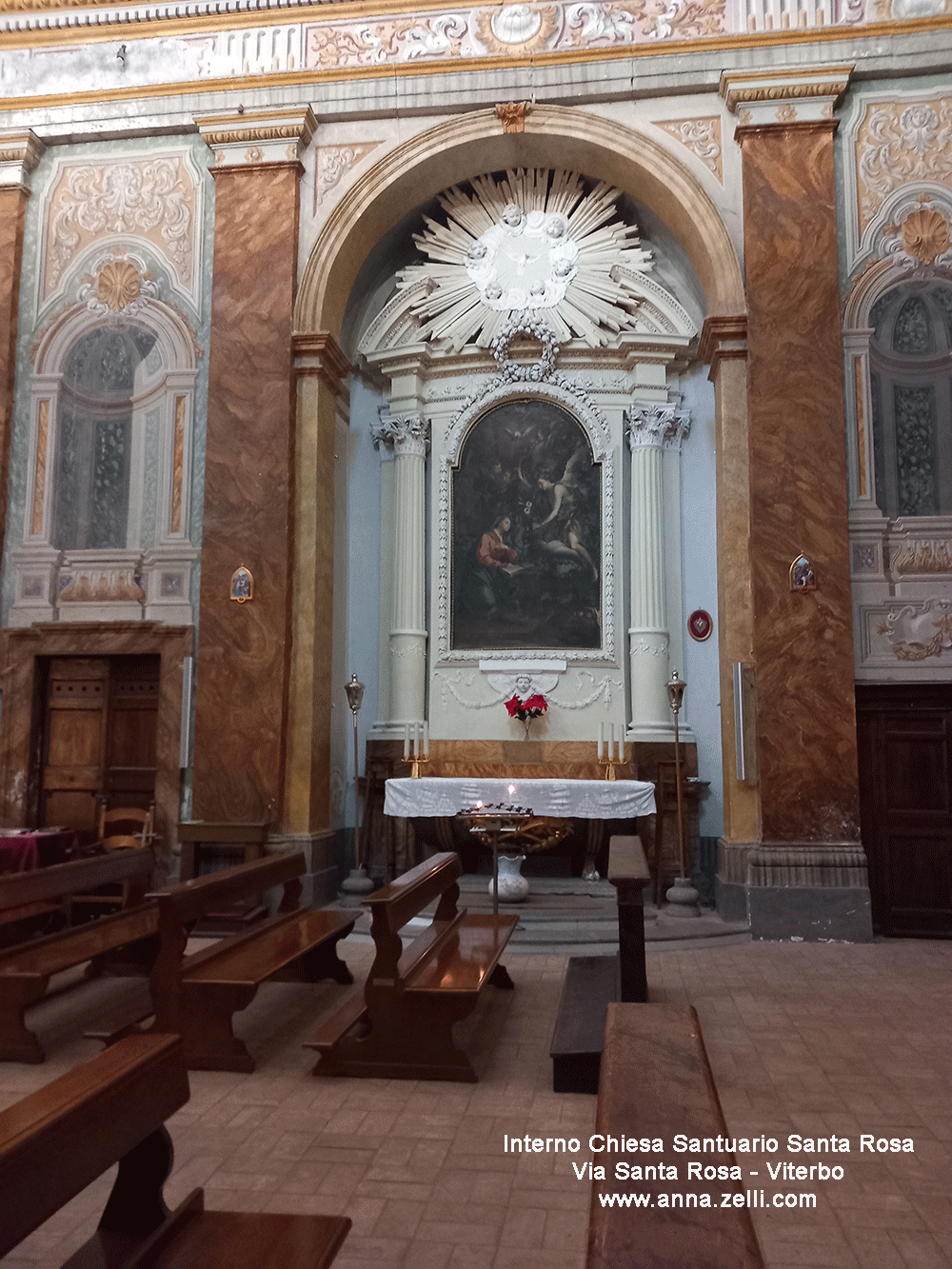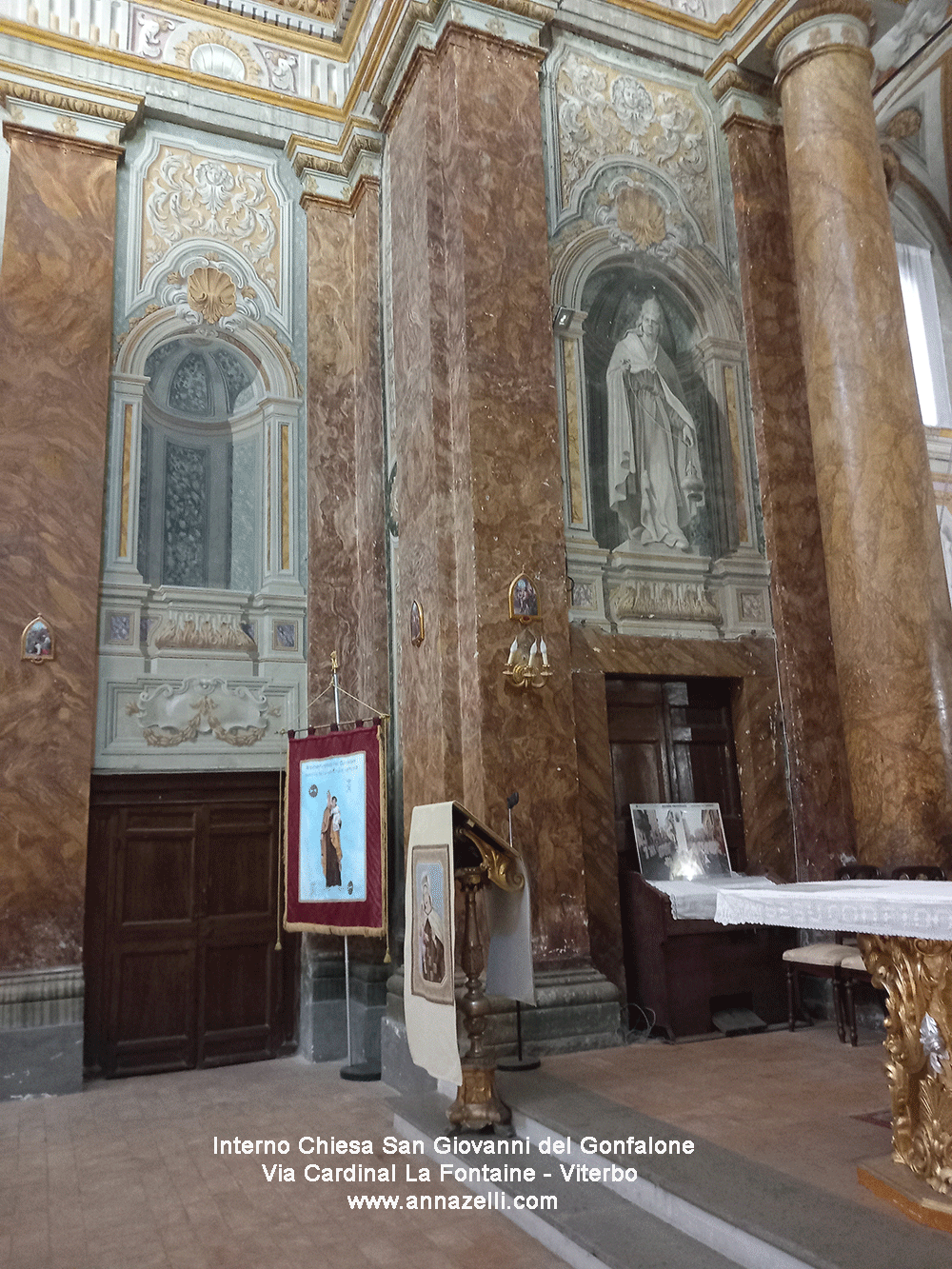|
Viterbo |
chiesa di san giovanni battista del gonfalone via cardinal la fontaine viterbo centro storico | ||||||||||||||||||||||
|
CHIESA DI SAN GIOVANNI DEL GONFALONE VIA LA FONTAINE |
|||||||||||||||||||||||
|
Chiesa di San Giovanni Battista del Gonfalone, via Cardinale La Fontaine, Viterbo, la chiesa fu voluta dalla Compagnia del Gonfalone, i quali custodivano il Gonfalone della città di Viterbo che si conservava nella antica e piccola chiesa di san Giovanni in Valle sotto il Colle del Duomo. Fu il Cardinale Francesco Maria Brancacci nel 1665 a benedire la posa in opera della prima pietra della nuova Chiesa ed Oratorio della Compagnia del Gonfalone. Da notare che durante le processioni non si utilizzava l’originale dello stendardo del Gonfalone ma copie. La chiesa in via La Fontaine, fu eretta tra il XVII e il XVIII secolo, è un esempio di barocco viterbese e fu voluta dalla Confraternita del Gonfalone, dalla quale ne ha preso il nome. Questa Confraternita era presente a Viterbo già dal XII secolo e si riuniva in una contrada in Valle, poi nel 1561 si unì alla congregazione Romana del Gonfalone, fondata da San Bonaventura da Bagnoregio, assumendone sia l’insegna che la divisa, un abito a forma di sacco bianco con cappuccio e cordone dello stesso colore e con una croce bianca e rossa in campo azzurro sulla spalla destra. La finalità della Confraternita era quella di raccogliere fondi sia per il riscatto dei cristiani tenuti prigionieri dai turchi che di poter dare una dote alle ragazze rimaste orfane e di buoni costumi. Poiché nel tempo l’oratorio in Valle era divenuto inadatto alle esigenze della Confraternita, nel 1664 acquistarono un terreno ove poter edificare una nuova chiesa. Nel 1664 la Congregazione acquistò un orto con casa e torracchio, a tale acquisto, contribuirono generosamente con 200 scudi gli eredi di Caterina Nini di Nino: i nobili Paluzo Paluzi e Decio Ancaiani. Anche la Confraternita fece quello che poté e vendette un orto che era annesso alla vecchia sede di San Giovanni in Valle, al vescovo Brancacci che lo incorporò al giardino del palazzo episcopale. In merito al torracchio o turraccio, la torre con abitazione annessa si possono notare nella Pianta di Viterbo del Ligustri (1596). Per l’edificazione della chiesa furono distrutti sia gli antichi edifici medioevali che e la torre. La prima pietra venne posta il 21 dicembre 1665 con la benedizione del Cardinale Francesco Maria Brancaccio. L’impianto venne affidato ad un allievo romano del Borromini, l’architetto Govanni Maria Baratta, ligure, che con il fratello Francesco era diventato l’architetto della famiglia Pamphili. Mentre tutte le opere vennero eseguite da mastri e muratori viterbesi, ed anche viterbesi furono gli artisti che decorarono l’interno della chiesa. Per completare la chiesa ci vollero sessanta anni, anche se dal XVII era già la sede dell’Oratorio dei Confratelli che ottennero il diritto di avere sepoltura in questo luogo. La facciata della chiesa è opera dell’architetto romano Francesco Ferruzzi, che ne ebbe l’incarico nel 1725, e l’anno successivo nel 1726, il prospetto venne completato, questa data è evidenziata dall’iscrizione sul cornicione del marcapiano. La facciata, a disegno leggermente concavo, è divisa in due ordini da un ampio mensolone, alle cui estremità sono poste due fiamme in forma di lampade. Nella parte inferiore si apre il portale, al quale si accede mediante otto gradini, con mostre in peperino, sormontato da due stemmi, il più grande dei quali ornato da festoni, raffigura l’arme di Benedetto XIII Orsini e l’altro quella del vescovo Sermattei; ai lati due costoloni in pietra ed altri angolari danno slancio al prospetto nel quale, nella parte superiore, si apre un finestrone tondo inserito in una cornice rettangolare. Anche nella parte alta si ripete il motivo decorativo a costoloni e sulla mensola di chiusura si levano quattro torcere, che simboleggiano la luce della fede. Sulle fiancate dei contrafforti sostengono la metà superiore dei muri. La facciata a due ordini è caratterizzata da lastre in peperino, e l’andamento concavo non si conclude con un timpano ma con una piccola cuspide quasi invisibile dal basso, con il corpo centrale a forma di trapezio e con i lati obliqui ad andamento curvo affiancati da leggere volute. Nel lato sinistro si eleva il campanile a pianta quadrata, inserito nel corpo della costruzione. All’interno della chiesa c’è un pregevole organo del settecento. Oggi la chiesa è custodita dagli Araldi di Maria della Arciconfraternita del Gonfalone Madonna del Carmelo, e quindi la chiesa è tornata a rivivere grazie alla loro disponibilità, tenendola aperta al pubblico con quello spirito che anima chi ama la Madonna e dona a Lei il proprio cuore "rosso" e sangue "blu", che sono i colori della Confraternita. Nella chiesa si venera la statua della Madonna del Carmelo che viene portata in processione nel mese di Luglio di ogni anno..La chiesa ha subito dei restauri nel 1836, di nuovo nel 1911 ad opera dell’imprenditore Giuseppe Coccia, e nel 1988 quando la Cassa di Risparmio di Viterbo ha finanziato il restauro della facciata., il 23 Settembre 1913, la chiesa è stata eretta come vice parrocchia della vicina Chiesa di santa Maria Nova. Il 27 Gennaio 1916 un decreto, a firma di Tommaso di Savoia, fece sì che la Confraternita del Gonfalone consegnasse tutto il patrimonio allo Stato, ciò fu causa della fine della Confraternita stessa. L’ultima riunione della Congregazione dei dodici avvenne il 27 Aprile 1958, e così si chiuse la storia della Confraternita del Gonfalone di Viterbo. Se si passeggia per il centro di Viterbo, si vedranno murate sulle facciate di diverse case, delle formelle della Confraternita del Gonfalone, molte delle quali sono da far risalire al 1764, quando nel Dicembre fu ordinato a Francesco Anselmi di far mettere gli stemmi su tutte le proprietà. Le formelle sono caratterizzate dalla croce della Confraternita e dalla figura di san Giovanni Battista, per lo più sono in peperino, poche in ceramica dipinta a colori.
Interno Chiesa S. Giovanni Interno della Chiesa del Gonfalone: via Cardinal La Fontaine, Viterbo, qui troviamo uno dei più stupefacenti e raffinati complessi della pittura barocca viterbese, quasi un museo che raccoglie la produzione dei maggiori artisti della città, realizzata nell’arco di un anno, dal settembre 1756 al febbraio 1757,riccamente decorato, secondo i canoni barocchi, con raffigurazioni simboliche, allegorie, figure di profeti ed episodi del Vangelo e le imponenti figure prospettiche realizzate da Giuseppe Marzetti, viterbese All’entrata della chiesa si può ammirare una grande bussola in legno di noce del XVIII secolo, che qui venne collocata nel 1883 e che proviene dalla vendita di oggetti appartenuti alla Chiesa di san Francesco alla Rocca, che in quel periodo era stata chiusa al culto. L’altare maggiore e il ciborio furono eseguiti nel 1747 su disegno dell’architetto romano Niccolò Salvi, progettista della Fontana di Trevi in Roma. Fu incaricato dell’esecuzione lo scalpellino Pier Francesco Giorgioli che, per scarsezza di fondi, fu costretto a sostituire alcune parti in marmo, previste nel progetto, con il ben più economico peperino. Ai lati dell’altare maggiore sono due figure allegoriche di Sebastiano Carelli di Montefiascone eseguito nel 1772 che rappresentano la Scienza e la Religione. La chiesa internamente è divisa dalle due colonne poste sull’altare maggiore in due sezioni, una zona riservata ai fedeli e l’altra ai confratelli dell’Oratorio. Sull’entrata nella lunetta sopra l’organo, si ammira la Decapitazione del Battista, affrescata nello stesso anno dal Corvi. L’altare del 1746 opera dell’architetto Nicola Salvi, progettista della Fontana di Trevi a Roma e autore dei rifacimenti della chiesa e del convento di S. Maria in Gradi; il paliotto di marmo venato giallo con fascia di contorno in marmo verde e rosso reca al centro il simbolo della Confraternita; il Ciborio con colonnine marmoree termina in una cuspide su cui poggia la Croce. Sul primo altare a destra ci sono due statue in stile barocco, processionali, della Passione e nella cappella sopra l’altare in stucco e pietra di Domenico Lucchi, c’è la pala con San Bonaventura che scrive ispirato dallo Spirito Santo del sec. XVIII. Nelle due finte nicchie ai lati dell’altare maggiore, Sebastiano Carelli di Montefiascone ha dipinto nel 1772 due figure monocrome raffiguranti la Scienza e la Religione. Nella lunetta dell’altare maggiore San Giovanni Battista davanti a Erode, opera del 1756 di un altro artista viterbese, Anton Angelo Falaschi. Il coro ligneo è opera del viterbese Carlantonio Morini, sopra, sulle pareti, tra motivi decorativi monocromi del maestro romano Pietro Piazza vi è una serie di sei riquadri in chiaroscuro dipinti nel 1747 ancora da Pietro Piazza e dal conterraneo Giuseppe Rosa con episodi della vita del Battista: da sinistra: L’Angelo e Zaccaria, Giovanni nel deserto, Dio gli ordina la missione, rimprovera Erode, l’Agnello di Dio, e la Decapitazione. Sulla lunetta dell’abside vi è la raffigurazione dell’Onnipotente probabilmente opera di Giuseppe Rosa. All’interno vi è un dipinto che raffigura la morte di Sant’Anna del XVII secolo, che era già nella chiesa di San Silvestro. In un altare vi è la Madonna Annunziata del XVIII secolo realizzato da Domenico Lucchi, mentre in una delle cappelle vi è un crocefisso in legno dipinto, di datazione incerta.Sul soffitto a volta Vincenzo Stringelli, viterbese, nel 1758 ha affrescato con il tema dell’Empireo grandiosa figurazione con gruppi di angeli e beati, sorretti da nuvole, protesi verso la luce celeste. Giuseppe Rosa ha dipinto a monocromo le vele, i riquadri angolari del soffitto, i lati delle lunette raffigurandovi angeli e figure simboliche sorrette da nubi, puttini in volo; nel grande affresco della volta ha raffigurato con vivace vena coloristica la Nascita del Battista e, nella lunetta verso l’altare, una affollata scena con la Predicazione di S. Giovanni.
Pavimento Chiesa
Pavimento Chiesa San Pavimento Chiesa del Gonfalone, Viterbo, Il pavimento della chiesa fu rinnovato agli inizi del 1915, furono tolti i mattoni di terracotta, sostituendoli con mattonelle bianche e nere in granito di cemento, lo stesso fu fatto per i gradini degli altari. Nel 1916, venne murato nel piccolo orto , presso la sacrestia, il coperchio della sepoltura dei confratelli che era sul pavimento della chiesa. Poi, nel 2000 il piancito è stato rifatto totalmente apponendovi di nuovo mattoni in cotto lavorati a mano, che hanno ridato di nuovo alla chiesa l’aspetto d’una volta, ed inoltre è stato ricollocato al suo posto il coperchio della sepoltura della Confraternita. Sulla pietra è scolpita la croce uncinata del Gonfalone con agli angoli dei fiori, un mattone, murato sul pavimento, nella parte alta del coperchio, porta incisa la data 1691. Oratorio, Chiesa de Gonfalone, Viterbo, qui campeggia il grande Stendardo della Confraternita, dipinto su entrambe le facciate dal viterbese Giovan Francesco Romanelli, il pittore del Re Sole, che vi ha raffigurato il Battesimo di Cristo e la Madonna della Misericordia, databile 1649. Le pitture monocrome dell’oratorio sono dei romani Giuseppe Rosa e Pietro Piazza databili nel 1747 con raffiguranti la vita del Battista. Il coro ligneo è del viterbese Carlantonio Morini è del 1834. Nell’Oratorio, dietro all’altare maggiore, si poteva ammirare, appeso ad un tirante, lo Stendardo della Confraternita del Gonfalone, che è stato terminato di restaurare nel 1998. Proveniente dalla antica residenza di san Giovanni in Valle è dipinto su entrambe le facciate e raffigura il Battesimo di Cristo e la Madonna della Misericordia con san Bonaventura, opera eseguita nel 1649 dal viterbese Giovan Francesco Romanelli (1610 - 1662), il pittore del Re Sole. Sembra, che il valente pittore, per realizzare questo lavoro, si sia servito del cartone già usato per la esecuzione degli arazzi di Palazzo Barberini, raffiguranti momenti di vita del Cristo (1643 - 1646). Lo stendardo è stato restaurato nel 1824 dal pittore viterbese Angelo Papini e nel 2001 dal Laboratorio di restauro per la Provincia di Viterbo. Copia dello stendardo fu eseguita dal pittore viterbese Francesco Ciaci nel 1664, che risulta la prima in ordine di tempo, poi ne fu commissionata un’altra al pittore romano Pietro Paolo Panci nel 1770, il quale fu incaricato in sostituzione del viterbese Michelangelo Benedetti. Nel 1829, durante la processione del Corpus Domini, fu portata per le vie della città la copia dello stendardo eseguita nello stesso anno dall’artista Domenico Costa, viterbese.E’ curiosa la riproduzione in pittura di una sassata che infrange i vetri sulla finta finestra, la prima a destra. Sul fondo dell’Oratorio è, appesa alla parete, la copia dello stendardo di Romanelli che fu eseguita, nel 1901, dal concittadino Enrico Canevari (1861 - 1947), preferito a Pietro Vanni, il quale chiedeva un maggior compenso; è questo l’ultimo stendardo della Confraternita. Nel 1895 Canevari aveva decorato anche le pareti rimaste prive di pittura. Alla sinistra dello stendardo è un’epigrafe in marmo sagomato, con borchie in ottone e con lo stemma della Confraternita a colori, che riferisce: Ai fratelli / ai figli di fratelli / caduti per la Patria / negli anni di guerra / MCMXV MCMXVIII / F.llo Emilio Bianchi / decorato con medaglia d’oro / Giuseppe Grazini / Celestino Tamantini / Giovanni Ranocchiari / Egisto Monarchi / Romolo Merlani / Luigi Mecarini / Antonio Mecarini / Francesco e Domenico Duri del F.llo Raimondo / Aurelio Masini del F.llo Paolo / Pietro Bruni del F.llo Francesco / Ugo Lupi Aldo Lupi} del F.llo Enrico / gloria perenne e pace in Cristo / i confratelli i genitori / p.p. Nel soffitto dell’Oratorio è affrescata la Natività di san Giovanni Battista, opera del romano Giuseppe Rosi eseguita verso il 1747, dopo aver terminato l’altare maggiore, quando era vescovo della città Alessandro Abati (1731 - 1748) del quale si vede lo stemma. Il pittore eseguì in monocromia le vele, i riquadri angolari del soffitto, i lati delle lunette raffigurandovi angeli e figure simboliche sulle nubi e puttini volteggianti Ciborio Chiesa del Gonfalone, via Cardinal La Fontaine, Viterbo,Nel 1839 fu rinnovato conservando la mensa, il paliotto ed il ciborio, il disegno fu eseguito dall’architetto viterbese Vincenzo Federici. Nel 2000 l’altare è stato riportato come lo aveva progettato il Salvi, ossia è stato demolito il fronte che fiancheggiava il ciborio, consentendo così una maggiore visione dello stendardo del Romanelli nel coro. Il paliotto è in marmo venato giallo con una fascia a cornice in marmo rosso e verde, mostra al centro, il simbolo della Confraternita del Gonfalone. Il ciborio caratterizzato da colonnine marmoree termina a cuspide da cui si innalza la croce. La consulenza per i colori fu affidata a Domenico Costa (1786 - 1856) già autore di un nuovo stendardo nel 1829, come riferisco appresso, e di una Macchina di santa Rosa. Il 18 Febbraio 1736 Giuseppe Rapaccioli decorò l’Altare dell’Annunziata. Coro Chiesa del Gonfalone, via Cardinal La Fontaine, Viterbo,il Coro in legno è stato eseguito dal falegname - ebanista viterbese Carlo Antonio Morini, nel 1833 - 1834, il quale aveva la bottega in Via del Melangolo e fu autore di una cronaca locale manoscritta che intitolò Straccifojo. A sinistra è la Tribuna del coro con lo stemma coronato in oro della Confraternita sull’alto dell’alzata, la croce col braccio verticale di rosso, quello orizzontale di bianco su fondo azzurro, e un calice con l’ostia sul fronte della balaustra Sacrestia Chiesa del Gonfalone, via Cardinal La Fontaine, Viterbo,Nel 1843 fu sopraelevata la sacrestia per ricavarne un’ampia stanza, illuminata da una finestra, ove si tenevano le riunioni della Confraternita, l’accoglienza per i celebranti nelle festività e la conservazione dei documenti d’archivio
Organo Chiesa San Giovanni Organo Chiesa del Gonfalone, via Cardinal La Fontaine, Viterbo,Sopra alla porta d’accesso alla chiesa, nella cantoria, è l’organo eseguito e montato nel 1772 da Nicola Raimondi da Todi, infatti, vi è la scritta:Nicolaus Raimundi de Tuderto fecit anno Domini 1772. Si presenta a cassa indipendente con facciata a cuspide centrale. Il vecchio organo fu venduto nel 1770 al canonico Giovan Battista Garofolini il quale, ancora nel 1773, non aveva terminato di pagarlo alla Confraternita del Gonfalone. Sopra all’organo, nella controfacciata, vi è una grande lunetta raffigurante il Carcere e la decollazione di san Giovanni Battista, lavoro in affresco del viterbese Domenico Corvi eseguito tra la fine del 1756 ed inizio 1757, a lui si deve la realizzazione dei medaglioni sorretti da due angeli con raffigurati i profeti Abdia, sulla parete di sinistra, e Isaia su quella di destra.
Campanile Chiesa San Campanile Chiesa del Gonfalone, il campanile si vede da via del Gonfalone, e da via San Carluccio, Viterbo, alla destra della chiesa,è un campanile a torre, a pianta quadrata, con due campane delle quali la più grande fu eseguita da Luigi Belli nel 1823, infatti fu rifusa in quell’anno una più vecchia che sin dal 1821 era inservibile, vi è scritto:D.O.M. deiparae Virgini atque patrono nostro Joanni Baptista dicatum / anno MDCCCXXIII. Nel 1941 le campane erano tre. Nel 2000 - 2001 venne restauro il campanile perché pericolante; e din quella occasione è stato anche eseguito l’impianto di riscaldamento della chiesa..
Scalinata Chiesa San Scalinata Chiesa del Gonfalone, via Cardinal La Fontaine, Viterbo,Nella parte inferiore si apre il portale, al quale si accede mediante otto gradini, con mostre in peperino, sormontato da due stemmi, il più grande dei quali ornato da festoni, raffigura l’arme di Benedetto XIII e l’altro quella del vescovo Sermattei
Stemmi Chiesa San Stemmi Chiesa del Gonfalone,via Cardinal La Fontaine, Viterbo, il portale è sormontato da due stemmi, il più grande dei quali ornato da festoni, raffigura l’arme di Benedetto XIII e l’altro quella del vescovo Sermattei. Arcionfraternita del Gonfalone onfraternita del GonfaloneConfraternita del Gonfalone, Viterbo, la Chiesa di san Giovanni Battista del Gonfalone,in via Cardinal La Fontaine, è da considerare come l’esempio del barocco a Viterbo. Venne costruita per volontà della Confraternita del Gonfalone, che era una delle più importanti tra le varie Confraternite presenti a Viterbo, sia per i suoi vasti possedimenti che per il numero di confratelli facoltosi. In origine si chiamò Confraternita di San Giovanni Battista che dal XII secolo aveva la propria sede a valle Faul, presso un oratorio. Nel 1561 si aggregò a loro la Confraternita del Gonfalone di Roma che era stata fondata nel 1264 da San Bonaventura da Bagnoregio. La Confraternita viterbese ne assunse il nome, l’insegna e la divisa. L’abbigliamento era costituito da un sacco bianco con un cappuccio ed un cordone dello stesso colore e da una croce bianca e rossa in campo azzurro posta sulla spalla destra. Il fine era quello di riscattare attraverso le elemosine i cristiani prigionieri dei turchi, di visitare le persone malate e di occuparsi della dote per due fanciulle orfane e di sani principi. Nel 1581 si unì a loro la Confraternita della Misericordia, ormai ridotta nel numero dei confratelli, che aveva la sua sede nella Chiesa di Santa Maria della Carbonara San Giovanni Battista San Giovanni, detto il Battista, vita opere storia, a Viterbo gli è dedicata la chiesa di San Giovanni Battista del Gonfalone, su via La Fontaine, fu il primo Apostolo di Gesù e l’ultimo profeta dell’Antico Testamento. Il nome Giovanni in ebraico Iehóhanan significa: “Giovanni il Precursore”,riconosciuto come il più grande dei Profeti, nacque ad Ain Karim, tra il 29 e il 32 , un villaggio vicino a Gerusalemme, è stato un asceta proveniente da una storica famiglia sacerdotale ebraica. Ad Ain Karim, esistono due santuari del VI secolo uno dedicato alla Visitazione e l’altro alla Natività. La madre di Giovanni, Elisabetta discendeva da Aronne, era moglie di Zaccaria, sacerdote della classe di Abia. I due coniugi erano ormai di età avanzata quando Zaccaria, mentre svolgeva il suo servizio nel Tempio di Gerusalemme, ebbe la visione di un angelo che gli annunciò la prossima nascita di un figlio, fino a quel momento non ne avevano avuti. Poiché Zaccaria non gli credette perché la moglie Elisabetta era gia anziana, l'angelo lo fece diventare muto fino a che il suo annuncio non si fosse adempiuto. Zaccaria riacquistò la parola solo dopo che il bambino fu nato e, durante il rito della circoncisione, gli fu imposto il nome di Giovanni, come l'angelo aveva ordinato. Al sesto mese di gravidanza, Elisabetta ricevette la visita di Maria, che nel corso dell'Annunciazione era stata avvertita che anche la sua parente era incinta. All'udire il saluto di Maria, Elisabetta "fu piena di Spirito Santo" e riconobbe Maria come la madre del Salvatore. Maria rispose intonando l'inno del Magnificat. Questo episodio è ricordato nella dottrina cristiana come la "Visitazione". la Chiesa Ortodossa venera Elisabetta e Maria come figlie di sorelle, Esmerìa ed Anna, e quindi Giovanni Battista come cugino di secondo grado di Gesù. L’immagine di San Giovanni è stata lungamente rappresentata ed è presente in moltissime chiese con una pelle di animale ed un bastone a forma di croce. La sua vita viene raccontata nel Vangelo di Luca, crebbe retto e pio come lo erano stati i suoi avi sacerdoti, già carico di responsabilità che gli derivavano dalle parole profetiche dell'Arcangelo Gabriele quando descrisse le sue virtù, del suo essere "pieno di Spirito Santo", operatore di conversioni in Israele, precursore del Signore con lo spirito e la forza di Elia. Quando fu adulto Giovanni, conscio della sua missione, si ritirò a condurre la dura vita dell’asceta nel deserto: portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi e il suo cibo erano cavallette e miele selvatico.,Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio (28-29 d.C.), iniziò la sua missione lungo il fiume Giordano; con l’annuncio dell’avvento del regno messianico ormai vicino, esortava alla conversione e predicava la penitenza. Andavano ad ascoltarlo da tutta la regione del Giordano, dalla Giudea e da Gerusalemme, era considerato un profeta, e per liberare le persone dai peccati, in segno di purificazione e di rinascita, le immergeva nelle acque del fiume. Per questo Giovanni è chiamato anche il Battista, ovvero colui che battezza. Anche i soldati del Re Antipa andavano da Giovanni a chiedere consiglio, e molti pensavano che fosse lui il Messia, ma lui rispondeva che era solo un Precursore, che il Messia era già in mezzo a loro, ma non era lui. Quando Gesù si fece battezzare da Giovanni. in tale occasione egli additò Gesù ai suoi seguaci come "l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo" (Vangelo secondo Giovanni 1, 29). Nello stesso tempo, dal cielo si udì una voce: “questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto: ascoltatelo!” (Marco 1:1-8) Gesù nel frattempo aveva iniziato la sua predicazione: aveva formato il gruppo degli apostoli e discepoli ed era seguito da una gran folla e Giovanni, che aveva predicato proprio per preparare un popolo degno, che accogliesse Gesù e il suo messaggio di Redenzione, confidava ai suoi discepoli “Ora la mia gioia è completa. Egli deve crescere e io invece diminuire”, sottintendendo con ciò la fine della sua missione. In quel tempo governava in Israele il re Erode Antipa il quale conviveva con la moglie divorziata da suo fratello, la bella Erodiade, vivendo in aperto contrasto con la legge ebraica, perchè per il Libro Sacro, la “Torah”, il divorzio di Erodiade non era ammissibile dato che dal matrimonio era nata una figlia, Salomè. Giovanni rimproverava il Re per questo scandalo pubblico e per la sua condotta e soprattutto si inimicò Erodiade la sua concubina che voleva Giovanni morto. Erode lo fece arrestare ma lo teneva in buona considerazione, vigilando su lui e ascoltando le sue parole, considerandolo uomo giusto e santo. Un giorno, il re per festeggiare il suo compleanno diede un banchetto invitando tutte le persone più importanti della Galilea, in quella occasione Erodiade fece ballare Salomè, la figlia, la sua esibizione piacque molto al re ed ai commensali, per cui disse alla ragazza: “Chiedimi qualsiasi cosa e io te la darò”. La giovane Salomé chiese consiglio alla madre che, non aspettava altro, e le suggerì di chiedere la testa del Battista. Erode si rattristò a questa richiesta, ma per il giuramento fatto davanti a tutti non potè rifiutare e ordinò alle guardie che gli fosse portata la testa di Giovanni. Il Battista fu decapitato e la sua testa fu portata su un vassoio e data alla ragazza che la diede alla madre soddisfatta della sua vendetta. I discepoli di Giovanni, saputo del martirio, recuperarono il corpo, lo deposero in un sepolcro che divenne oggetto di pellegrinaggio. . Per via della decapitazione è conosciuto anche come San Giovanni Decollato.Il suo culto si diffuse in tutto il mondo conosciuto di allora, sia in Oriente che in Occidente e a partire dalla Palestina si eressero innumerevoli Chiese e Battisteri a lui dedicati anche Gesù lo aveva definito, il più Grande. La Chiesa lo ricorda nella liturgia insieme a Maria sia nel giorno della morte il 29 Agosto che in quello della nascita il 24 giugno . Si discute molto sui possibili rapporti fra il Battista e la comunità giudaica degli Esseni, che vivevano in comunità monastiche nel deserto, aspettavano l'avvento del Messia e praticavano il battesimo come rito di purificazione. La novità del battesimo di Giovanni, rispetto alle abluzioni di tipo rituale che già si conoscevano nella tradizione giudaica, consisteva nel preciso impegno di "conversione", da parte di coloro che andavano a farsi battezzare da lui. Secondo alcuni vangeli apocrifi, in seguito alla morte della madre si sarebbe recato nel deserto dove fu ispirato dagli angeli e uomini sapienti per la sua futura missione. Inoltre, L'unico luogo in cui si celebra un'apparizione di San Giovanni Battista, la seconda domenica di maggio, è la cittadina fluviale di Pontecorvo in provincia di Frosinone, in ricordo del miracoloso intervento di San Giovanni Battista in favore di un giovane contadino. Secondo la tradizione, il 14 aprile del 1137 Giovanni Mele, intento a lavorare il suo fondo sulla sponda sinistra del fiume Liri, fu tentato dal demonio. Seduto sulla sponda opposta, il diavolo, nelle sembianze di un nobile signore vestito elegantemente, offrì all'ingenuo villico una borsa (o, secondo altra versione, una coppa d'argento) piena di monete d'oro, invitandolo ad attraversare il fiume perché potesse prenderla. Il contadino, vinto dal desiderio di tanta ricchezza, che lo avrebbe affrancato per sempre dal duro lavoro dei campi, tentò di attraversare il fiume. Giunto però nel mezzo, dove l'acqua era più profonda, iniziò ad annegare. Sul punto di soccombere, si rivolse allora a San Giovanni Battista per essere salvato. Il santo ascoltò la supplica e apparve al giovane, che fu preso per una mano e tratto in salvo dalle acque del Liri. Nella tradizione popolare pontecorvese Giovanni Mele diventa per contrazione Camele e ancora oggi "camele" è epiteto vernacolare per indicare persona ingenua e credula. San Giovanni Battista, è il protettore, per via dell'abito di pelle di dromedario, che si cuciva da sé e della cintura, di sarti, pellicciai, conciatori di pelli; per l'agnello, dei cardatori di lana; per il banchetto di Erode che fu causa della sua morte, è patrono degli albergatori; er la spada del supplizio, di fabbricanti di coltelli, spade, forbici; per l'inno liturgico patrono dei cantori. In quanto colui che battezza, è protettore dei trovatelli, che venivano abbandonati alle porte dei battisteri. Inoltre con il titolo di San Giovanni Decollato, è protettore delle confraternite che assistevano i condannati a morte, e protettore dei santi martiri decollati. Viene anche invocato, contro le calamità naturali quali terremoti, È anche patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta Fotografie Chiesa San Giovanni Battista del Gonfalone via Cardinal Pietro La Fontaine Viterbo Chiesa S.Giovanni Battista Gonfalone -Via Cardinal La Fontaine Viterbo - via Cardinal la Fontaine Facciata Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo, via Cardinal la Fontaine Facciata Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo, via Cardinal la Fontaine Campanile Chiesa San Giovanni Battista detta del Gonfalone Campanile Chiesa San Giovanni Battista detta del Gonfalone, Viterbo - via Cardinal la Fontaine Campanile Chiesa San Giovanni Battista detta del Gonfalone Viterbovia Cardinal la Fontaine - Scalinata Chiesa San Giovanni Battista del Gonfalone Viterbo Scalinata Chiesa San Giovanni Battista del Gonfalone - Viterbo - via Cardinal la FontaineStemmi facciata Chiesa San Giovanni del Gonfalone Viterbo Stemmi facciata Chiesa San Giovanni Battista del Gonfalone - Viterbo via Cardinal la FontaineAltare Maggiore Chiesa San Giovanni Battista del Gonfalone Viterbo Interno Chiesa del Gonfalone via Cardinal La Fontaine Viterbo Madonna con Bambino Chiesa del Gonfalone via Cardinal la FontaineViterbo Interno Chiesa del Gonfalone, Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo - via Cardinal la Fontaine Interno Chiesa del Gonfalone, Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo - via Cardinal la Fontaine Interno Chiesa del Gonfalone, Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo - via Cardinal la Fontaine Interno Chiesa del Gonfalone, Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo - via Cardinal la Fontaine Interno Chiesa del Gonfalone, Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo - via Cardinal la Fontaine Organo Chiesa San Giovanni Battista del Gonfalone Viterbo Organo Chiesa del Gonfalone, Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo - via Cardinal la Fontaine Organo Chiesa del Gonfalone, Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo - via Cardinal la Fontaine Volta Soffitto Chiesa San Giovanni Battista del Gonfalone Viterbo Volta soffitto Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo, via Cardinal la Fontaine Volta soffitto Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo, via Cardinal la Fontaine Volta soffitto Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo, via Cardinal la Fontaine Volta soffitto Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo, via Cardinal la Fontaine Volta soffitto Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo, via Cardinal la Fontaine Pavimento Chiesa San Giovanni del Gonfalone Pavimento Chiesa San Giovanni Battista, Viterbo, via Cardinal la Fontaine Il Gonfalone Chiesa di San Giovanni Battista del Gonfalone Gonfalone Chiesa San Giovanni Battista, via Cardinal la Fontaine Viterbo, info e foto Anna Zelli Arciconfraternita del Gonfalone Arciconfraternita del Gonfalone - via Cardinal la Fontaine - ViterboSan Giovanni Battista storia vita opere Da vedere alla chiesa di San Giovanni Battista del Gonfalone Viterbo
Fotografie informazioni turistiche via Cardinal La Fontaine Viterbo Mappa piazza S. Lorenzo - Mappa via S. Lorenzo - San Pellegrino
Vedi Piazze di Viterbo - Vie di Viterbo centro storico Piazze di Viterbo centro - Vie di Viterbo centro
Viterbo centro storico -
Viterbo dintorni
Viterbo guida centro storico - Viterbo dintorni Copyright dal 2011
Tutte le foto
ed i contenuti del presente sito web
sono di Anna Zelli,sono di
Informazioni Turistiche
città di
Viterbo monumenti di Viterbo centro storico Viterbo centro storico - Viterbo dintorni 
Viterbo guida centro storico - Viterbo dintorni
|
||||||||||||||||||||||
|
Città di Viterbo |
informazioni storico turistiche e fotografie della città di Viterbo a cura di Anna Zelli |












.gif)

.gif)