VIA GIULIA E DINTORNI GUIDA TURISTICA ROMA INFORMAZIONI STORICHE ARTISTICHE TURISTICHE FOTO ANNA ZELLI www.annazelli.com
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
via giulia e dintorni guida turistica di roma informazioni storiche artistiche turistiche foto a cura di anna zelli Guida Turistica di Roma Informazioni Storiche Artistiche Turistiche Culturali Foto di Roma Arte Cultura Novità Idee sito web di informazione culturale artistico turistica di Roma Via Giulia e dintorni (Roma) Via Giulia e dintorni, la via fa parte del rione Ponte e rione Regola, Roma, va da piazza San Vincenzo Pallotti a piazza dell'Oro, è una delle strade più lunghe di Roma, oltre 1 chilometro, con un tracciato rettilineo, questa strada deve il suo nome a Papa Giulio II della Rovere al soglio dal 1503 al 1513, ideatore del piano urbanistico che, a maggior gloria della Chiesa cattolica, avrebbe trasformato la Roma medioevale in una città più moderna caratterizzata da ampi viali diritti. Via Giulia fu progettata per permettere ai pellegrini di raggiungere San Pietro, senza smarrirsi in un dedalo di viuzze secondarie e presto divenne, ed è tuttora, la strada più prestigiosa di Roma. Il progettista fu Bramante, è fiancheggiata da Palazzi aristocratici datati dal XVI al XVII secolo. E' ricca di chiese. Ci sono negozi di antiquariato. E' una via affascinante per una bella passeggiata piena di splendore e storia. La via prima della urbanizzazione di papa Giulio II si chiamava via Magistralis, perché era una via importante, una via maestra, anche se tortuosa e fangosa, denominata anche "mercatoria" perché collegava la zona da piazza di Ponte Sant'Angelo ai mercati di Campo de' Fiori e di piazza Navona. La via era in origine tortuosa e venne raddrizzata e per questo venne chiamata via Recta. Ai due estremi di via Giulia fino al secolo XIV vi si erano stabilite alcune colonie di persone provenienti dalla Toscana, specialmente da Siena, poi la zona venne abbandonata ma rimase la chiesa che i senesi eressero nel 1526 alla loro patrona e santa, Santa Caterina da Siena, la chiesa ebbe anche il nome "in castrum" che significava accampamento militare per via delle torri che davano alla contrada l'aspetto di cittadella fortificata Fu il Bramante che raddrizzò la via originaria e per farlo abbattè gli edifici sulla destra e la sinistra della via, meritandosi il soprannome di "Maestro Ruinante". Qui si sarebbero dovuti edificare i tribunali e gli uffici annessi, ma vennero gettate solo le fondamenta in grosso bugnato sporgente, visibili ancora oggi e chiamati i sofà di via Giulia, l'opera rimase incompiuta per la morte del Papa Giulio II e del Bramante. Con Papa Innocenzo XII verrà edificato il palazzo di Montecitorio che fu adibito a palazzo Giustizia allora mancante a Roma. La via Giulia è tagliata a metà dall'Arco dei Farnesi. Sulla via vi sono numerosi palazzi storici, al 93 si trova la casa dei Farnese ornata di grifi in stucco e dell'arme di papa Paolo III, al numero 85 vi è la casa di Raffaello ma l'artista non vi abitò mai, al numero 52 vi è il fabbricato delle Carceri Nuove. Cosa c'è da vedere nella zona di Via Giulia e dintorni:
Chiese Arciconfraternite Oratori e
Templi:
Chiesa Orazione e Morte, Chiesa San
Biagio della Pagnotta, Chiesa San Filippo Neri, Chiesa Spirito Santo
Napoletani, Chiesa S. Francesco demolita, Chiesa Santa Maria del
Suffragio, Chiesa S. Caterina Siena via Giulia, Chiesa S. Salvatore
in Onda, Chiesa Santa Brigida, Chiesa S, Maria di Monserrato, Chiesa
S. Anna dei Parafrenieri,, Chiesa S. Girolamo Carità, Chiesa S.
Eligio degli Orefici, Chiesa SS Evangelista e Petronio, Basilica S.
Giovanni dei Fiorentini, Chiesa S, Giovanni in Ayno, Chiesa S.
Caterina della Rota, Arciconfraternita dei Pallottini, Oratorio del
Gonfalone. Da vedere a via Giulia e dintorni (Roma) Arco dei Farnese detto anche ponte di Michelangelo, via Giulia, rione Ponte e rione Regola, Roma, era una sorta di ponte mai costruito che avrebbe dovuto unire il palazzo Farnese al palazzo della Farnesina al di là del Tevere. Il ponte di Michelangelo, doveva sorgere a via Giulia, ma non fu mai costruito, oggi si vede solo l'arco dei Farnese, che era la prima arcata del ponte. Il ponte di Michelangelo è un ponte non finito, è rimasto nella sua fase iniziale, l'ideatore fu Michelangelo, e nella sua idea doveva essere un vero e proprio ponte, che avrebbe congiunto palazzo Farnese con i giardini che i Farnese possedevano sull'altra sponda del Tevere, che oggi si chiama la Farnesina, e se fosse stato finito, sarebbe stato un ponte grandioso per chi veniva da Campo de Fiori. Ma purtroppo il ponte venne costruito solo per il primo tratto, nel 1603, ed è l'arco che oggi si vede a via Giulia. Il ponte non venne terminato per la morte di Michelangelo. La sovrintendenza architettonica passò al Vignola e a Gicomo della Porta, ma il ponte comportava una spesa enorme, ed i Farnese avevano già speso molto per costruire e decorare il palazzo, che oggi si chiama palazzo Farnese nella omonima piazza, ed il problema economico venne aggravato da un terribile incendio del 1612, che distrusse librerie ed archivi preziosissimi, per cui non si pensò più a costruire il ponte di Michelangelo, ma solo a sistemare l'arco. A questo si aggiunse anche l'estinzione dei Farnese nel 1731 ed il passaggio del palazzo ai Borboni di Napoli, con la conseguente perdita di tutte le opere d'arte trasportate a Napoli, compreso il "Toro dei Farnese", alla fine il palazzo fu ceduto alla Francia, venne riscattato dal Governo Italiano, ed oggi vi è la sede di rappresentanza diplomatica dell'Ambasciata di Francia che paga un affitto simbolico. Pertanto del grandioso progetto di Michelangelo, rimane solo un arco a ricordo. Vedi anche via Giulia e dintorni. Vedi ponte di Michelangelo. Fontana del Mascherone a Via Giulia rione Ponte e rione Regola, Roma, si trova addossata ad un muro che separa via Giulia dal Lungotevere, forse venne realizzata nel XVII secolo da Girolamo Rainaldi su commissione dei Farnese, il quale realizzò anche le due fontane gemelle di piazza Farnese. La fontana è alimentata dall'acqua Paola ed è formata da una antica vasca termale in granito, collocata al centro di un bacino leggermente incassato nel livello stradale e lastricato con frammenti di marmi policromi. Il fondale della vasca è costituito da un prospetto marmoreo, coronato da un giglio in metallo simbolo dei Farnese, al centro si trova un antico mascherone di epoca romana con gli occhi sbarrati che versa l’acqua nella sottostante vasca rettangolare di porfido anche questa di epoca romana. In occasione delle innumerevoli e sontuosissime feste che in passato si tenevano a via Giulia, la fontana è ricordata per aver riversato vino per 3 giorni, in onore del Gran Maestro di Malta Zondari. I Sofà di Via Giulia si trovano ad angolo con la via del Gonfalone, rione Ponte e rione Regola, Roma, sono dei grossi blocchi di travertino grezzo che sporgono dagli edifici sul lato destro della strada: è quanto resta dell’incompiuto Palazzo dei Tribunali, progettato dal Bramante per Papa Giulio II. Curia Julia, incompiuta, via Giulia, rione Ponte e rione Regola, Roma, nel 1540 la costruzione venne adibita a teatro gestito dalla Accademia degli Intrepidi e poi dalla Accademia dei Desiosi, verso la fontana del Mascherone c'era anche un altro teatro in una zona chiamata del Carbone. Chiesa Santa Maria dell'Orazione e Morte, via Giulia, rione Regola, Roma, si trova tra l'Arco dei Farnese e il Palazzo Falconieri, la chiesa risale al XVI secolo quando fu fondata una congregazione incaricata di raccogliere i corpi degli sconosciuti e di dare loro una degna sepoltura, il tema della morte è legato a questa chiesa Le porte e le finestre della facciata sono di Ferdinando Fuga e sono decorate con teschi alati, sull'ingresso principale c'è una clessidra simbolo del tempo che passa e della morte, e una cassetta delle elemosine con uno scheletro con le ali. Questa chiesa e l'annesso oratorio furono nel 1573 eretti dalla confraternita di Santa Maria dell'Orazione e Morte. Poiché era troppo piccola, venne riedificata nel 1737 da Ferdinando Fuga e consacrata sotto i titoli del SS. Crocifisso e della Beata Vergine da Cristoforo d'Almeida, arcivescovo di Perge, il 20 ottobre 1738. L'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte aveva come scopo quello di dare sepoltura ai morti, trovati in campagna o annegati nel Tevere, senza identità o comunque che non potevano ricevere degne esequie. Oltre alla chiesa, vennero costruiti anche un oratorio e un vasto cimitero, in parte sotterraneo ed in parte sulle rive del Tevere, cimitero che fu quasi completamente distrutto nel 1886 con la costruzione dei muraglioni del Tevere. Sotto la cripta sotterranea, un tempo cimitero della confraternita dove furono inumate dal 1552 al 1896 più di 8000 salme, si presenta come un ossario, dove tutto decorazioni, sculture e lampadari è fatto con ossa e scheletri. Chiesa di San Biagio della Pagnotta, via Giulia 64, rione Ponte e rione Regola, Roma, la facciata è dell’architetto G.A. Perfetti, che la realizzò nel 1730. E’ la chiesa della comunità armena, dedicata al vescovo armeno che subì il martirio nel 316, santo protettore della gola. Il 3 febbraio, giorno della sua festa, dopo una Messa cantata di rito armeno, a ogni partecipante viene distribuita una piccola pagnotta. Per questa ragione la chiesa viene chiamata "San Biagio della Pagnotta". In origine questa chiesa si chiamava de cantu secuta, per via del fatto che nel punto in cui sorge vi si depositavano la rena e il fango trasportati dagli innumerevoli straripamenti del Tevere, che qui avvenivano spesso prima della edificazione dopo l'Unità d'Italia, dei muraglioni, i quali si seccavano, da cui il termine latino secuta, e proprio nei pressi si trova il vicolo del Polverone. La chiesa è comunque più popolarmente ricordata come chiesa della Pagnotta, fu restaurata per la prima volta nel 1072, e furono rinvenuti qui resti di un antico tempio romano forse dedicato a Nettuno. La chiesa venne poi affidata alla basilica di San Pietro fino al XV secolo, venne poi nel 1539 dal cardinale Cesarini restituita al capitolo Vaticano divenendo parrocchia. Nel 1836 papa Gregorio XVI la affidò al rito armeno e agli Armeni che prima che qui officiavano nella chiesa di Santa Maria Egiziaca. Chiesa di San Filippo Neri, via Giulia, Roma, di dimensioni modeste detta anche San Filippino, e forse più che una chiesa doveva essere un oratorio, fu fondata dal guantaio fiorentino Rutilio Brandi che la dedicò a San Trofimo, accanto vi costruì un piccolo ospedale per i preti poveri ed un conservatorio per le zitelle che pose sotto la protezione di San Filippo Neri. Dal conservatorio la piccola chiesa venne intitolata a San Filippo Neri, Di questa chiesa ne rimane soltanto la facciata opera di F. Raguzzini, del 1728. Mussolini volle demolire tutti gli edifici della zona per lasciare spazio a una larga strada rettilinea che collegasse Ponte Mazzini con la Chiesa Nuova sul vicino Corso Vittorio. Ma la protesta popolare suscitata dall’iniziativa lo costrinse ad abbandonare il progetto prima di riuscire ad abbattere la facciata. La chiesa è tuttora diroccata. Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, detta anche chiesa Santa Aurea, è a via Giulia 34, Roma è un esempio del roboante Barocco napoletano. La chiesa precedente chiesa di Santa Aura fu edificata nel XIV secolo insieme ad un convento di monache che vi dimorarono per oltre due secoli. Nel 1572 l'edificio venne concesso alla Compagnia dei Napoletani e la chiesa venne ricostruita nel 1600 sotto la direzione di Domenico Fontana. Durante la dominazione napoleonica le confraternite a Roma vennero soppresse inclusa questa e la chiesa dei Napoletani venne chiusa, rimase priva di culto finchè la chiesa venne concessa a Vincenzo Pallotti ed i Pallottini ne ripristinarono il culto cristiano. Nel 1854 l'architetto Cipolla si occupò della facciata della chiesa e dei restauri, durante i quali, ampliò il presbiterio e costruì un abside, nel quale vennero poi poste nel 1942 le salme di re Francesco delle Due Sicilie e della moglie la regina Maria Sofia. La chiesa fu anche il sepolcro dei Borboni di Napoli, che qui sono sepolti in gran numero. Chiesa San Francesco d'Assisi, demolita dopo l'Unità d'Italia, era a via Giulia, rione Ponte, Roma, fu voluta nel 1587 da Papa Sisto V che qui volle ricoverare in un edificio fatto edificare apposta tutti i mendicanti di Roma. Accanto a questo ospizio fece edificare la chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi il santo dei poveri. La chiesa restò in vita fino alla edificazione dei muraglioni sul Tevere, allorchè venne abbattuta, solo il soffitto si è salvato ed oggi si trova nella chiesa di Santa Caterina della Rota che è nella piazza omonima. Chiesa Santa Maria del Suffragio, via Giulia, rione Ponte, Roma, fu fondata nel 1616 dalla Confraternita del Suffragio che aveva dovuto lasciare la chiesa di San Biagio della Pagnotta, la chiesa è vicina alle Carceri Nuove, è opera di Carlo Rainaldi che la terminò nel 1675. Nel 1592 era stata creata la "Confraternita "del Suffragio" presso la chiesa di San Biagio della Pagnotta, con il compito di pregare per le anime dei defunti. La confraternita fu approvata nel 1594 da papa Clemente VIII e nel 1620 fu elevata ad "Arciconfraternita" da papa Paolo V. Essendosi presto rivelata insufficiente la chiesa di san Biagio, la Confraternita aveva acquisito sin dal 1607 una porzione dell'area in origine destinata al Palazzo dei Tribunali, progettato e iniziato sotto papa Giulio II da Bramante a via Giulia e mai terminato. Il progetto venne affidato nel 1662 all'architetto Carlo Rainaldi e la chiesa venne terminata nel 1669, mentre la decorazione dell'interno si protrasse fino al 1685. La facciata presenta due ordini di quattro lesene, che inquadrano in basso tre portali e in alto un finestrone centrale. L'interno è ad un'unica navata con cappelle laterali, coperta da una volta a botte lunettata. Chiesa Santa Caterina da Siena via Giulia, rione Ponte e rione Regola, Roma, questa chiesa fu edificata nel 1526 dalla Compagnia dei Senesi e con il finanziamento di Agostino Chigi, infatti mercanti e banchieri senesi vivevano in via Giulia fin dal XV secolo. La chiesa fu poi restaurata nel 1760 su progetto di Paolo Posi che ha il suo monumento funebre, opera di Giuseppe Palazzi, all'interno della chiesa stessa. La storia della chiesa è legata alla arciconfraternita dei Senesi, a cui ancora oggi l'edificio appartiene. La comunità senese è presente a Roma dalla fine del Trecento. La compagnia dei Senesi, dapprima aveva sede nella chiesa di Santa Maria in Monterone, poi si spostò, verso la metà del Quattrocento, presso la tomba di santa Caterina nella basilica di Santa Maria sopra Minerva, dopo il 1461, anno di canonizzazione della santa senese, la sede della confraternita Senese divenne la chiesa di San Nicola degli Incoronati presso via Giulia. Nel 1519 il sodalizio senese fu ufficialmente riconosciuto come confraternita da papa Leone X. Qui fu decisa la costruzione della chiesa dedicata alla santa patrona della città, dell'oratorio della confraternita e della casa del clero, lavori che furono affidati nel 1526 a Baldassarre Peruzzi e che vennero finanziati dalla nobiltà senese di Roma, tra i quali si distinsero il cardinale Giovanni Piccolomini ed il banchiere Agostino Chigi. Caduta in rovina anche a causa delle piene del Tevere, l'edificio venne completamente ricostruito su disegno di Paolo Posi tra il 1766 ed il 1775, anno in cui fu consacrato il nuovo altare. Della primitiva chiesa, rimangono le descrizioni in alcuni documenti conservati ora nell'archivio della confraternita divenuta arciconfraternita nel 1736. La chiesa di Santa Caterina da Siena a via Giulia aveva tre altari: sull'altare maggiore era esposta la tela raffigurante la Resurrezione, opera di Gerolamo Genga, ora conservata nell'oratorio dell'arciconfraternita; gli altari laterali erano affrescati con dipinti di Timoteo della Vite, discepolo di Raffaello, e di Antiveduto Gramatica. La facciata si ispira al Borromini, ai lati della finestra centrale, si ammirano Romolo e Remo con la lupa, in quanto si attribuisce a Remo la fondazione di Siena. L'interno si presenta ad un'unica navata con quattro cappelle laterali e presbiterio leggermente rialzato e absidato. La chiesa e gli ambienti annessi si estendono fino al lato opposto dell'isolato, su via di Monserrato, nel 1912 è stata rifatta la facciata. Carceri Nuove, Via Giulia 52, rione Ponte e rione Regola, Roma, Papa Innocenzo X fece costruire questo carcere modello, opera di del Grande, del 1655, che rimase in funzione fino alla fine dell’Ottocento, per venire rimpiazzato dal grande e brutto carcere di Regina Coeli, sull’altra sponda del Tevere. Sulla facciata si legge un’iscrizione in favore di un trattamento più umano dei criminali. Le Carceri Nuove rimpiazzavano le tremende carceri di Tor di Nona a Corte Savella, oggi l'edificio ospita il Museo di Criminologia, fondato nel 1931, che raccoglie una documentazione storica e interessante dei mezzi di prevenzione, repressione e sistemi di pena, con l'esposizione dei corpi di reato ed i lavori eseguiti nei penitenziari italiani, l'ingresso è su via del Gonfalone. Palazzo Sacchetti, via Giulia 66, Roma, Antonio da Sangallo, l’architetto di Palazzo Farnese, lo fece costruire nel 1542 per proprio uso personale. Dopo la sua morte, il palazzo passò nelle mani del Cardinale Giovanni Ricci, che lo fece ingrandire da Nanni di Baccio Bigio, e successivamente divenne proprietà della famiglia Sacchetti, che vi abita ancora oggi. Si tratta di un vasto complesso rinascimentale con un cortile al centro e un giardino sul retro, che originariamente scendeva fino al Tevere. Dalla fine dell’Ottocento, quando gli argini del fiume vennero innalzati e fu costruito il Lungotevere, i Sacchetti non debbono più subire le periodiche inondazioni, ma il giardino all’italiana di un tempo è stato molto ridotto e i giganteschi mascheroni appaiono quindi sproporzionati. L'ampia facciata di Palazzo Sacchetti contiene un balcone sul grande portale, probabilmente un'opera posteriore. Da non perdere, i resti della fontana detta del Putto che si trova sul lato sinistro di palazzo Sacchetti all’angolo tra via Giulia e vicolo del Cefalo, raffigurante un ragazzo a cavallo che tiene per la coda due delfini , oggi la fontana è in rovina. Fontana di Palazzo Sacchetti, via Giulia, rione Regola, si trova all'interno del cortile, ha uno zampillo così alto che innaffia anche il giardino circostante. Palazzo Falconieri, via Giulia 1, si trova accanto alla chiesa di Santa Maria dell'Orazione e Morte, rione Regola, Roma, è sede della Accademia d'Ungheria, fu completamente restaurato dal Borromini, ha una bella facciata con angeli, erme di busti femminili a testa di falco, e all'interno presenta uno splendido scalone borrominiano che conduce ai piani superiori. La loggia a tre arcate sul giardino guarda verso il Tevere. Qui vi abitarono il cardinale Fesch zio dell'imperatore Napoleone che vi raccolse una galleria di quadri ed opere d'arte, e il papa Leone XIII quando era ancora cardinale. Il palazzo Falconieri, sorge sull'antico palazzo Odescalchi, del XVI secolo e conservato integro fino al 1638, quando Orazio Falconieri lo acquistò dai Farnesi che a loro volta lo avevano rilevato nel 1606. Dopo il 1640 Borromini lavorò alla ricostruzione dell'edificio con una nuova ala verso il Tevere, iniziata nel 1646. A conclusione dei lavori, protrattisi fino al 1649, l'edificio risultava ampliato e modificato in più zone. Nella facciata su Via Giulia, Borromini aggiunse tre finestre alle otto preesistenti e realizzò un portone cieco, simmetrico a quello cinquecentesco. Alle estremità del prospetto egli inserì due erme con teste di falco, animale simbolo della famiglia, e seni femminili; delle due una, quella di sinistra fu messa in opera nel 1730-35. Dal 1650 al 1660 furono eseguiti dei lavori inerenti la funzionalità dell'edificio: canalizzazione dell'acqua, costruzione di granai, cucine e giardini. Dal '64 al '69 gli operai della fabbrica si occuparono di finiture e restauri. Tra il 1730 e il 1733 Ferdinando Fuga è documentato come architetto della famiglia Falconieri per la quale lavorò nel palazzetto adiacente all'edificio principale su Via Giulia, ove eseguì alcuni lavori di rifinitura. Vi sono due erme ai lati del palazzo con la testa di falco, l'immagine della Madonna con bambino in mosaico " Patrona Hungariae " posta sopra la seconda porta, quella murata, e la parte di sotto del balconcino con rosoni e stemma con falco. Dal lato del Lungotevere abbiamo anche una bella vista dell'altana progettata dal Borromini. Fontana di palazzo Falconieri, via Giulia 1, rione Regola, Roma, si attribuisce al Borromini, è formata da una nicchia entro la quale una conchiglia di marmo accoglie il getto di acqua che esce a ventaglio. In alto nel mezzo del timpano interrotto vi è un vaso di fiori in pietra. La fontana è al centro delle due rampe della scalinata che da accesso al piccolo giardino interno. Palazzo Clarelli, via Giulia 79, rione Regola, Roma, opera di Antonio da Sangallo il Giovane, che qui si era costruito la propria abitazione, l'edificio passò poi ai Medici, ha un portalea bugnato rustico con colonne doriche in travertino. Casa di Raffaello, Via Giulia 85, Roma, così chiamata perché edificata sul lotto che il celebre pittore, come altri artisti dell’epoca, si era acquistato nella nuova strada. La prematura scomparsa gli impedì tuttavia di avviare i lavori, cosicché l’edificio che oggi porta il suo nome venne in realtà costruito dopo la sua morte. Liceo Ginnasio Virgilio, via Giulia 38, rione Ponte e rione Regola, Roma, fu edificato tra il 1936 e il 1939, il portone faceva parte dell'antico Collegio Ghisleri. Piazza San Vincenzo Pallotti, va da via Giulia a Lungotevere dei Vallati, rione Regola, Roma,ricorda il sacerdote romano nato nel 1795 e morto nel 1850 che fondò l'ordine religioso dei preti secolari comunemente noti come Pallottini che hanno sulla piazza la loro Curia Generalizia. Arciconfraternita dei Pallottini, l'edificio si trova su piazza San Vincenzo Pallotti, rione Regola, Roma, ed ospita la Curia Generalizia della Arciconfraternita dei Pallottini. Lungotevere dei Vallati, Roma, va da piazza San Vincenzo Pallotti a via Arenula, fa parte del rione VII Regola, collega ponte Sisto a ponte Garibaldi sul lato opposto del Tevere c'è lungotevere Raffaello Sanzio, il nome ricorda la antica e nobile famiglia romana dei Vallati che si sacrificò per difendere ponte Sisto dai Lanzichenecchi nel famoso sacco del 26 maggio del 1527, qui sul lungotevere dei Vallati 20 c'è il villino Scafi realizzato nel 1886 su progetto di Filippo Galassi. Vedi Lungotevere ei Vallati. Lungotevere dei Tebaldi, Roma, rione VII Regola, va da piazza San Vincenzo Pallotti al ponte Mazzini, collega ponte Sisto a ponte Mazzini sul lato opposto del Tevere c'è il lungotevere della Farnesina, ricorda una antica famiglia romana che si estinse nel 1745, e che qui aveva le proprie dimore, molti dei suoi membri furono Conservatori di Roma. Questo è uno dei più bei lungotevere di Roma che unisce architetture antiche e fascino naturalistico, dell'antistante colle Gianicolo e la suggestione dei platani, in una sorta di continuità tra il moderno lungotevere e la via Giulia. In questa zona passava la chiavica di Santa Lucia, che era una delle più importanti cloache della città di Roma e sempre qui vi era un importante snodo viario del retrostante quartiere commerciale di via del Pellegrino e di via di Monserrato. Per l'edificazione del lungotevere dei Tebaldi vennero abbattuti alcuni edifici di via Giulia e piazza della Padella che davano sul Tevere e che formavano il cosiddetto Monte dei Planca Incoronati dal nome della famiglia che era proprietaria di quelle case, e sempre qui vi era la chiesa di San Nicolò degli incoronati soprannominata de furcis, perchè un tempo qui venivano eseguite le condanne a morte. Nella via di Monserrato e di via Giulia, a sottolineare il carattere religioso della zona, vi sono ben cinque chiese nel primo tratto, tra queste la chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, di origine medioevale dedicata a Sant'Aurea e che nel 1574 passò alla nuova confraternita dello Spirito Santo dei Napoletani, vi era annesso un ospizio che poi, ristrutturato divenne nel 1670 la sede del Collegio Ghisleri. Vedi Lungotevere dei Tebaldi. Ponte Sisto Roma, il ponte Sisto è l' ex ponte di Agrippa, chiamato anche ponte Aurelio, pons Aurelius, pons Janicularis, ponte Gianicolense, pons Valentinianus, ed anche ponte Antonino Pio, oggi Ponte Sisto. Il Ponte Sisto fu voluto da Papa Sisto IV che in occasione del Giubileo del 1475 , altro non fu che un imponente restauro del preesistente romano ponte di Agrippa, limitato alle arcate del ponte e non alle "pile", ovvero i piloni che erano ancora ben conservati. Papa Sisto IV, Francesco della Rovere, aveva promesso a se stesso che se un giorno fosse diventato papa avrebbe ricostruito quel ponte, l'antico ponte di Agrippa, diroccato, che stava davanti alla chiesa di San Salvatore in Onda, a via dei Pettinari, zona Campo de Fiori, perchè ogni volta che doveva recarsi in Vaticano, poteva recarsi li, solo passando per ponte Sant'Angelo; diventato Papa, mantenne la promessa. Nel 1475 l'antico ponte di Agrippa era stato restaurato e ribattezzato ponte Sisto. Era detto pons Aurelius ed anche pons Januculatis, congiungeva la via che oggi si chiama via dei Pettinari, con la via Aurelia vetus alle falde del Gianicolo. La gran parte dei ponti di Roma, collegavano l'antica Roma al Gianicolo, perchè il colle era una delle zone di Roma più densamente popolata, per la sua tranquillità e per l'aria salubre. Antichi codici, chiamano l'antico ponte anche pons Antoninus, forse il nome derivato da Marco Aurelio Antonino, o Antonino Caracalla, ed è probabile che il costruttore sia stato quest'ultimo, in quanto possedeva grandi proprietà a Trastevere. Vedi Ponte Sisto. Via dei Pettinari, va da piazza della Trinità dei Pellegrini a piazza San Vincenzo Pallotti, rione Regola, Roma, anticamente si chiamava via della Trinità, ma mutò il nome quando qui vi si stabilirono i cardatori di lana o pettinari, dalle cui botteghe usciva un tessuto chiamato "pettinato di lana". Gli ultimi pettinari presenti in questa zona risalgono al 1848 e furono i Venturini. La contrada per le frequenti piene del Tevere era detta anche "in onda". Edicola sacra via dei Pettinari, al numero 53, rione Regola, Roma, nei pressi del ponte Sisto, si tratta dell'affresco protetto da un vetro di una Madonna con il Bambino Gesù in braccio e con accanto, seduto a terra sulla sinistra San Giovannino accanto al quale vi è poggiata una croce, l'immagine si trova entro una semplice cornice modanata di stucco, corrispondente al vano di una finestra cieca del primo piano, al di sotto una lapide che recita : "Vi offro il mio cuore e insieme l'alma mia, per me pregate o Vergine mia. Se dirai di cuore Ave Maria, in cielo tu vedrai la faccia mia " datata : 1705. Edicola sacra via dei Pettinari, al numero 39, rione Regola, Roma, c'è una Madonna con Bambino, che si trova al di sopra di un balcone, è un moderno altorilievo, dove la madonna con il bambino è seduta tra le nubi ed è inserita in un ovale di stucco grigio contornato da una vistosa raggiera solare. La madonnina è protetta da un baldacchino che culmina con una stella a 8 punte e a tre dimensioni, illumina l'immagine una lanterna in ferro battuto. Chiesa San Salvatore in Onda, via dei Pettinari, rione Regola, Roma, è una antica chiesa di tipo basilicale a tre navate risalente al XIII secolo. Fu restaurata nel 1260 dai Cesarini e venne concessa ai Frati Conventuali da papa Eugenio IV. Nel 1700 la chiesa venne rialzata dal suo livello primitivo e subì un radicale restauro nel secolo scorso. Vicolo dell'Arcaccio, va da piazza San Vincenzo Pallotti, rione Regola Roma, si trova presso ponte Sisto, palazzo Spada e palazzo Farnese. Fontanella a vicolo dell'Arcaccio, scomparsa, era all’angolo di Vicolo dell’Arcaccio, accanto all'entrata di un Ristorante Vietnamita, era una classica fontanella romana che una notte è sparita e non è più tornata forse è andata ad abbellire qualche giardino privato. Piazza Farnese, è tra via dei Baullari e via di Monserrato, rione Regola, Roma, prende il nome dal palazzo Farnese. Palazzo Farnese, piazza Farnese, rione Regola, Roma, è uno dei più bei palazzi Cinquecenteschi di Roma, fu voluto dal Cardinale Alessandro Farnese, il quale quando divenne Papa con il nome di Papa Paolo III fece ridisegnare il Palazzo dal Sangallo il Giovane aiutato da Michelangelo che progettò il grande cornicione, la finestra centrale della facciata e il terzo piano verso il cortile Michelangelo voleva collegare Palazzo Farnese con Villa Farnesina a Trastevere, con un ponte, ma il progetto non fu mai realizzato, del progetto rimane solo l'arco di Via Giulia. Il Palazzo fu poi completato da Della Porta nel 1589. Oggi ospita l'Ambasciata Francese. Per la sua mole e forma il palazzo era chiamato "il dado dei Farnese "ed era considerato una delle meraviglie di Roma.Il palazzo venne edificato a partire dai primi del 1500, quando i Farnese acquistarono delle proprietà appartenute al cardinale Ferritz. Per costruire il sontuoso palazzo, e ampliare la piazza alcune di queste case vennero demolite. Nel 1593 la piazza era chiamata del Duca, perché Pier Luigi Farnese era Duca di Parma, secoli dopo, estinti i Farnese il palazzo passò agli eredi dei Borboni di Napoli, e la piazza si chiamerà di Napoli. Via dei Farnesi, rione Regola, Roma, va da piazza Farnese a via Giulia, rione Regola, Roma, prende il nome come la piazza dal palazzo Farnese. Edicola sacra via dei Farnesi, rione Regola, Roma, è un Cristo raffigurato entro un medaglione ovale, il Cristo è in piedi nel sepolcro, il rilievo fu eseguito nel 1734 da Pietro Bracci ed è incisa la parola "Charitas". Si trova sulla Casa della Arciconfraternita della Carità, che ha una elegante facciata risalente al XVIII secolo, era sede di una istituzione religiosa sorta nel 1520 come assistenza ai bisognosi, agli infermi e ai poveri. Chiesa Santa Brigida piazza Farnese rione Regola, Roma, risale al 1391, dovrebbe essere stata edificata sulla casa dove visse la santa svedese giunta a Roma per il Primo Anno Santo indetto da Papa Bonifacio VIII, si fermò a Roma con la figlia dando vita ad un suo ordine monacale. La casa le venne data da Francesca Papazzurri nel 1354 e qui la Santa morì nel 1373. La casa venne trasformata in oratorio e venne restaurata nel Settecento. La volta è stata affrescata da Biagio Puccini. Campanile chiesa Santa Brigida piazza Farnese, rione Regola, Roma, sovrasta con la sua bellezza la chiesa di Santa Brigida. Fontane gemelle di Piazza Farnese, rione Regola, Roma, sono collocate ai lati della piazza, e consistono in due enormi vasconi provenienti dalle Terme di Caracalla e che Alessandro Farnese ebbe in dono dal pontefice, ma che furono attive solo quando arrivò qui l'acqua dell'Acquedotto dell'Acqua Paola, la sistemazione delle due fontane si deve a Carlo Rainaldi, e presentano i gigli simbolo araldico dei Farnese. Palazzo del Gallo di Roccagiovine, piazza Farnese, rione Regola, Roma, fronteggia il palazzo Farnese, tra via dei Baullari e via della Corda, è notevole lo scalone Settecentesco a spirale che si può ammirare dal cortile. Il Palazzo del Gallo di Roccagiovine, era conosciuto anche come Palazzo Fusconi Pighini, venne eretto nel 1527 da Baldassarre Peruzzi ma il suo elegante aspetto settecentesco è dovuto ad Alessandro Specchi, che si occupò anche del suo ampliamento sul lato sinistro rispetto alla costruzione originaria. La facciata principale presenta, al pianterreno, l'alto portale d'ingresso fiancheggiato da colonne su alto plinto e sormontato da balcone con porta finestra, inoltre vi sono quattro botteghe con arco ribassato. La facciata posteriore del palazzo affaccia su via della Corda e mostra l'antico aspetto cinquecentesco originario. All'interno si trova una ricca collezione di opere antiche pregevoli tra cui la statua di Meleagro con il cane e la copia della testa del cinghiale ucciso, il cui originale è al Museo Pio Clementino ai Musei Vaticani. Via dei Baullari, rione Regola, Roma, va da corso Vittorio Emanuele II a piazza Campo de Fiori, il vicolo tra campo de Fiori e piazza Farnese. La via fu aperta nel 1517 dal cardinale Alessandro Farnese Edicole sacre a via dei Baullari, rione Regola, Roma, vi sono 3 bellissime edicole sacre. Vicolo della Corda, rione Regola, Roma, va da Campo de Fiori a piazza Farnese, ricorda il palo del supplizio della corda che si eseguiva a campo de Fiori , erano dei pali con carrucole per supplizi che venivano inflitti per i reati minori. Via dei Balestrari, rione Regola, Roma, va da piazza campo de Fiori a piazza della Quercia, qui in epoca medioevale vi erano i fabbricanti ed i venditori di balestre. Edicola sacra via dei Balestrari rione Regola, Roma, è collocata al numero 42 della via, si trova tra il pianterreno di un palazzo che era della Arciconfraternita della Immacolata Concezione, di cui conserva sul portone di ingresso una targa, si tratta della tela di una madonna con bambino, la Madonna contempla il Figlio con lo sguardo amoroso mentre lo copre con il suo manto bianco. L'immagine si trova entro un medaglione realizzato in stucco, sorretto da un fiocco ricco di motivi ornamentali in rilievo, tra cui spiccano stelle ad otto punte. E' stata restaurata nel 1975. Pontificia Università della Santa Croce, Biblioteca, via dei Farnesi, Roma, è una istituzione Universitaria che elargisce borse di studio per gli studenti di Dottorato delle Università Pontificie di Roma e del Lazio. Via di Monserrato rione Regola, Roma, va da via dei Banchi Vecchi a piazza Farnese, la via fece parte per un periodo della antica via Papalis che veniva percorsa dai cortei papali, il nome le deriva dalla chiesa di Monserrato. Qui un tempo vi erano le carceri e la Corte Savella o Curia dei Savelli una sorta di Tribunale la cui giurisdizione era in capo alla famiglia dei Savelli. Chiesa di San Tommaso di Canterbury, via di Monserrato, rione Regola, Roma, si trova all'altezza di piazza Santa Caterina della Rota, è la chiesa del Venerabile Collegio Inglese, la chiesa è in stile romanico, a tre navate. Sono tre le chiese che si sono susseguite nel corso dei secoli su questo stesso edificio. La prima chiesa di cui si ha conoscenza è la chiesa della Santissima Trinità degli Scozzesi, che una tradizione non documentata attribuisce alla volontà del re di Mercia Offa nel 630. Essa è attestata, con annessi un monastero e un ospizio per i pellegrini d'Inghilterra, alla fine del XII secolo nel catalogo di Cencio Camerario al nº 56 con il titolo di sancte Trinitati Scottorum. Una bolla di papa Bonifacio VIII del 1299, che ne conferma una precedente di papa Innocenzo IV (1249), attribuisce la chiesa al monastero di San Gregorio al Celio. L'istituzione dei Giubilei fu accompagnato dall'aumento del numero dei pellegrini d'oltremanica. Questo determinò la nascita di una societas pauperorum Anglorum (divenuta poi confraternita) e l'ampliamento dell'ospizio di via di Monserrato e dell'annessa chiesa, ricostruita nel 1363. Fu in questo periodo che all'antico titolo fu aggiunto quello di san Tommaso Becket, arcivescovo di Canterbury nel XII secolo. L'edificio subì un primo intervento di restauro e ampliamento nel 1450. A partire da Enrico VII (1485-1509), era al sovrano inglese che spettava il compito di nominare il rettore della chiesa e dell'ospizio; ma dopo lo scisma di Enrico VIII, papa Paolo III avocò alla chiesa di Roma tale diritto, e nel 1538 fu nominato governatore della chiesa e degli annessi edifici il cardinale Reginald Pole. Nel 1575, su iniziativa del cardinale William Allen, fu intrapresa un'opera di riedificazione della chiesa e dell'antico ospizio. Con una bolla di papa Gregorio XIII del 1º maggio 1579 l'ospizio fu mutato in collegio ecclesiastico per giovani studenti della nazione inglese, l'odierno Venerabile Collegio Inglese, affidato ai Gesuiti. Personalità del mondo anglosassone furono ospiti nel collegio, tra cui Thomas Cromwell, conte di Essex, nel 1514, il cardinale Reginald Pole nel 1534, il poeta John Milton nel 1636. Tra il 1581 ed il 1584 Niccolò Circignani, detto il Pomarancio, affrescò le pareti della biblioteca sopra la chiesa, con le storie di santi e martiri inglesiTra il 1680 ed il 1685 il cardinale Thomas Howard fece ristrutturare la chiesa ed il collegio; in questa occasione fu aggiunta la torre dell'orologio di ispirazione borrominiana.. Con l'occupazione francese di Roma, il complesso fu trasformato in caserma. Solo nel 1818 ritornò all'antica destinazione d'uso, ma necessitava di un generale restauro. La chiesa fu rifatta ex novo: la prima pietra fu posta il 6 febbraio 1866 ed il nuovo edificio fu aperto al pubblico nel 1888. Alla sua costruzione si susseguirono tre architetti: Luigi Poletti, Pietro Camporese il Giovane e Virginio Vespignani. Chiesa di Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli, via di Monserrato, rione Regola, Roma, la chiesa risale al 1506 quando la confraternita spagnola della Vergine di Monserrat in Catalogna, fondò a Roma un ospizio per i pellegrini spagnoli . è la chiesa nazionale degli Spagnoli a Roma e, dal 2003, è sede del titolo cardinalizio di Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli., ove erano già stabiliti i due ospedali anzidetti riuniti in un solo. Nasce dalla fusione, nel 1803, di due istituzioni separate, fondate verso la fine del Medioevo come centri di accoglienza per i pellegrini spagnoli, principalmente poveri e infermi, e per legati di diversa provenienza e rango sociale. Una di queste, Santiago y San Ildefonso de los Espanoles in piazza Navona, fu fondata da Alfonso de Paradinas nominato nel 1469 vescovo di Ciudad Rodrigo, e accoglieva principalmente coloro che provenivano dal Regno di Castiglia; l'altra, Santa Marìa de Montserrat, nella strada che porta il suo nome, via di Monserrato, coloro che provenivano dai Regni della Corona d'Aragona ed era ispirata alla Madonna venerata presso il monastero catalano di Montserrat. Per le loro origini e attività, entrambi i centri stabilirono presto delle relazioni con le istituzioni dei due regni, acquisendo così il carattere, via via più marcato, di chiese "nazionali". Ma dopo la chiusura, nel 1798, della chiesa di Monserrato, papa Pio VII, nel 1807, approvò la sua unione canonica con quella di Santiago. Successivamente, stabilita nel 1817 la chiusura di quest'ultima e la sua vendita nel 1878, fu mantenuta come unica chiesa nazionale spagnola quella di Monserrato, alla quale era stata anteposta nel 1807 la titolarità dell'altra. Da qui la sua denominazione di Chiesa Nazionale Spagnola di Santiago e Monserrato. Autore della chiesa fu Antonio da Sangallo il Giovane. I lavori di edificazione subirono delle interruzioni per mancanza di risorse, ma nonostante ciò gli architetti che si susseguirono al Sangallo, Bernardino Valperga, Francesco da Volterra, ed altri, rispettarono il progetto originale. La posa della prima pietra avvenne nel 1518; l'altare maggiore fu consacrato nel 1594; la volta della navata fu terminata nel 1598, ma solo nel 1675 fu completata quella dell'abside, con la realizzazione e consacrazione di un nuovo altare maggiore. Restaurata completamente nel 1818-21 e costruito ex novo l'altare maggiore, fu riconsacrata nell'anno 1822.. All'interno notevole è il busto del Bernini di Pedro Foix De Montoya, c'è anche un dipinto di Annibale Carracci " San Diego de Alcalà", tombe del XV secolo di Andrea del Bregno e Luigi Capponi collocate nel cortile e nelle cappelle laterali. Edicola sacra Madonna con Bambino via di Monserrato, angolo piazza Farnese, rione Regola, Roma, è una piccola edicola mariana posta sull'angolo del palazzo Cadilhac, si trova all'altezza del promo marcapiano, è costituita da un medaglione ovale sorretto ai lati da due putti, ed inferiormente da una piccola testa alata, il dipinto è realizzato a fresco all'interno del medaglione, raffigura la Madonna che tiene in braccio il Bambino mostrandolo a San Filippo Neri che si china quasi a baciargli il piede. Chiesa Sant'Anna dei Parafrenieri a via Giulia, vedi anche chiesa in Santa Caterina della Rota, Roma Chiesa di San Girolamo della Carità, Via di Monserrato 62/A, Roma, la chiesa sorge nel luovo dove abitò San Filippo Neri, un uomo che nel XVI secolo rinnovò la vita culturale e spirituale di Roma e che si prese cura per tutta la vita del "monelli" romani. La Cappella Spada fu progettata dal Borromini, spledida testimonianza del Barocco, l'interno della cappella è decorato con marmi policromi con statue di diaspro venato che imitano damaschi fioriti e drappi di velluto Vi è anche la statua di San Filippo Neri circondata da angeli opera di Pierre Legros. Chiesa di Sant'Eligio degli Orefici, via di Sant'Eligio 8/A, Roma, fu commissionata nel XVI dalla corporazione degli orefici, opera di Raffaello che come Bramante il suo maestro amava le opere monumentali, la cupola è attribuita a Baldasarre Peruzzi, mentre la facciata fu aggiunta nel XVII secolo ed è opera di Flaminio Ponzio Via del Mascherone va da piazza Farnese a via Giulia, rione Regola, Roma, prende il nome dalla fontana del Mascherone a via Giulia. Edicola sacra via del Mascherone, rione Regola, Roma, è una bellissima madonnina con bambino all'interno di un tondo.
Chiesa Santi Giovanni Evangelista e Petronio, via del Marcherone, rione Regola,
Roma, è la chiesa regionale dei bolognesi residenti a Roma, una
chiesa parrocchiale medievale, risalente al 1186 ed annoverata tra
le chiese filiali di San Lorenzo in Damaso. All'epoca portava il
nome di Sanctae Thomae de Yspanis, perché affidata alla cura di
sacerdoti spagnoli: nel catalogo di Cencio Camerario di fine XII
secolo compare con il nome di Sancto Thome de Spanis. Alla fine del
XV secolo era chiamata San Tommaso dei muratori e successivamente
anche San Tommaso della catena, dai frati disciplinati che vi
dimorarono per un certo periodo. Nel 1581 papa Gregorio XIII affidò
la chiesa all'arciconfraternita delle Stimmate dei Bolognesi, che la
restaurò, affidando i lavori a Ottaviano Mascherino nel 1582, e
dello stesso architetto era l'oratorio annesso, eretto nel 1601 e
andato distrutto nell'Ottocento. La facciata odierna risale alla
fine del XVII secolo. Il cardinale titolare è l' arcivescovo emerito
di Bologna. Oratorio di Santa Lucia del Gonfalone, vicolo della Scimmia 18, Roma, vi si accede da Vicolo della Scimmia. Si tratta della sede di una delle molte confraternite sorte nel Medioevo a Roma, i cui membri partecipavano portando bandiere alle processioni di carri allegorici che avevano sostituito gli sport sanguinari del Colosseo. L’oratorio, che spesso ospita concerti, contiene un ciclo di 12 affreschi dipinti nel 1573 da Federico Zuccari, e altri che hanno come soggetto la Passione di Cristo. Carceri Via del Gonfalone, Roma, nell’adiacente Via del Gonfalone si trova un altro carcere, costruito 200 anni dopo esclusivamente per i minori e anch’esso attualmente abbandonato. Piazza dell'Oro, è tra via Giulia e via Acciaioli, rione Ponte Roma, il nome deriva dalle proprietà della famiglia Dell'Oro attiva a Roma fino alla fine del XVII secolo, la zona era chiamata Tarentium per via di una enorme voragine dalla quale fuoriusciva un olezzo tremendo, ed i romani credevano che fosse uno degli ingressi degli inferi, e Tarante figlio di Nettuno era per la leggenda il fondatore di Taranto, per corruzione il nome è giunto come tarandus, che era anche un mitico animale demoniaco grande come un bue con la testa di cervo ed i piedi di orso Via degli Acciaioli, rione Ponte, Roma, va dal lungotevere dei Fiorentini a corso Vittorio Emanuele ricorda una famiglia fiorentina che fu qui fin dal 1282. Basilica di San Giovanni dei Fiorentini, Via Acciaioli 2, rione Ponte, Roma, fu iniziata la costruzione della Chiesa dal 1500, per la numerosa comunità fiorentina, che viveva in questa zona, Papa Leone X volle che questa chiesa esprimesse la superiorità culturale di Firenze su Roma.Ci volle un secolo perchè la chiesa fosse ultimata.L'architetto principale fu Antonio da Sangallo il Giovane, la cupola è del Maderno del 1614, la facciata restaurata di recente fu aggiunta nel XVIII secolo La chiesa è decorata principalmente da artisti toscani, è interessante la statua di San Giovannino opera del siciliano Mino del Reame collocata in una nicchia sopra la sacrestia.Da veder il battesimo di Gesù di Antonio Raggi che si trova al centro di un grandioso altare del Borromini, sepolto nella chiesa insieme al Maderno.E' una chiesa in cui sono bene accetti gli animali e a Pasqua c'è la tradizionale benedizione dell'agnello pasquale.San Filippo Neri fondò la Congregazione dell'Oratorio proprio mentre era Rettore di questa Chiesa, c'è infatti una cappella a lui dedicata. Malgrado la poco attraente facciata settecentesca, si tratta di una chiesa barocca cui hanno lavorato alcuni dei più importanti architetti del Seicento: Sansovino, Antonio da Sangallo e Carlo Maderno. Papa Leone X de’ Medici la fece edificare nel 1620 per i suoi compatrioti fiorentini stabilitisi nel quartiere, ma purtroppo non accettò i progetti presentati dai due grandi geni dell’alto Rinascimento, Michelangelo e Raffaello. Attualmente, ogni settimana vi si celebrano messe cui è possibile partecipare con i propri animali domestici. Cupola Basilica San Giovanni dei Fiorentini, rione Ponte Roma, la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini richiese un secolo per essere completata e fu infatti edificata attraverso l'opera di, Antonio da Sangallo il Giovane, Giacomo Della Porta e da Carlo Maderno, al quale si deve la caratteristica cupola del 1614 di forma allungata, che i romani battezzarono "il confetto succhiato". La cupola si imposta su un alto tamburo ottagonale sul quale si aprono quattro finestre rettangolari, con eleganti cornici, ed altrettante nicchie ad arco. Sopra, dopo una zona intermedia leggermente arretrata, si eleva la calotta, scandita in sezioni ogivali, che si conclude con una graziosa lanternina barocca finestrata. Nel campanile venne posta un'antica campana con la scritta in inglese "Maria is my name" che si vuole provenga dalla cattedrale di Saint Paul di Londra. Piazza De Ricci, va da via di Santa Aurea a via di Monserrato, rione Regola, Roma, anticamente era detta piazza Orsini per la presenza del palazzo omonimo, divenne poi per la famiglia Ricci, piazza de Ricci Edicola Sacra piazza de Ricci, rione Regola, Roma, è collocata all'angolo con la via Aurea, posta sul cantone bugnato cinquecentesco del palazzo Ricci, palazzo che fu fatto edificare dagli Acquaviva incaricando Nanni di Baccio Bigio. All'interno di un ovale in stucco si trova un dipinto ad olio seicentesco della Madonna con le mani giunte in atteggiamento di preghiera, intorno a questa edicola mariana pendono festoni di fiori e nastri, mentre al di sopra vi è una ricca ghirlanda di rose, inferiormente una piccola testa alata, e a protezione dell'insieme un baldacchino in stucco. Palazzo Ricci, piazza de Ricci, Roma, il palazzo era famoso per gli affreschi della sua facciata, oggi scolorita, che risalivano al XVI secolo, e che erano opera di Polidoro da Caravaggio allievo di Raffaello. Durante in Rinascimento era abitudine far decorare dagli artisti le facciate dei palazzi, in modo da confermare l'importanza del committente. Le decorazioni delle facciate richiedevano una ottima conoscenza della prospettiva, destrezza, perchè la pittura doveva essere terminata prima che l'intonaco fresco si asciugasse. Il palazzo venne eretto da Nanni di Baccio Bigio per la famiglia degli Aquaviva, venne poi acquistato dal vescovo di Bisignano, Fabio Arcelli che lo fece ampliare nel 1531. Passò poi al cardinale Giulio Ascanio Sforza ed infine al cardinale Francesco Ricci. Chiesa San Giovanni in Ayno, piazza de Ricci, rione Regola, Roma, è una piccola chiesa sconsacrata oggi ridotta ad abitazione, forse il termine significa agnello per via di una pittura murale. La chiesa si trova citata per la prima volta in un documento di papa Urbano III del 1186 tra le chiese filiali di San Lorenzo in Damaso. Piazza Santa Caterina della Rota è tra via di Monserrato e via di Santa Caterina della Rota, prende il nome dalla chiesa omonima che vi sorge dedicata alla santa nativa di Alessandria d'Egitto e martirizzata nel IV secolo per non aver voluto rinnegare la sua fede cristiana. Il 25 Novembre d ogni anno festa della Santa, si faceva una funzione speciale per l'accensione della legna in tutti i camini, era la cerimonia di entrata ufficiale dell'inverno e delle feste natalizie, e da quel giorno si vedevano circolare per Roma i pifferai fino a Natale. Chiesa di Santa Caterina della Rota, piazza S. Caterina della Rota, rione Regola, Roma, È una delle più antiche chiese del rione Regola. Nel XVI secolo la chiesa fu rifatta con lavori di Ottaviano Mascherino e dedicata a Santa Caterina d’Alessandria, martirizzata nel IV secolo per non aver voluto rinnegare la propria fede. La tradizione vuole che la santa subisse il martirio della ruota, da cui deriva il nome della chiesa, in romanesco, della rota. Dal 1929 la chiesa è sede della Venerabile Arciconfraternita di Sant'Anna de' Parafrenieri. La facciata risale al 1730 e al centro del timpano è posto lo stemma del Capitolo di San Pietro, cui si deve il restauro della chiesa alla fine dell’Ottocento. L’interno si presenta ad una sola navata con tre cappelle per lato: di notevole suggestione il soffitto ligneo che risale al Cinquecento e proveniente dalla chiesa di San Francesco d’Assisi a ponte Sisto, chiesa demolita in occasione della costruzione dei muraglioni del Tevere. Via delle Zoccolette, va da via dei Pettinari a via Arenula, rione Regola, Roma, il toponimo sembra derivare dal Conservatorio dei Santissimi Clemente e Crescentino istituito per le povere orfane denominate zoccolette, per via dei calzari che indossavano, anche se a Roma il nome "Zoccola" indica "Meretrice", donna di malaffare, probabilmente le piccole orfane una volta cresciute, se non avessero trovato di che mantenersi, inevitabilmente sarebbero finite sul marciapiede. Ad ogni modo le orfane, di almeno uno dei genitori, ammesse nel conservatorio, imparavano a cucire, a ricamare e a lavorare la lana, e pertanto avevano la possibilità di mantenersi con un mestiere. Conservatorio dei Santi Clemente e Crescentino, via delle Zoccolette, rione Regola, Roma, costituisce una parte del grande complesso dell'Ospizio dei Mendicanti, istituito da Papa Sisto V nel 1587, su progetto di Domenico Fontana, la parte istituita alle "zoccolette" fu istituita nel 1715 da Papa Clemente XI che trasferì qui l'istituto creato da Papa Innocenzo XII 15 anni prima a San Giovanni Decollato. Il complesso si sviluppa su due edifici a due e a tre piani con le iscrizioni relative ai due Papi. Ha subito diverse modifiche nel corso dei secoli, l'ultima è del 1893 ad opera dell'architetto Parisi che sostituì il portale sul quale campeggia o stemma di papa Leone XIII allora regnante. Edicola sacra a via delle Zoccolette, rione Regola, Roma, è una edicola seicentesca posta quasi ad angolo con via dei Pettinari, su di un edificio dove ha sede il Centro Immigrati della Caritas. L'immagine è posta entro una cornice di stucco con una ricca decorazione a ovuli, al centro vi è il dipinto di una Madonna con Bambino con due Santi, di cui uno quello sulla sinistra forse è Sant'Antonio Abate, dell'altro santo non si riesce a distinguerne bene i contorni. Piazza del Monte di Pietà, è tra via dell'Arco del Monte e via degli Specchi, rione Regola, Roma, prende il nome dal palazzo del Monte dei Pegni, che i romani chiamano Monte dell'Empietà, per l'elevato interesse che la Cassa di Risparmio richiede a chi ha la sfortuna di dovervi ricorrere. Palazzo del Monte della Pietà, rione Regola, Roma, l'istituzione nacque dalla provvida mente di fra Barnaba da Terni che arrivò a Roma nel 1540 e di fra Giovanni de Calvi, inizialmente il Monte di Pietà non aveva una sede stabile, questa fu concessa nel 1540, e l'attuale edificio deriva dal riadattamento di un altro precedente, eseguito nel 1588 da Ottavio Mascherino. Quando nel 1603 l'edificio venne ceduto al Sacro Monte di Pietà, venne ampliato sotto la direzione di Carlo Maderno, dopo la sua morte i lavori proseguirono ad opera di Bartolomeo Breccioli fino al 1637 e di Francesco Peparelli fino al 1641. I lavori si conclusero con la costruzione e la decorazione della cappella ad opera di Giovanni Antonio De Rossi e di Francesco Bizzaccheri, il resto dell'edificio verso la chiesa della Trinità dei Pellegrini è di Sebastiano Cipriani. Nel 1740 il palazzo fu di nuovo ingrandito ad opera di Nicola Salvi e la facciata si arricchì del monumentale orologio che però non segna mai l'ora giusta, malfunzionamento voluto dal suo costruttore tedesco che non venne pagato per la sua opera e che quindi manomise il meccanismo in modo che non potesse essere in nessun modo riparato, al di sotto c'era la scritta, oggi scomparsa, "Per non essere stato al nostro patto lì orologio del Monte è sempre matto". Fontana del palazzo del Monte di Pietà, piazza del Monte di Pietà, rione Regola, Roma, si trova sul lato del portone d'ingresso, fu fatta edificare da papa Paolo V, la fontana è piena di simboli dei Borghese, racchiusi in una grossa conchiglia nella quale l'aquila, sempre simbolo dei Borghese, campeggia nella sottostante vasca di raccolta. Edicola sacra piazza del Monte della Pietà, rione Regola, Roma, si tratta dell'immagine del Cristo nel sepolcro, con ai lati gli stemmi pontifici di papa Paolo III e di papa Clemente VIII, nella parte inferiore gli stemmi del cardinale Pietro Aldobrandini e del Comune di Roma. Foto via Giulia e dintoni Via Giulia e dintorni, Roma, foto Anna Zelli Foto via Giulia e dintorni Roma
Vedi nei dintorni di via Giulia (Roma)
Via Giulia e dintorni (Roma)
Via Giulia e dintorni, Roma, foto Anna Zelli Torna via Giulia e dintorni - Itinerari Turistici Roma - Guida Turistica di Roma Via Giulia e dintorni - Itinerari Turistici Roma- Guida turistica di Roma
Tutte le Foto sono di proprietà di
Anna Zelli
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna Zelli A.Z. Arte Cultura Novità Idee
potete contribuire gratuitamente con le vostre idee : mandate una mail |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.gif)



















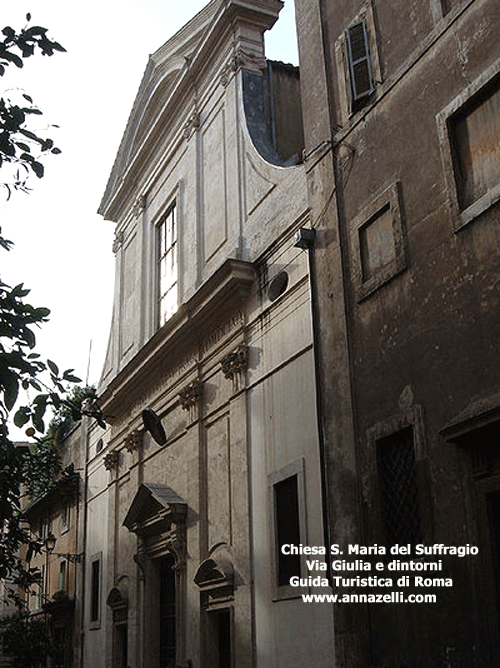


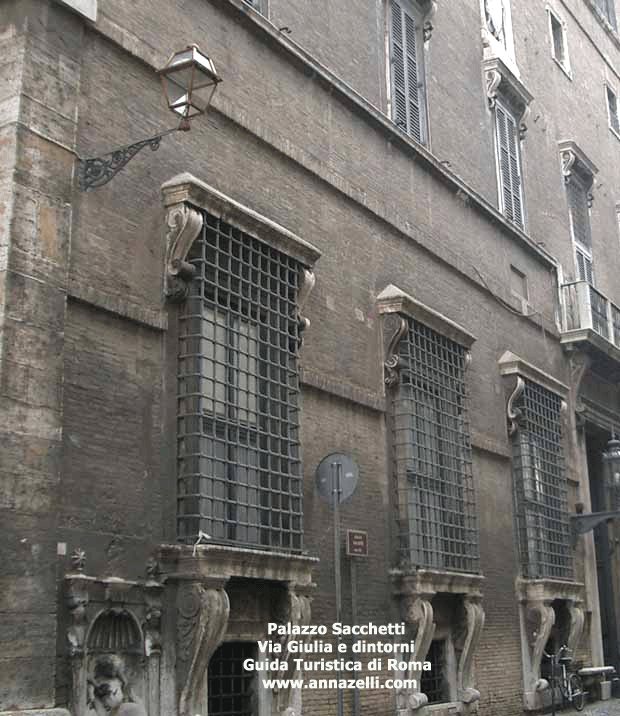
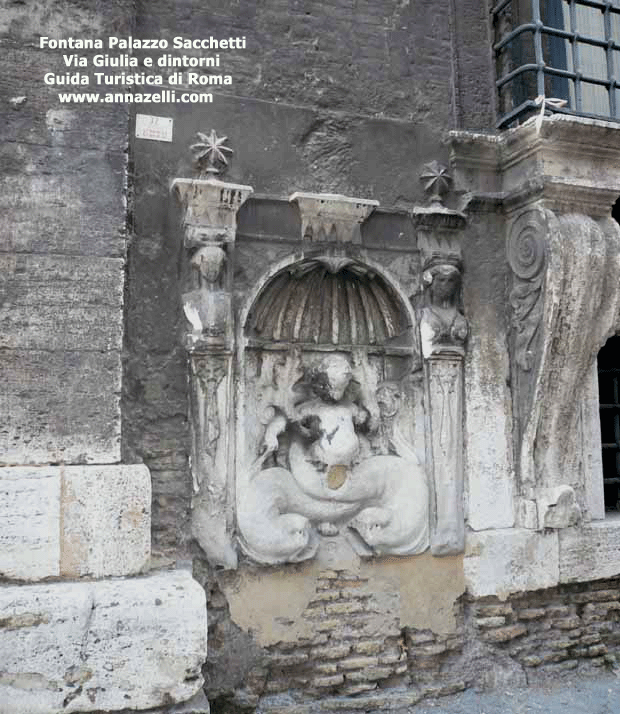





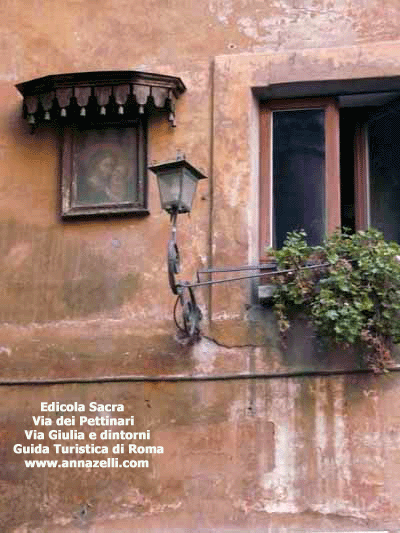






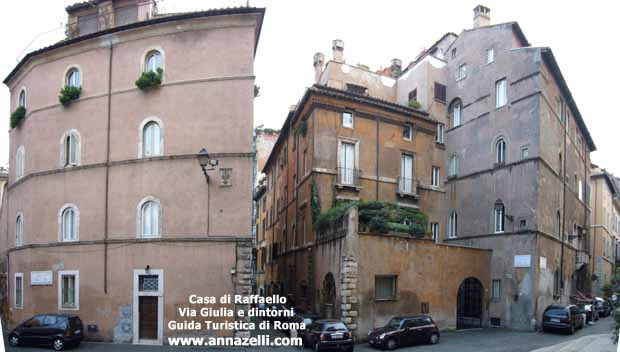
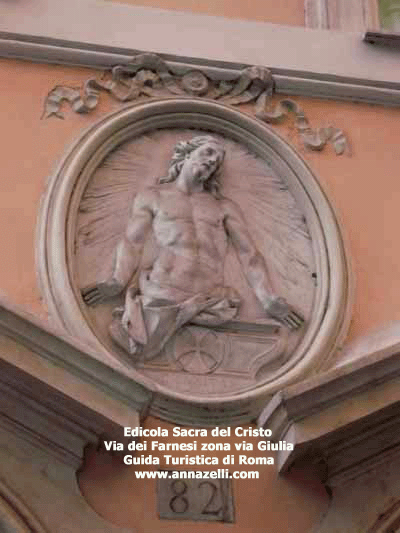
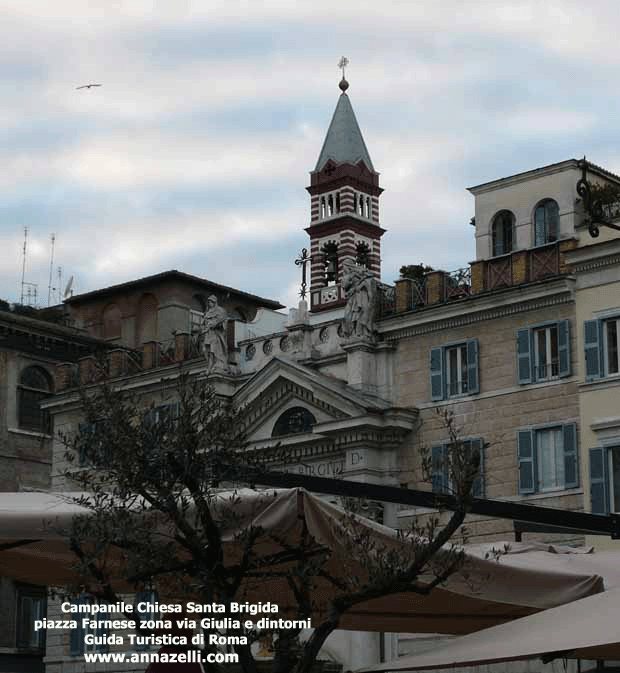

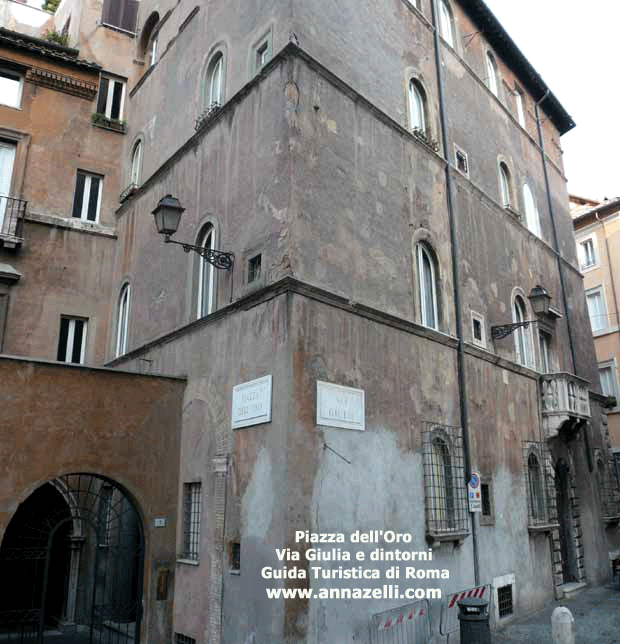




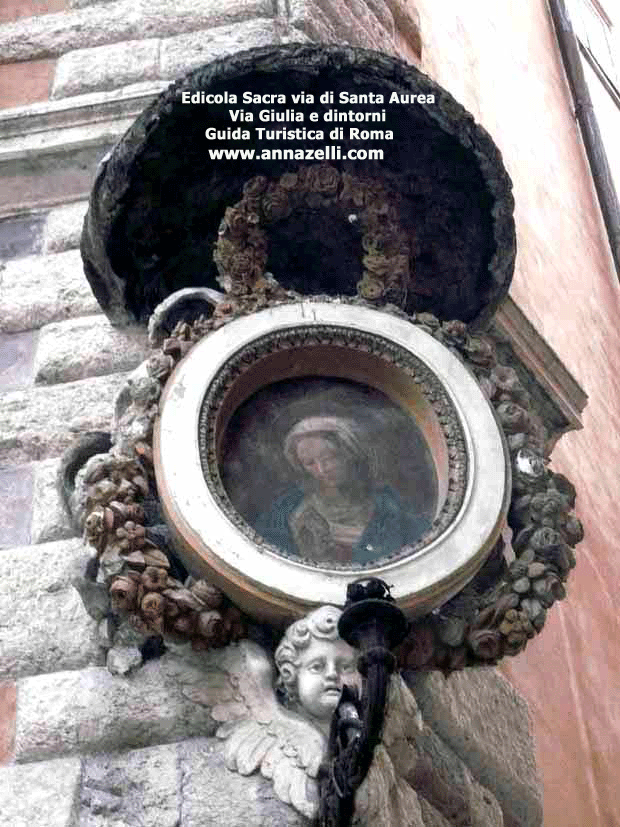





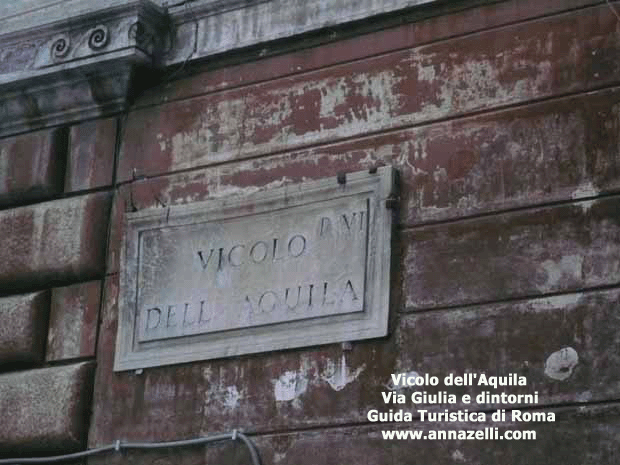








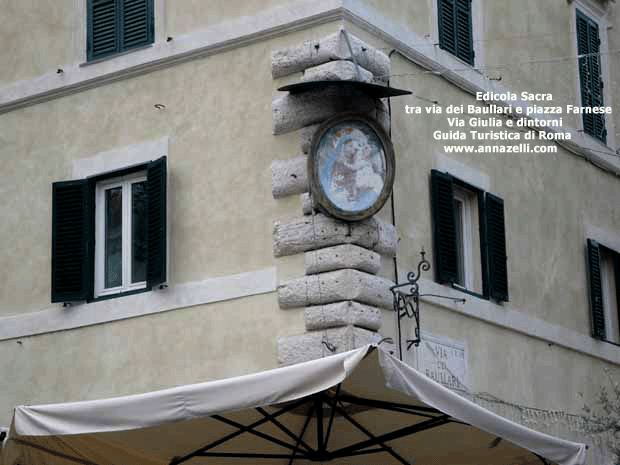















.gif)
.gif)
.gif)
.gif)

.gif)
.gif)
.gif)









.gif)