PIAZZA DI SPAGNA E DINTORNI GUIDA TURISTICA ROMA INFORMAZIONI STORICHE ARTISTICHE TURISTICHE FOTO ANNA ZELLI www.annazelli.com
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
piazza di spagna e dintorni guida turistica di roma informazioni storiche artistiche turistiche foto a cura di anna zelli Guida Turistica di Roma Informazioni Storiche Artistiche Turistiche Culturali Foto di Roma Arte Cultura Novità Idee sito web di informazione culturale artistico turistica di Roma Piazza di Spagna e dintorni (Roma) Piazza di Spagna e dintorni, piazza di Spagna, fa parte del rione Colonna e del rione Campo Marzio, la piazza è tra via Due Macelli e via del Babuino, Roma, l'edificazione dell'area risale al XVI, in quanto bisognava trovare posto alla moltitudine di pellegrini che ormai non entravano più nella Roma medioevale, pertanto fu realizzato un nuovo percorso per incanalare i pellegrini che venivano a Roma dalla parte nord della città e che dalla Porta del Popolo andavano al Vaticano. Piazza di Spagna è una delle zone più belle di Roma, frequentata anche nel passato da poeti, artisti, pittori, musicisti e da persone che amano la mondanità, ci sono i più bei negozi di moda e di gioielli, specie nella Via dei Condotti, questa è una delle strade più eleganti al mondo, c'è Bulgari che vende i più bei gioielli al mondo, il Caffè Geco, la Chiesa di Trinità dei Monti del XVI secolo, la sala da tè di Babington's, la colonna dell'Immacolata, il collegio di Propaganda Fide la cui facciata è del 1665 una delle ultime opere del Boromini., la Fondazione Keats Shelley Memorial, dove il poeta Kats morì nel 1821, la scalinata di Piazza di Spagna che è in stile Barocco e tantissimo altro. La piazza ha la forma a farfalla ed è circondata da case con alte finestre nei tipici colori ocra, crema e rosso ruggine, è sempre affollata di gente, è una delle più belle piazze di Roma, punto di riferimento per i turisti. Nel XVII secolo sulla piazza sorgeva l'Ambasciata di Spagna e la zona tutta intorno era considerata territorio spagnolo, un tempo vi erano anche molte locande e alberghi. Il toponimo deriva dal Palazzo di Spagna, che sorge sulla piazza e che fu costruito nel 1647, da Antonio del Grande, già sede della Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. e la zona tutta intorno era considerata territorio spagnolo, la zona era piena di alberghi. Piazza di Spagna un tempo, nella parte verso via del Babuino era chiamata piazza di Francia. La piazza di Spagna ha sempre avuto un grande prestigio per la magnifica scalinata di Trinità dei Monti, davanti alla scalinata c'è la fontana della Barcaccia. Fa parte della scenografia di piazza di Spagna il pubblico eterogeneo che la frequenta ad ogni ora del giorno e della notte. Piazza di Spagna è sempre stata meta turistica , ed un tempo tra le diverse locande, c'era la "Locanda della Scalinata", dove si svolgevano le riunioni framassoniche e pseudomagiche di Cagliostro, in questa locanda nel 1748 vi dimorò Casanova, al servizio del Cardinale Acquaviva. Al numero 26 di piazza di Spagna, abitò e morì nel 1821 John Keats, nella cosi detta "casina rossa", che fiancheggia la scalinata sulla destra che oggi è sede della "Shelley and Keats Memorial House". Sull'altro lato in basso vi è Babington's, un locale aperto alla fine dell'Ottocento dalle sorelle Babington, è una sala da te in caratteristico stile inglese. Su un lato della piazza di Spagna c'è la piazza Mignanelli, dove dall'8 Dicembre 1857 si eleva la colonna dell'Immacolata, eretta per proclamare il dogma della Immacolata Concezione, promulgato dal Papa Pio IX, 3 anni prima. Qui c'è anche il Palazzo di Propaganda Fide, commissionato al Bernini da Papa Urbano VIII, ma alla morte del pontefice la costruzione dell'edificio passò al Borromini, il palazzo è un vero capolavoro. Cosa c'è da vedere nella zona di Piazza di Spagna
Chiese : Sant'Andrea delle
Fratte, chiesa Trinità dei Monti, Chiesa di Ognisanti, Le chiese gemelle di
piazza del popolo Santa Maria dei Miracoli e Santa Maria in
Montesanto, Chiesa di Santa Maria del Popolo, Chiesa di San Rocco,
Chiesa di Sant'Ambrogio e di San Carlo al Corso, chiesa del Divino
Amore al vicolo del Divino Amore, Chiesa Santa Lucia della Tinta,
chiesa di Gesù e Maria, Chiesa San Giacomo in Augusta degli
Incurabili, Chiesa sant'Ambrogio e San Carlo al Corso, chiesa San
Girolamo dei Croati, chiesa di Sant'Atanasio. La Fontana della, Barcaccia a Piazza di Spagna, rione Colonna e rione Campo Marzio, Roma, è di solito seminascosta dai turisti, è opera del Bernini, una delle meno appariscenti fontane Barocche di Roma. le api ed i soli che decorano la fontana sono il simbolo di Urbano VIII Barberini che commissionò la fontana. La fontana della Barcaccia risale al 1629, opera di Pietro Bernini padre e con decorazioni di Gian Lorenzo Bernini, figlio. Sembra che la fontana sia stata edificata a forma di barca, a ricordo di una barca che qui si arenò in seguito ad una delle innumerevoli piene del Tevere. Museo Keats Shelley, piazza di Spagna 26 , rione Colonna e rione Campo Marzio, Roma, nel 1820 il poeta inglese John Keats soggiornò in questa casa rossa ai piedi della scalinata con il suo amico pittore Joseph Severn, Keats ammalato di tisi fu mandato a Roma dai medici che speravano che il clima gli giovasse alla salute, ma depresso per le severe critiche alla sua opera e per un amore non ricambiato per Fanny Brawne, morì l'anno dopo a soli 25 anni. Alla sua morte Percy Bysshe Shelley scrisse il poema Adonais, nel 1822 Shelley morì annegato nel Golfo di La Spezia. Al Cimitero Protestante di Roma sono sepolti Keats, Severn e Shelley. Nel 1906 la casa fu acquistata da una associazione Anglo-Americana, ed oggi ospita la fondazione e la biblioteca dedicata ai poeti romantici inglesi. I mobili della stanza di Keats, dove morì, per ordine del papa furono bruciati, si conservano solo alcuni cimeli. La Scalinata di Piazza di Spagna detta la scalinata di Trinità dei Monti, rione Colonna e rione Campo Marzio, Roma, nel 1600, i proprietari francesi di Trinità dei Monti, decisero di collegare la Chiesa con la piazza con una splendida scalinata, la scalinata su progetto di di Francesco De Sanctis fu terminata nel 1720, il suo andamento con tratti dritti e curvi e le terrazze, la rendono una delle scenografie più suggestive di Roma. L'idea della scalinata venne al Cardinal Mazzarino, nel 1660, ma la sua morte ne bloccò la realizzazione, il progetto venne ripreso più tardi dall'architetto De Sanctis, benchè il disegno sia attribuito a Alessandro Specchi. Nel 1725 la scalea venne inaugurata ma fu agibile solo l'anno dopo, si articola in una successione di rampe di 12 gradini ciascuna per un totale di 138, all'inizio della gradinata ci sono i cippi con i gigli di Francia e le aquile di Papa Innocenzo XIII Conti, a metà c'è un'ampia terrazza con una balaustra dalla quale si dipartono le due ultime rampe di scala a tenaglia che sboccano alla balaustra della piazza della Trinità dei Monti, con uno splendido panorama sulla città di Roma. Nel secolo scorso le donne della Ciociaria vendevano fiori sulla scalinata, prese spesso a modello di pittori. Proibita la vendita dei fiori, la piazza in primavere viene decorata dalle azalee. La scalinata si articola in una successione di rampe di 12 gradini per un totale di 138. E' una delle meraviglie di Roma, con i fiori ed i colori è una scalinata magica. Piazza della Trinità dei Monti, a Roma, fa parte del Rione IV Campo Marzio, si trova tra viale della Trinità dei Monti e via Sistina, la piazza prende il nome dalla Chiesa della Trinità dei Monti, con riferimento alle alture del Pincio ed è delimitata dalla scalinata che la collega con la piazza di Spagna. Davanti alla Chiesa della Trinità dei Monti c'è l'obelisco Sallustiano, proveniente dagli Horti Sallustiani, dove era utilizzato come spina dell'ippodromo. L'obelisco fu eretto a piazza Trinità dei Monti da Papa Pio VI nel 1789, è alto 13 metri e reca sulla cima il giglio di Francia, in omaggio alla zona un tempo sotto la giurisdizione francese, presenza ancora oggi testimoniata dalla vicina Villa Medici, sede della Accademia di Francia. La costruzione della Chiesa della Trinità dei Monti,, iniziò nel 1502 per volere di Re Luigi XII, ma terminata solo nel 1585 per opera di Papa Sisto V, venne danneggiata in epoca napoleonica, fu fatta restaurare da Luigi XVIII, la facciata è opera di Carlo Maderno, preceduta da una scala a doppia rampa di Domenico Fontana, al'interno ci sono i capolavori di Daniele da Volterra, una "Immacolata" di F. Veit e "storie del vecchio e del nuovo Testamento" di Perin del Vaga. Nel Chiostro del convento ci sono lunette ad affresco di Pomarancio e Cavalier d'Arpino. Al numero 6 della piazza c'è l'Hotel Hassler , uno dei più belli d'Europa per la posizione panoramica e la raffinatezza degli ambienti, costruito nel 1885 da impresari svizzeri, gli Hassler, fu ricostruito nel 1944 da Oscar Wirth, mantenendo il precedente nome. Vedute di Roma dalla Terrazza della Trinità dei Monti, rione Campo Marzio, Roma, da qui si gode un panorama splendido di Roma. Chiesa della Trinità dei Monti, piazza della Trinità dei Monti, rione Campo Marzio, è una delle Chiese Francesi di Roma, iniziata a costruire nel 1502, per ordine di Luigi XII, consacrata 85 anni dopo, da Papa Sisto V. Venne restaurata da Luigi XVIII in quanto era stata danneggiata dall'occupazione napoleonica, la facciata di Carlo Maderno è preceduta da una scalinata dovuta a Domenico Fontana, nell'interno conservano opere di Daniele da Volterra. La chiesa fu edificata dai francesi nel 1495, l'architettura è tardo gotica, le cappelle sono state decorate da Daniele da Volterra allievo di Michelangelo, lo stesso che per ordine di Pio IV dovette coprire le nudità ritenute scandalose del Giudizio Universale della Cappella Sistina, L'influenza di Michelangelo si nota nei corpi muscolosi della della deposizione seconda cappella a sinistra, mentre i cerchi e gli angeli che circondano la vergine ricordano lo stile di Raffaello. Edicola Sacra piazza della Trinità dei Monti, rione Campo Marzio Roma, raffigura la Madonna con il bambino. Obelisco Sallustiano della Trinità dei Monti, rione Campo Marzio, Roma, è sulla piazza della Trinità dei Monti ed è una copia di età romana, un tempo eretto da Augusto al Circo Massimo trasferito poi qui nel 1789, l'obelisco proviene dagli Horti Sallustiani, e forse era collocato su una spina dell'Ippodromo, il basamento originale in granito fu scoperto nel 1912 tra via Sicilia e via Sardegna ed oggi si trova in Campidoglio. Vedi: Obelisco Sallustiano. Vedi Obelisco Sallustiano. Vedi Obelisco Sallustiano. Hotel Hassler, al numero 6 della piazza della Trinità dei Monti, rione Campo Marzio, Roma, è il primo degli alberghi in Europa, per la posizione stupenda all'inizio di via Sistina, con una splendida terrazza che ha una delle più belle vedute su Roma. Fu costruito nel 1885 nell'area del demolito palazzo Santarelli, da proprietari svizzeri che gli diedero il nome. Nel 1944 fu ricostruito da Oscar Wirth, che ha mantenuto il precedente nome. Villa Medici, viale della Trinità dei Monti, rione Campo Marzio, Roma, la villa fu voluta dal cardinal Ricci da Montepulciano che volle una grandiosa villa sul Pincio e ne diede incarico ad Annibale Lippi nel 1544. Passò poi ai Medici, e da qui il nome, e da loro prima ai granduchi di Toscana e poi alla Francia. Nel 1803 Napoleone vi fece trasferire da palazzo Salviati l'Accademia di Francia, che è qui anche oggi. All'interno ci sono dei festoni provenienti dall'Ara Pacis, il bellissimo parco si stende lungo le mura Aureliane fino al Muro Torto. Di fronte alla Villa Medici c'è la "Vasca del Pincio" una fontana semplice, con una enorme vasca ed al centro una palla di cannone detta anche fontana della Palla, opera di Annibale Lippi. La Villa è del XVI secolo, sulla superba posizione della collina del Pincio, sopra piazza di Spagna, ha il nome del cardinale Ferdinando De Medici che l'acquistò nel 1576, dalla terrazza si vede Castel Sant'Angelo, oggi la villa ospita l'Accademia di Francia fondata da Luigi XIV nel 1666 per consentire ai giovani pittori francesi di studiare a Roma Poussin fu uno dei primi consiglieri, Ingres fu il direttore, e fra gli studenti ci furono Fragonard e Boucher. Dal 1803, l'Accademia fu aperta anche ai musicisti e vi figurano come studenti Berlioz e Debussy. La fontana della Vasca del Pincio, è di fronte a Villa Medici, rione Campo Marzio, Roma si tratta di una antica vasca circolare di granito rosso rinvenuta presso porta San Lorenzo e che per ordine del cardinale Odoardo Farnese venne collocata in un primo tempo nella piazza S. Marco oggi piazza Venezia in sostituzione di una delle due vasche termali che oggi si trova a piazza Farnese. Giacomo Della Porta tentò di usarla come base per la statua di Marforio e venne addossata al palazzetto Venezia ornata con un'edicola marmorea, poi intorno al 1860 la vasca venne trasferita al Pincio e quindi, nel 1941, nuovamente spostata, ma di poco, nell'attuale via e inserita al centro di un vasto bacino circolare, rialzato da terra, con ampio bordo arrotondato in travertino. Il fine estetico della vasca era quello di non far vedere il parapetto del muraglione verso il Muro Torto. La fontana del Bottino, scendendo da Trinità dei Monti sul lato della via San Sebastianello, si può ammirare la Fontana del Bottino, ornata da un bel sarcofago. Pincio e Villa Borghese, i giardini del Pincio e di Villa Borghese. I giardini del Pincio furono disegnati da Valadier agli inizi del XIX secolo, che ridisegnò anche la Piazza del Popolo, i viali sono pieni di pini e di palme, il pincio è un bellissimo posto per rilassarsi e fare delle passeggiate, dalla terrazza del Pincio, Piazzale Napoleone I, si gode uno splendido panorama di Roma, che spazia da Monte Mario al Gianicolo, la casa Valadier fu frequentata da personaggi famosi della storia come Mussolini, Gandhi, Strauss, Re Faruk, ora nella casina Valadier c'è un esclusivo caffè e ristorante con giardino. L'ora del tramonto è l'ora migliore per godere il panorama di Roma. Da notare nel parco di Villa Borghese, è l'obelisco egizio, fatto erigere dall'imperatore Adriano sulla tomba del suo schiavo favorito Antinoo, che sembra sia morto prematuramente per salvare la vita dell'imperatore Adriano.In Via dell'Orologio c'è un orologio ad acqua progettato da un monaco domenicano nel XIX secolo, e presentato all'Esposizione di Parigi del 1889. Il Pincio o colle Pinciano, dal latino mons Pincius è un colle di Roma, non incluso nei 7 colli. Il colle si trova a nord del Quirinale, e guarda sul Campo Marzio. Diverse ville e giardini occupano il colle, compresa Villa Borghese. Da piazzale Napoleone I, in cima al colle, c'è un ampio panorama su piazza del Popolo e sul rione Prati, che sorge su quelli che, fino alla fine dell'800, erano i Prati di Castello. viene ancora detto "il Pincio" la parte di Villa Borghese all'interno delle Mura aureliane, dalla terrazza su piazza del Popolo a Villa Medici. Il Pincio è il primo giardino pubblico di Roma, voluto da Napoleone tra le passeggiate storiche è la più cara ai romani.La sistemazione odierna è dovuta al Valadier che, su richiesta di Pio VII unì il colle più bello della città alla porta Flaminia e a piazza del Popolo in un unicum neoclassico, simmetrico. Sono da ammirare l'Obelisco di Antinoo, la Casina Valadier, il laghetto del Pincio, i busti all'interno dei giardini, le fontane, l'orologio ad acqua, e la villa Borgese.Vedi : Colle del Pincio e obelisco di Antinoo. Via Condotti, Roma, va da piazza di Spagna a Largo Goldoni, rione Campo Marzio, Roma, il nome deriva dalle condotte che portavano l'acqua alle terme di Agrippa che si trovavano vicino al Pantheon, ospita i negozi dei più importanti e famosi stilisti italiani, ci sono negozi di Hermes, Ferragamo, Gucci, Beltrami e tantissimi altri. Nella parallela via Borgognona ci sono gli Ateliers di stilisti come Fendi, Ferrè, Versace, i negozi di Valentino sono a Via Bocca di Leone e a Via Mario de Fiori, Armani ha il suo emporio a Via del Babuino, la via di gallerie d'arte, antiquari ed esclusivi negozi d'arredamento. Caffè Greco, Via Condotti 86, rione Campo Marzio, Roma, Il caffè fu aperto da un greco e da qui il nome, nel 1760, per tutto il XVIII secolo fu frequentato da artisti stranieri, da scrittori, da poeti come Keats, Byron e Goethe, da compositori come List, Wagner, Bizet, clienti abituali erano anche Casanova, e Ludovico di Baviera, il locale ha le foto dei più famosi clienti che hanno frequentato questo Caffè. Colonna dell'Immacolata, andando sul lato destro ai piedi della scalinata verso la piazza Mignanelli, rione Campo Marzio, Roma, c'è una colonna che fu eretta ed inaugurata nel 1857 da Papa Pio IX per sancire il dogma della Immacolata concezione, dove si stabilisce che solo la Vergine Maria sia stata l'unica persona del genere umano a nascere senza il peccato originale, la colonna appartiene all'epoca romana, ed è uno dei monumenti pagani convertiti alla cristianità, sulla cima della colonna si erge la statua della Madonna. Collegio di Propaganda Fide, Via di Propaganda 1, rione Campo Marzio, Roma, fu costruito nel 1662 per i Gesuiti, quando erano al culmine del loro potere.E' stata l'ultima opera del Borromini, è notevole l'andamento mosso della facciata, purtroppo il Borromini si suicidò poco dopo averlo portato a termine. Via Margutta, va da via del Babuino a via Alibert fa parte del rione Campo Marzio, Roma, prima si chiamava via dei Nari, cambiò il nome in Margutta o per via di un barbiere soprannominato Margutte che viveva nel 1526 nel rione Sant'Eustachio, , che significava tonto, brutto, o persona sbucata da chissà dove, o per la famiglia Marguti che si era stanziata a Roma dal XV secolo. La via è celebre per le botteghe degli artisti, sembra che qui vi abbia dimorato il pittore Orazio Gentileschi, è caratterizzata da piccoli e bassi edifici ricoperti di edera, di fiori e di verde. Negli anni cinquanta, dopo il film Vacanze romane, via Margutta diventa una strada esclusiva, residenza di personaggi famosi, tra cui Federico Fellini e Giulietta Masina, Anna Magnani, Giorgio de Chirico. Fontana degli Artisti, via Margutta, rione Campo Marzio, è situata ungo la via è in marmo, a base triangolare, è sormontata da un secchio di pennelli, in relazione alla presenza degli artisti prevalente in questa via sin dal XVII secolo. La fontana venne realizzata nel 1927 su progetto dell'architetto Pietro Lombardi, che realizzò altre fontanelle allusive agli stemmi dei rioni o alle attività dei luoghi di Roma. I due mascheroni centrali, uno triste ed uno lieto simboleggiano l'alterno stato d'animo degli artisti, e poggiano su mensole applicate su cavalletti da pittore, zampillano il getto d'acqua in due piccole vasche sottostanti. Via Sant'Andrea delle Fratte, va da via della Mercede a via del Babuino, rione Colonna, Roma, prende il nome dalla chiesa Omonima. Il nome della via deriva dal fatto che fino al 1500 la zona era situata in mezzo ad orti e fratte. Basilica di Sant'Andrea delle Fratte, Via di Sant'Andrea delle Fratte 1 rione Colonna, Roma, la chiesa risale al XII secolo, si chiama fratte perchè si trovava all'interno di un boschetto, fu completamente ricostruita nel XVII secolo, in gran parte dal Borromini, Il Campanile e la cupola si vedono meglio da Via Capo le case, all'interno della chiesa si trovano gli angeli del Bernini. Via del Babuino, va da piazza del Popolo a piazza di Spagna, fa parte del rione Campo Marzio Roma, è una antichissima e famosa strada del centro storico di Roma, alla fine dell'XI secolo vi si stabilì una colonia di Napoletani e la via si chiamò Orto di Napoli per il primo tratto mentre l'altro si chiamava via del Cavalletto, che era una sorta di supplizio per i condannati. La via venne risistemata nel 1525 da papa Clemente VII e si chiamò via Clementina, notevoli cambiamenti si ebbero con papa Paolo III e da allora si chiamò via Paolina, nel 1576 assune l'attuale nome di via del Babuino. Il toponimo le deriva dalla statua di un sileno che papa Gregorio XIII fece addossare al palazzo al numero 51 della via come ornamento ad una fontana, la statua è talmente brutta e deforme che venne battezzata er babuino. Fontana del Babuino, via del Babuino, rione Campo Marzio, Roma, il Babuino fa parte di una delle sei statue parlanti di Roma, raffigura un sileno giacente su una base rocciosa, chiamato dal popolo di Roma “er babuino” perché così brutto e deforme da non poter essere paragonato nemmeno ad una scimmia. La fontana venne eretta nel 1571 da Papa Pio V, ed era alimentata dall'acquedotto Vergine da lui ripristinato dopo le devastazioni dei barbari, era addossata al palazzo del nobile Alessandro Grandi, in quel tempo la via si chiamò via Paolina. La statua era ad ornamento di una vasca quadrangolare, vi erano anche dei delfini simbolo araldico di Papa Gregorio XIII Buoncompagni, oggi scomparsi, palazzo che era stato acquistato appunto dal papa, infatti la statua era inserita in una nicchia delimitata da due lesene i cui capitelli sostenevano la cornice superiore su cui erano posti i due delfini. A causa di questa statua la via cambiò il nome da via Paolina a via del Babuino. La statua del Babuino venne presto annoverata tra le “statue parlanti” di Roma, e come le altre cinque è stata la “voce” di diverse pasquinate, violente e spesso irriverenti satire indirizzate a colpire anche pesantemente e sempre in modo anonimo i personaggi pubblici più in vista nella Roma a partire dal XIV secolo. Più che pasquinate le sue erano definite babuinate, ma il contenuto era lo stesso. A causa dei lavori per la costruzione della rete fognaria, nel 1877 l’intero complesso venne smembrato: la vasca fu utilizzata per un’altra fontana in via Flaminia, mentre la statua venne riposta all’interno del palazzo ex Buoncompagni. Solo nel 1957, a seguito di una campagna di recupero portata avanti da alcuni cittadini romani, il Sileno è tornato nella via che della statua aveva preso il nome, e si trova ora a fianco della chiesa di Sant’Atanasio dei Greci, ancora ridotta al rango di elemento decorativo dell’antica vasca, anch’essa recuperata, dove un tempo si abbeveravano i cavalli. Della nicchia con lesene, della cornice e dei delfini, non si hanno più tracce, mentre dopo l’ultimo restauro del 2007 è stata posizionata intorno alla fontana un’inferriata sorretta da due colonnine in pietra. Chiesa di San Atanasio, Via del Babuino rione Campo Marzio, Roma, chiesa con rito Greco, fondata nel 1573 quando papa Gregorio XIII istituì la Congregazione dei Greci, che propose la fondazione di un Collegio Greco per la formazione religiosa del clero cattolico di rito orientale. Il Collegio fu fondato nel 1577 ed aveva l’entrata in via dei Greci, poi fu spostata in via del Babuino. Nel 1580 venne posta la prima pietra della chiesa dei Greci dedicata ad Atanasio, vescovo di Alessandria, la cui costruzione venne affidata a Giacomo della Porta che la portò a termine nel 1583. Sino al 1872 la chiesa fu officiata secondo il rito romano ed il Rito Greco, quando si decise di affidarla definitivamente alla Congregazione per le Chiese Orientali. In questa occasione fu rimossa l'iconostasi lignea di Francesco Traballesi (molti dei cui dipinti furono conservati, e si trovano tuttora nel Collegio adiacente alla chiesa) e fu affidata all'architetto pontificio Andrea Busiri Vici la nuova sistemazione interna della chiesa. In tale occasione fu costruita la nuova iconostasi e la parte inferiore dell'abside fu rivestita in marmi bianchi e grigi. La facciata della chiesa di Sant'Atanasio fu completata da Martino Longhi il Vecchio, è suddivisa in due ordini, nell'ordine inferiore, si trovano il portale e due nicchie, in quello superiore, vi sono il grande finestrone e due iscrizioni, una in lingua greca e l'altra in lingua latina in onore di Sant'Atanasio, la chiesa è preceduta da una breve scalinata, in alto è inquadrata da due campanili coperti da cupolette, sopra il campanile di sinistra è collocato un orologio donato da Papa Clemente XIV nel 1771 che non è rivolto verso via del Babuino, ma verso il palazzo del Pontificio Collegio Greco. Sopra via dei Greci, che costeggia il fianco sinistro della chiesa, si trova un passaggio ad arco che conduce nel palazzo del Pontificio Collegio Greco. L’interno della chiesa di Sant'Atanasio è a croce latina con navata unica ed una cappella per lato ,la volta è a botte; la pianta si presenta a “trifoglio”, ossia con due absidi ai lati e una di fondo, secondo uno schema di derivazione bizantina, che costituisce un esempio raro nell’architettura romana. La decorazione interna inizialmente fu affidata a Francesco Traballesi, nato a Firenze nel 1541 e morto a Mantova nel 1588, al quale spettano gli affreschi nelle cappelle laterali, raffiguranti l’Annunciazione a destra e Gesù fra i dottori del Tempio a sinistra, nonché la primitiva iconostasi lignea, i cui frammenti sono conservati nel Collegio greco. Al Traballesi subentrò nel 1585 il Cavalier d'Arpino, al quale si devono gli affreschi con l’Assunzione di Maria e la Crocifissione che si trovano nell'abside di destra e di sinistra. Chiesa di Ognisanti, All Saints, Via del Babuino, rione Campo Marzio, 153 B, Roma rito anglicano, in lingua inglese. Nel 1816 il Papa accordò ai visitatori inglesi il diritto di praticare il culto anglicano a Roma, ma solo nel 1880 fu acquistato il terreno per edificare la Chiesa, l'autore fu l'architetto inglese G.E. Street, conosciuto in patria per le chiese neogotiche, ed il palazzo di giustizia di Londra. La chiesa conserva una atmosfera inglese, Casa di Goethe, Via del Corso 18-20, Roma il poeta, drammaturgo, romanziere tedesco Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), visse in questa casa dal 1786 al 1788, lavorando al suo diario che divenne un libro "Viaggio in Italia". Chiesa di Gesù e Maria a Via del Corso rione Campo Marzio, Roma, chiamata e dei Santi Nomi di Gesù e Maria è una chiesa barocca di Roma che occupa parte di un terreno, oggi compreso tra le vie : via del Corso, via di Gesù e Maria, via del Babuino e via di San Giacomo, su cui, agli inizi del XVII secolo sorgeva una villa con giardino di proprietà di Antonio Orsini, nipote del cardinale Flavio Orsini. Il terreno ed i suoi fabbricati furono acquistati dagli Agostiniani scalzi nel 1615, per costruirvi la loro nuova sede romana e la casa per la formazione dei seminaristi. La chiesa fu costruita successivamente all’acquisto, in due epoche diverse; nel frattempo, funzionava una piccola cappella dedicata a sant'Antonio abate, che affacciava su via del Babuino (in corrispondenza dell’attuale chiesa anglicana di All Saints) e che fu in seguito distrutta. La costruzione iniziò con la posa della prima pietra il 3 aprile 1633 e la prima tranche di lavori, su progetto di Carlo Buzio, fu ultimata sul finire del 1635: il 17 gennaio 1636 avvenne il solenne trasloco dalla chiesetta di sant'Antonio alla nuova chiesa, che fu dedicata ai nomi di Gesù e Maria. La chiesa, che mancava della parte finale e della facciata, fu ultima una trentina di anni dopo, sotto la direzione di Carlo Rainaldi, tra il 1671 ed il 1674: il 28 gennaio 1675 fu solennemente consacrata, come ricorda una lapide murata per l’occasione in sacrestia. Fra il 1678 ed il 1690 fu messa in opera la decorazione interna dell’edificio sacro ed il suo totale rivestimento in marmo, grazie alla munificenza del vescovo di Rieti, Giorgio Bolognetti. La chiesa è sede del titolo cardinalizio di “Santissimi Nomi di Gesù e Maria in Via Lata”, istituito da papa Paolo VI il 7 giugno 1967. La facciata della chiesa, di Carlo Rainaldi, è in travertino e mattoni. L’unico portale d’ingresso è sormontato da un timpano a lunetta e da un finestrone rettangolare; è affiancato da quattro lesene corinzie, che sostengono la trabeazione con la scritta Iesu et Mariae, ed un grande timpano triangolare di coronamento. La chiesa è ad un’unica navata, con volta a botte e tre cappelle per lato. Il presbiterio e l’altare maggiore si caratterizzano per l’imponenza e la ricchezza dei materiali utilizzati. La tela d’altare è di Giacinto Brandi e rappresenta Gesù che incorona Maria de 1679. Chiesa di San Giacomo in Augusta degli Incurabili a Via del Corso, Roma si trova presso il dismesso ospedale omonimo. L’attuale chiesa risale ad una piccola cappella dedicata nel 1347 a san Giacomo apostolo nello stesso anno in cui quando venne fondato l’Ospedale di san Giacomo degli Incurabili, chiamato così perché vi si assistevano gli ammalati di malattie non curabili negli altri ospedali romani. La chiesa si chiama in Augusta per la presenza nelle vicinanze del Mausoleo di Augusto; la progettazione dei lavori venne affidata all’architetto Francesco Capriani da Volterra, cui subentrò nel 1598 Carlo Maderno che terminò i lavori nel 1602. Nel 1824 Leone XII eresse la chiesa a parrocchia del rione. Trasformata in stalla durante la Repubblica Romana del 1849, perse gran parte delle opere e dell’arredo, bruciato in piazza del Popolo. Il restauro successivo, voluto da Pio IX comportò il rifacimento della tinteggiatura di tutta la chiesa, la messa in opera dell’affresco della volta, e il pavimento marmoreo del 1863. La chiesa presenta, all’esterno, due campanili gemelli a fianco dell’abside. L’interno è a pianta ellittica con tre cappelle per lato. La volta fu affrescata da Silverio Capparoni e raffigura la Gloria di san Giacomo. L’altare maggiore è opera di Carlo Maderno, eretto con marmi provenienti dal vicino Mausoleo di Augusto; la pala d’altare è di Francesco Grandi (1831-1891) e rappresenta la Santissima Trinità. Nella cappella della Madonna dei Miracoli è conservata l’immagine sacra, a cui fu attribuito un miracolo che dette origine alla Chiesa di Santa Maria dei Miracoli in piazza del Popolo. Nelle altre cappelle della chiese vi sono opere seicentesche di Giuseppe Passeri, del Pomarancio, di Antiveduto Gramatica, di Domenico Cresti, detto il Passignano. Ospedale San Giacomo in Augusta degli Incurabili, dismesso, via del Corso Roma chiamato così perché vi si assistevano gli ammalati di malattie non curabili negli altri ospedali romani. È in questo ospedale che fu curato san Camillo de Lellis, ed è qui che ebbe l’intuizione di fondare l’ordine che porta il suo nome e che è dedito alla cura degli ammalati. Nel 1579 iniziò l’integrale ricostruzione dell’ospedale ad opera del Cardinale Antonio Maria Salviati, lo stesso che nel 1592 fece iniziare la totale ricostruzione e ampliamento della chiesa di san Giacomo. L'Ospedale, venne eretto nel 1339 dagli esecutori testamentari del cardinale Pietro Colonna, fu chiamato San Giacomo in memoria dello zio cardinale Giacomo, avversario di Bonifacio VIII. Al nome San Giacomo fu aggiunto "in Augusta" in quanto l'edificio si trova vicino al Mausoleo di Augusto, allora trasformato in una fortezza posseduta dai Colonna. La posizione dell'ospedale fu scelta in base alla funzionalità del luogo, vicino alla porta Flaminia dalla quale entravano a Roma tanti pellegrini, provenienti dalle vie Cassia e Flaminia, bisognosi di cure dopo il lungo viaggio. Non si sa nulla del trecentesco edificio rettangolare che sorgeva lungo la via di San Giacomo oggi via Canova, allora assai più ampia. Nel 1451 il funzionamento fu affidato alla Compagnia del Divino Amore, che chiese a Leone X di riservare un ospedale ai malati di sifilide, il male diffuso a Roma dall'esercito di Carlo VIII ed allora ritenuto incurabile: la scelta cadde sul San Giacomo, che aveva una posizione decentrata rispetto alla città. La Compagnia si mutò allora in "Confraternita di S.Maria del Popolo e di S.Giacomo degli Incurabili": a questo scopo l'ospedale fu completamente ristrutturato tra il 1519 ed il 1525 su progetto di Antonio da Sangallo il Giovane e Baldassarre Peruzzi. Nel Cinquecento l'ospedale fu diviso in due corpi uno per le donne ed uno per gli uomini ed ebbe anche un cimitero. Vi era annessa anche una "spetiaria" con un esperto di "untioni servitiali". In quel triste ambiente di incurabili si prodigarono San Filippo Neri, San Gaetano da Thiene, San Camillo del Lellis, oltre a suore e frati. Nel Settecento il San Giacomo fu ulteriormente ristrutturato e divenne ospedale generico per ogni genere di malattie. Determinanti gli ampliamenti effettuati a metà dell'Ottocento secondo un progetto di Pietro Camporese il Giovane: la facciata principale rimase quella su via Canova ma la soluzione architettonica più ariosa divenne quella nuova, sul Corso, dove si ebbe il prospetto delle due testate delle corsie che inquadrano la chiesa di San Giacomo, caratterizzate da due ampie e finte logge. Via di Ripetta, Roma, la passeggiata di Ripetta va da piazza Augusto Imperatore a lungotevere Arnaldo da Brescia, mentre la via di Ripetta va da piazza del Popolo a via del Clementino, fanno parte del rione Campo Marzio e del Quartiere Flaminio. Ricordano entrambe l'antico e scomparso porto di Ripetta, ricordato a piazza del Porto di Ripetta con la Fontana . Vedi Porto di Ripetta. Piazza Augusto Imperatore, a Roma, fa parte del Rione Campo Marzio, si trova tra Largo San Rocco e via dei Pontefici, la piazza è dedicata a Cesare Ottaviano Augusto, nato a Roma nel 64 a.C e morto nel 14 d.C. che qui eresse il mausoleo e sepolcreto per se e la sua famiglia. In epoca fascista per ridefinire la piazza vennero abbattuti edifici storici, e vennero edificati nuovi e moderni palazzi, che hanno dei portici, su progetto dell'architetto Vittorio Ballio Morpurgo, sulla piazza vi vede l'abside della Chiesa di San Carlo e Ambrogio al Corso, che si affaccia sull'omonimo Largo, davanti all'abside ci sono due monumentali statue marmoree che ricordano San Carlo Borromeo scolpito da Selva, e Sant'Ambrogio scolpito da Dazzi. Il Mausoleo di Augusto, che si trova sulla piazza, ebbe varie denominazioni, derivanti dalla corruzione di "Augusta", come Austa, Langosta, Hausta, Lagusra, e Agosta, qui i Colonna trasformarono il mausoleo in roccaforte, che venne smantellata nel 1241 da Papa Gregorio IX. Per l'incuria in cui versa il mausoleo di Augusto, i romani lo hanno ribattezzato "er dente cariato". Il monumento ha una otevole rilevanza storica per la sua forma che ricorda gli antichissimi tumuli etruschi, la sua destinazione iniziale era quella di ospitare le ceneri di Augusto, della moglie Livia, della sorella Ottavia, del nipote Caio, di Lucio e Marcello, che la morte colpì in giovane età. Qui furono sepolti anche il genero di Augusto Agrippa, il figliastro Druso, Germanico, Tiberio, Agrippina, Claudio, Britannico, Nerva e Giulia Donna, moglie di Settimio Severo, vi venne cremato anche Cola di Rienzo morto nel 1354. Il monumento divenne cava di travertino, e venne gravemente distrutto. Nel tempo divenne poi anche vigna e giardino, arena per le giostre di vaccine e bufale, corride di tori, e spettacoli di fuoco d'artificio. Divenne anfiteatro quando il mausoleo passò come proprietà dei Marchesi Correa, che imposero all'arena il nome della famiglia, che in romanesco divenne Anfiteatro Corea, il nome divenne di nuovo Mausoleo di Augusto, quando questi passò al demanio pubblico italiano. Venne poi gestito come arena per gli spettacoli diurni, sotto re Umberto, che gli cambiò il nome e lo chiamò anfiteatro Umberto, ma dal 1888, venne negata l'agibilità del luogo, per il pericolo di incendi, quindi il mausoleo divenne un magazzino, fu usato per modellare la statua equestre di Vittorio Emanuele II per l'altare della patria, poi passò al Comune di Roma, venne ristrutturato nel 1905, e adibito a sala per concerti, con il nome di Politeama Augusteo, e così rimase fino al 1930, quando la sala venne demolita per il rinnovamento della piazza., il mausoleo assunse quindi la sua forma originaria diventando definitivamente monumento archeologico. Ara Pacis,Via di Ripetta rione Campo Marzio, Roma, recentemente restaurata è uno dei monumenti più importanti dell'Antica Roma, Ara Pacis, significa Altare della Pace, celebra la pace realizzata da Augusto nell'area del Mediterraneo, dopo le vittoriose campagne in Gallia e in Spagna. Il monumento fu commissionato dal senato nel 13 a.C. e completato nel 17 a.C. E' un recinto quadrato posto su una bassa base con al centro l'Altare. Tutte le superfici sono di Marmo di Carrara, scolpite con fregi e rilievi. Data la raffinatezza probabilmente gli artisti erano dei greci.Un lato raffigura una processione svoltasi il 4 luglio del 13 a.C. dove si riconoscono i membri della famiglia imperiale disposti in successione gerarchica. L'erede era ritenuto allora Marco Agrippa marito della figlia di Augusto, Giulia. Tutti i ritratti sono improntati a grande realismo. Il ritrovamento dell'Ara Pacis inizia nel XVI secolo, quando furono ritrovati i primi pannelli, una parte di questi fini a Parigi ed un'altra a Firenze, e dal 1938 si iniziò l'opera di ricomposizione dell'intero monumento. L'altare al centro era sacrificale in occasione della inaugurazione del monumento. Fontana dell'Ara Pacis via di Ripetta, rione Campo Marzio, Roma è un insieme di16 zampilli che emergono da dei bassi muretti di travertino posti ai lati che secondo l’architetto Meyer, rappresenterebbe una barriera visiva e sonora tra la nuova piazza ed il traffico sul lungotevere anche se il nuovo complesso stride con tutte le altre memorie storiche che circondano l'Ara Pacis. Mausoleo di Augusto Piazza Augusto imperatore, rione Campo Marzio, Roma, il posto è una collinetta con cipressi che nel 28 a.C. divenne la tomba di Augusto e dei suoi discendenti. L'edificio del Mausoleo era di forma circolare con 2 obelischi posti all'ingresso della tomba ( oggi si trovano uno a piazza dell''Esquilino e l'altro a Piazza del Quirinale) All'interno 4 anelli concentrici dove erano collocate le ceneri della famiglia imperiale. Il primo ad esservi seppellito fu Marcello il nipote preferito da Augusto che aveva sposato Giulia la figlia di Augusto, che morì nel 23 a.C., fu probabilmente avvelenato da Livia seconda moglie di Augusto, che riteneva suo figlio Tiberio più degno di diventare imperatore. Augusto morì nel 14 a.C.e le sue ceneri furono collocate nel mausoleo. Chiesa di Sant'Ambrogio e di San Carlo al Corso, Via del Corso 437 rione Campo Marzio, Roma. la Chiesa apparteneva alla comunità lombarda di Roma, ed è dedicata ai due vescovi canonizzati di Milano. Nel 1471 Papa Sisto IV donò la chiesa ai Lombardi che la dedicarono a Sant'Ambrogio morto nel 397. Quando nel 1610 Carlo Borromeo fu canonizzato la chiesa fu ricostruita in suo onore. Gran parte della nuova chiesa fu realizzata dagli 'architetti Onorio e Martino Longhi, padre e figlio, metre la bella cupola è opera di Pietro da Cortona.La pala d'altare "Gloria dei Santi Carlo e Ambrogio" è opera di Carlo Maratta (1625-1713), dietro l'altare vi è un corridoio che conduce ad un reliquiario dove è custodito il cuore di San Carlo. Statua di San Carlo a destra e statua di Sant'Ambrogio a sinistra, rione Campo Marzio, Roma, sono visibili a piazza Augusto Imperatore e fanno parte della chiesa di San Carlo e Ambrogio al Corso. Fontanella a Via della Tribuna di San Carlo Roma, si trova sulla via che va da piazza Augusto Imperatore al Largo dei Lombardi, rione Campo Marzio, la via prende il nome dalla tribuna, l'abside, della chiesa dei Santissimi Carlo e Ambrogio al Corso Questa piccola fontanella settecentesca venne trasferita qui nel 1872, proviene dalla facciata di palazzo Vitelli al Corso. La fontanina è formata da una piccola vasca trilobata di forma rigonfia al di sopra una testa che dovrebbe immettere acqua dal foro centrale, ma al momento è inattiva. Architettura dell'epoca fascista a Piazza Augusto Imperatore Roma, rione Campo Marzio, questa piazza venne realizzata in epoca fascista demolendo le antiche strade, ed edificando edifici moderni, con portici opera dell'architetto Vittorio Ballio Morpurgo. La zona vide la scomparsa del porto di Ripetta e la risistemazione di Largo Sa Rocco. Largo San Rocco va da via di Ripetta a piazza Augusto Imperatore, rione Campo Marzio, Roma, prende il nome dalla chiesa omonima che si affaccia su via di Ripetta, incastrato sul muro vi è un igrometro messo qui nel 1821 che si trovava al porto di Ripetta, la fontana del porto oggi è nella nuova piazza del porto di Ripetta.
Chiesa di San Rocco, Largo San
Rocco rione Campo Marzio, Roma, la facciata neoclassica è del
Valadier, in origine era la cappella di un ospedale del XVI secolo
con 50 posti letto, San Rocco guariva gli appestati, cui era stata
aggiunta un'ala per le mogli dei barcaroli del Tevere per evitare
che partorissero sulle barche in condizioni malsane. L'ospedale fu
poi utilizzato per ospitare le ragazze madri, ed una sezione era per
le donne che volevano mantenere l'anonimato, potevano anche tenere
un velo per tutta la loro permanenza, i bambini indesiderati
venivano inviati in un orfanatrofio, e se la madre e il bambino
morivano, venivano sepolti in tombe anonime, l'ospedale fu
abbandonato alla fine del secolo e demolito negli anni 30, durante
gli scavi del Mausoleo di Augusto, nella pala d'altare, all'interno
della chiesa, si può ammirare un'opera barocca del Baciccia che
decorò anche il soffitto della Chiesa del Gesù. Chiesa di San Girolamo dei Croati, Via di Ripetta Roma, si trova di fronte all'Ara Pacis, è la chiesa nazionale dei croati di Roma è anche nota con i nomi antichi di San Girolamo degli Illirici e San Girolamo degli Schiavoni. È chiesa rettoria di San Lorenzo in Lucina e titolo cardinalizio. La chiesa venne fondata in quanto nella zona, prospiciente lo scomparso porto di Ripetta, si era insediata fin dal XIV secolo una comunità di profughi sfuggiti ai Turchi dall'Illiria e dalla Schiavonia, ai quali papa Niccolò V concesse nel 1453 l'istituzione di una Congregazione di San Girolamo degli Schiavoni, dotata di un ospizio, di un ospedale, e di una piccola chiesa dell'XI secolo, originariamente chiamata Santa Marina de Posterula, da intitolare a san Girolamo, di ascendenze dalmate. Nel secolo successivo papa Sisto V, già titolare della chiesa, la fece ricostruire interamente da Martino Longhi il Vecchio tra il 1588 e il 1589, dotandola di un campanile e di ricchi arredi. I marmi per la facciata furono spogliati dal Settizonio. Papa Sisto vi istituì, anche, un capitolo che doveva espressamente essere costituito da preti di provenienza slava. Avrebbe anche voluto portarvi il corpo di san Girolamo dalla basilica di Santa Maria Maggiore, ma non riuscì a dar seguito al suo proposito. Nel XIX secolo la chiesa è stata restaurata da papa Pio IX. La chiesa di San Girolamo dei Croati è affiancata dalla chiesa di San Rocco. La zona dopo l'Unità d'Italia ha visto la demolizione del porto di Ripetta e la sistemazione dei muraglioni e del lungoteveri recentemente vi sono stati lavori di risistemazione della Ara Pacis, inglobata in una struttura ultra moderna, che contrasta con la storia della zona. Fontana a via di Ripetta rione Campo Marzio Roma, si tratta di una vasca che al momento è disattiva. Fontana a piazza del Porto di Ripetta, rione Campo Marzio, Roma, era la fontana dello scomparso porto di Ripetta chiamata anche fontana del Navigatore o dei Navigatori è stata trasferita a piazza del Porto di Ripetta ai primi del ’900 quando, per l'allargamento degli argini del Tevere, venne smantellato l’omonimo porto fluviale di Roma. Vedi Porto di Ripetta. Vedi Porto di Ripetta. Largo della Fontanella Borghese, rione Campo Marzio, Roma, è tra piazza Borghese e via di Fontanella Borghese ed arriva a Largo Goldoni, il toponimo deriva da una piccola fonte che era su un lato del palazzo Borghese che era ad uso pubblico e che venne riattivata da Papa Gregorio XVI, ma di questa oggi non ne rimane traccia, probabilmente venne demolita, qui si affaccia lo splendido palazzo Borghese. Palazzo Borghese Fondazione Checchi Gori si affaccia su piazza della Fontanella Borghese e su via di Ripetta Roma, il Palazzo fu acquistato dal Cardinale Camillo Borghese nel 1605, poco prima di diventare Papa Paolo V, la collezione dei dipinti fu acquistata dallo Stato Italiano e trasferita al Museo di Villa Borghese. Piazza del Popolo, Roma la forma della grandissima piazza è ovale, in un tridente di vie, che sono una importante via di accesso al cuore di Roma: Piazza del Popolo si è formata nel corso dei secoli, nel 1589 Papa Sisto V fece erigere da Domenico Fontana, l'obelisco egizio al centro della piazza, che ha piu di 3000 anni e che fu portato a Roma dall'Imperatore Augusto che in origine era a decorare il Circo Massimo. Il secolo successivo, Papa Alessandro VII fece costruire dal Rainaldi le due Chiese gemelle, nel XIX secolo il Valadier ridisegnò l'intera piazza e rivestì la Chiesa di Santa Maria del Popolo di una veste neoclassica, per adattare la sua facciata al resto della piazza. Nel XVII e XIX secolo, le esecuzioni capitali si svolgevano a piazza del Popolo,i condannati a morte venivano presi a martellate nelle tempie finchè non morivano, l'ultima esecuzione avvenne nel 1826, successivamente si preferi per le esecuzioni la ghigliottina, nella piazza si svolgevano anche le feste del Carnevale. Si svolgevano anche delle crudeli corse di cavalli che venivano fatti partire da Piazza del Popolo giù per la Via del Corso, e che per farli correre senza fantini, venivano drogati, frustati, e gli si facevano scoppiare dei mortaretti tra le zampe. Due Fontane a forma di sarcofago, piazza del Popolo, Campo Marzio, Roma, si trovano ai lati della porta del Popolo. Fontana della Dea Roma, del Pincio a Piazza del Popolo, rione Campo Marzio, Roma, alimentata dall'acqua vergine, La fontana della Dea Roma collocata al centro dell’emiciclo posto sul lato destro della piazza venendo da via del Corso, è collocata al di sotto delle pendici del Pincio esattamente di fronte alla fontana del Nettuno che si trova nell’emiciclo opposto, fu ultimata nel 1823. La fontana della Dea Roma prende il nome dal grande gruppo scultoreo posto al di sopra della vasca costituito da una enorme statua della dea Roma, appunto, armata e fiancheggiata da due statue sedute rappresentanti i due fiumi di Roma, il Tevere e l’Aniene. Ai piedi della dea è collocata la lupa che allatta i gemelli, che celebra le leggendarie origini della città. L’imponente gruppo fu ideato dall’architetto Giuseppe Valadier e scolpito da Giovanni Ceccarini. Al di sotto è collocata una grande vasca semicircolare di travertino sopra la quale una valva di conchiglia sempre in travertino raccoglie l’acqua riversata da un piccolo catino posto più in alto. Fontana del Nettuno, piazza del Popolo, rione Campo Marzio, Roma, la piazza fu progettata dall’architetto Giuseppe Valadier in seguito alla trasformazione urbanistica di piazza del Popolo per dare nuovo assetto al principale accesso alla città per chi proveniva dal nord, collocò insieme alla fontana dei Leoni al centro della piazza stessa, le due fontane poste lungo i grandi emicicli laterali. Le fontane erano alimentate dall'Acqua Vergine. La fontana del Nettuno, fu costruita nell’emiciclo sinistro della piazza venendo da via del Corso, fu ultimata nel 1823. Collocata esattamente di fronte a quella della Dea Roma nell’emiciclo opposto, si compone di un’ampia vasca di travertino di forma semicircolare sopra la quale una grande valva di conchiglia, anch’essa di travertino, raccoglie l’acqua riversata da una piccola tazza posta poco più in alto. La fontana è ornata da un imponente gruppo scultoreo disegnato da Giuseppe Valadier e scolpito da Giovanni Ceccarini, nel quale l’elemento principale è rappresentato da una statua raffigurante Nettuno con il tridente nella mano destra, ai piedi della quale trovano posto due statue di tritoni appoggiati a delfini. Nel progetto originario del Valadier alla base dei due emicicli erano previsti anche due piccoli laghi a livello del terreno che non furono mai realizzati. Fontana dei Leoni a piazza del Popolo al centro della piazza, rione Campo Marzio, Roma, alimentata dall'acqua vergine, verso la metà del ‘500 una prima fontana al centro della piazza venne realizzata già nel 1572, su progetto di Giacomo della Porta, successivamente tra il .XVI e il XVII secolo la piazza assunse sempre più un carattere monumentale: nel 1589 venne innalzato al centro l’obelisco Flaminio per volere di papa Sisto V e nel corso del ‘600 venne trasformata la porta del Popolo da Gian Lorenzo Bernini e realizzate le due chiese gemelle di S.Maria dei Miracoli e S.Maria di Montesanto. Alla fine del Settecento si pensa ad una nuova sistemazione dell’intera piazza: il progetto, iniziato da Giuseppe Valadier nel 1811, viene proseguito anche con il contributo dell’architetto francese L.M. Berthault negli anni della dominazione napoleonica; i lavori vengono ultimati nel 1828. La nuova piazza assume la forma di una grande ellisse incentrata sull’obelisco e delimitata da due emicicli in corrispondenza del Pincio e del fiume Tevere, ornati da sculture e dalle grandi fontane della Dea Roma e del Nettuno. Due fontane sarcofago trovano posto anche sugli edifici ai lati della porta. La fontana dei Leoni al centro della piazza sostituisce la fontana cinquecentesca smontata e successivamente rimontata in piazza Nicosia e si sviluppa intorno all’obelisco Flaminio: ai quattro angoli del basamento a gradini, Valadier colloca delle vasche rotonde di travertino sopra le quali, su tronchi di piramide, sempre a gradini, sono posti leoni di marmo bianco in stile egizio dalle cui bocche sgorgano ampi ventagli d’acqua. Obelisco Flaminio, di Piazza del Popolo, rione Campo Marzio Roma, è un obelisco Egizio, in origine si trovava al Circo Massimo, zona Aventino, e poi fu spostato a piazza del Popolo. Fu portato a Roma da Augusto. E' alto 23,91 metri, con il basamento è alto 36,43, l'obelisco è vicino alle antiche Mura Aureliane, e posto nella splendida piazza del Popolo che da sola esprime tutta l'arte di Roma, dall'arte Romanica e Rinascimentale della chiesa di Santa Maria del Popolo, il Barocco delle chiese gemelle di Santa Maria in Monte Santo, la chiesa degli artisti, e di Santa Maria dei Miracoli, e l'arte Neoclassica del Valadier. Vedi Obelisco Flaminio. Caffè Rosati a Piazza del Popolo, rione Campo Marzio, Roma, all’inizio del Novecento era solo una semplice latteria, poi, nel 1922 i due fratelli Rosati acquistarono la acquistarono, trasformandola nel Caffè Rosati e ben presto divenne uno dei Bar più famosi di Roma, dagli inizi del 1930 iniziò ad essere frequentato dai pittori di via Margutta e sembra che anche il poeta romano Trilussa abbia sostato tra questi tavoli, oltre al poeta Vincenzo Cardarelli. Negli anni Cinquanta e Sessanta era frequente vedere qui Pier Paolo Pasolini, Alberto Moravia con la moglie Elsa Morante, Italo Calvino, Flaiano, e tanti cineasti e artisti come Fioroni, Angeli, Festa e Schifano, De Chirico, Guttuso, e molti altri. Non era raro trovarci Fellini, che veniva a incontrare Flaiano, Simone de Beauvoir che parlava fitto fitto con Sartre, Carlo Levi, Vittorini, Cascella, Marina Lante della Rovere, Luccichenti, Vittorio Caprioli, Mazzarella, Franca Valeri, Gassman, Bernardo Bertolucci. Questa speciale commistione tra arte, letteratura, cinema ha fatto di questo luogo un polo culturale di primissima categoria. Almeno fino agli anni Settanta, quando iniziò una sorta di decadenza, non solo dei caffè, ma, per certi versi, anche della cultura in generale. L’interno del locale è elegantemente arredato, con ricche boiserie e mobili pregiati. Ristorante Canova piazza del Popolo rione Campo Marzio, Roma, è uno dei più famosi locali storici ed eleganti al centro di Roma. Le Chiese Gemelle di Piazza del Popolo, camminando verso Piazza del Popolo, possiamo ammirare le due Chiese Gemelle la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli e la Chiesa di Santa Maria in Montesanto, le due chiese gemelle sono situate sul lato sud della Piazza, furono edificate su progetto dell'architetto barocco Rainaldi (1611-1691), che ha saputo ben competere con i suoi contemporanei Bernini e Borromini, per creare una perfetta simmetria : la cupola di Santa Maria dei Miracoli a destra è circolare, mentre quella di Santa Maria in Montesanto è ovale, e le due chiese sembrano perfettamente uguali. Chiesa di Santa Maria del Popolo, piazza del Popolo Roma, fu fatta edificare da Papa Sisto IV della Rovere nel 1472, la chiesa è in stile rinascimentale e conserva moltissime opere d'arte tra cui Andrea Bregno e Pinturicchio, vi sono opere del Bramante e del Bernini, le cappelle della chiesa appartengono alle famiglie illustri di Roma , la cappella dei Della Rovere ha affreschi del Pinturicchio , nella cappella Cerasi ci sono due opere del Caravaggio, la "Conversione di San Pietro" e la " Crocefissione di San Pietro". La Cappella Chigi fu progettata da Raffaello, la pala d'altare è di Sebastiano del piombo, nelle nicchie ai lati ci sono sculture di Bernini e del Lorenzetto . Dietro l'altare c'è la tomba di Andrea Sansovino. La Pala d'altare della Assunzione è di Annibale Carracci ( 1540-1609) Il mosaico del pavimento raffigurante la morte in ginocchio fu aggiunto alla cappella Chigi nel XVII secolo.Le vetrate della Chiesa sono opera del 1509 dell'artista francese Guillaume de Marcillat. La tomba di Ascanio Sforza morto nel 1505 è del Sansovino. Sull'Abside affreschi del Pinturicchio, la "Sibilla di Delfi" ed altri di ispirazione sacra. Porta del Popolo, piazza del Popolo Roma, si può arrivare alla Porta del Popolo anche dalla antica Via Flaminia realizzata nel 220 a.C. per collegare Roma all'Adriatico, la Porta del Popolo fu voluta da Papa Pio IV Medici ad opera dell'architetto Nanni di Baccio Bigio che si ispirò ad un arco di trionfo romano, sulla parte esterna ai lati dell'arco ci sono le statue di San Pietro e di San Paolo e sopra lo stemma dei Medci.. Un secolo dopo Papa Alessndro VII commissionò al Bernini di decorare la parte interna per celebrare l'arrivo a Roma della Regina Cristina di Svezia. Questo luogo era ance adibito ai controlli doganali. Via di Monte Brianzo, va da piazza Nicosia a piazza di Ponte Umberto rione Campo Marzio e rione Ponte, forse il nome deriva da un oste o locandiere della Brianza. Fontana dell'Orso dell'Acqua Vergine via di Monte Brianzo, rione Campo Marzio e rione Ponte, Roma, è addossata al muro di sostegno della rampa che conduce al sovrastante lungotevere fu costruita agli inizi del '900 a cura del Comune di Roma, si tratta, probabilmente, dell'intero rifacimento e spostamento di una precedente omonima fontana. La fontanella dell'Orso è formata da una cornice modanata di travertino che racchiude una superficie marmorea ad arco, al centro della quale è stata collocata la testa di orso in bronzo che versa l'acqua in una elegante tazza di travertino sorretta da un piedistallo. Sotto lo stemma comunale, inserito nel semicerchio della cornice, una epigrafe ricorda che la fontana è alimentata dall'Acqua Vergine. L'orso, ricorda probabilmente la famiglia Orsini che aveva alcune proprietà nella zona e la Locanda dell'Orso nella quale soggiornarono molti illustri personaggi, ma non Dante Alighieri, come affermano quasi tutte le guide di Roma, perché l'edificio risale alla metà del XV secolo quando il poeta era già morto da circa 150 anni. Chiesa di Santa Lucia della Tinta Roma, è al numero 61 di via di Monte Brianzo, rione Campo Marzio e rione Ponte, è una chiesa molto antica, la si ricorda in un documento del 1002, dedicata a Santa Lucia, l'appellativo della Tinta deriva dal fatto che in questa zona vi era una contrada di tintori di panni. Fu restaurata nle 1580 a cura della Compagnia dei Cocchieri cui era stata affidata, nel 1628 passò alla famiglia Borghese e nel 1826 passò ai procuratori della Curia Romana. Edicola Sacra di fianco alla Chiesa di Santa Lucia della Tinta, Roma, rione Campo Marzio e rione Ponte, è una piccola madonnina in ceramica accanto alla chiesa. Chiesa del Divino Amore, vicolo del Divino Amore, Roma, rione Campo Marzio Roma, dedicata fino all'inizio dell'800 ai Santi Cecilia e Biagio, oggi è conosciuta anche col nome di Madonna del Divino Amore in Campo Marzio . Nel 1575 la chiesa fu affidata alle cure della Compagnia dei materassai, che aggiunsero all’antico titolo quello di San Biagio, protettore della compagnia. Sotto il pontificato di papa Benedetto XIII la chiesa fu completamente ricostruita su progetto di Filippo Raguzzini. Nel 1802 Pio VII la affidò alla Confraternita del Divino Amore oggi Arciconfraternita del santissimo Sacramento e della Madonna del Divino Amore. Della antica chiesa medievale è rimasto il campanile, che risale al XII secolo. L’interno della chiesa è ad unica navata, con volta a botte, affrescata nell’Ottocento. Piazza Nicosia, Roma, è tra via di Monte Brianzo e via della Scrofa , rione Campo Marzio, prende il nome dallo scomparso palazzo del cardinale Aldobrandino Orsini arcivescovo di Nicosia. Fontana piazza Nicosia, Roma, rione Campo Marzio, fu progettata da Giacomo Della Porta nel 1572 e collocata in origine al centro di piazza del Popolo, la fontana di piazza Nicosia era una delle fontane pubbliche realizzate a Roma nel XVI secolo in seguito alla riattivazione dell’antico Acquedotto Vergine. La fontana fu collocata nel 1950 nella sede attuale, al centro di piazza Nicosia, un nuovo slargo realizzato realizzato dopo l'Unità d'Italia a seguito delle demolizioni attuate nella zona nel 1936 su progetto di Marcello Piacentini. Via della Scrofa, va da via del Clementino a Largo Giuseppe Toniolo, rione Campo Marzio e rione Sant'Eustachio, ricorda una taverna della Scrofa. La via fa riferimento ad una piccola scrofa di cui si fa cenno in documenti del 1445 che probabilmente è il frammento di un grande bassorilievo in marmo bianco raffigurante una processione. Perduta o distrutta la rimanente parte della composizione, la figura della scrofa, venne posta sul muro del convento degli Agostiniani ed ebbe tale notorietà da imporre il nome alla strada. La scrofa fu poi trasformata in fontanella per volontà di papa Gregorio XIII Boncompagni. Fontana via della Scrofa, Roma, rione Campo Marzio e rione Sant'Eustachio, in origine la fontana gettava acqua dall'antico bassorilievo di una a scrofa che fu trasformata nel 1580 in fontanella per volontà di papa Gregorio XIII Boncompagni mettendo una piccola cannella nella bocca dell'animale l'acqua si riversava in una sottostante una tazza di marmo. Nel 1873 a causa del notevole aumento del traffico si rese necessario lo spostamento della vaschetta che sporgeva troppo dallo stretto marciapiede. La fontana venne quindi rimossa, mentre la scrofa rimase là dov'è era in precedenza, una lapide posta sotto la scrofa ricorda il trasferimento della fontana. Edicola Sacra Via della Scrofa Roma, è posta sopra la fontana ad angolo con piazza Nicosia.
Fotografie : da
vedere zona
piazza di Spagna e dintorni (Roma)
Da vedere nei dintorni di Piazza di Spagna (Roma)
Piazza di Spagna e dintorni (Roma)
Piazza di Spagna e dintorni, Roma foto Anna Zelli torna Piazza di Spagna e dintorni - Itinerari Turistici Roma - Guida Turistica di Roma Piazza di Spagna e dintorni - Itinerari Turistici Roma - Guida turistica di Roma
Tutte le Foto sono di proprietà di
Anna Zelli
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna Zelli A.Z. Arte Cultura Novità Idee
potete contribuire gratuitamente con le vostre idee : mandate una mail |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.gif)




























.gif)



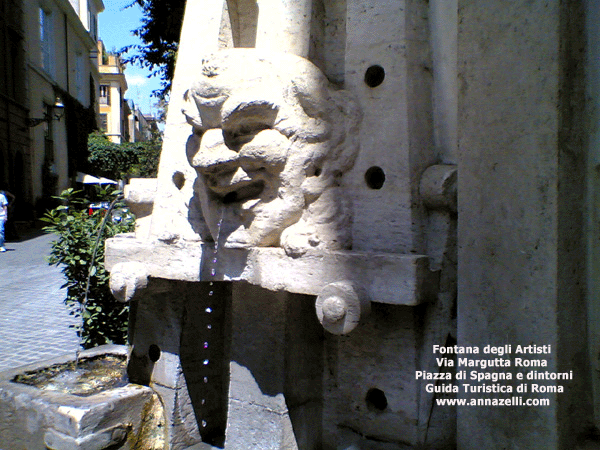






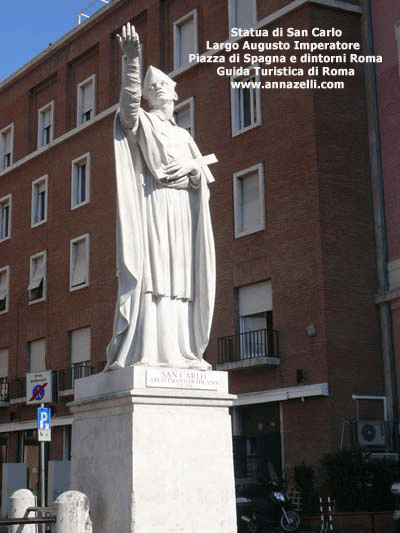
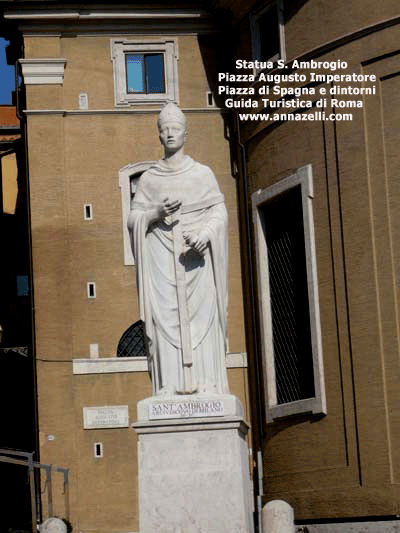










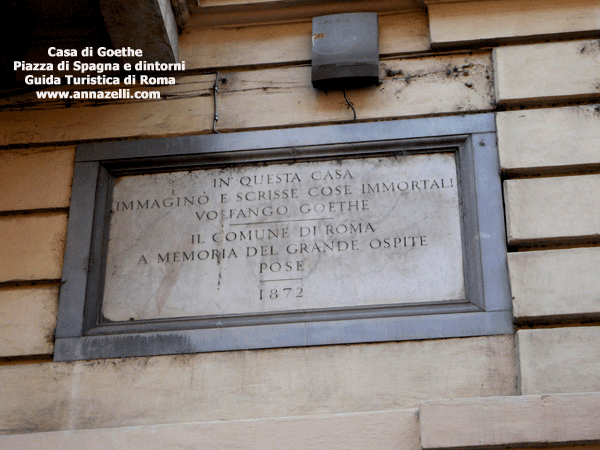


























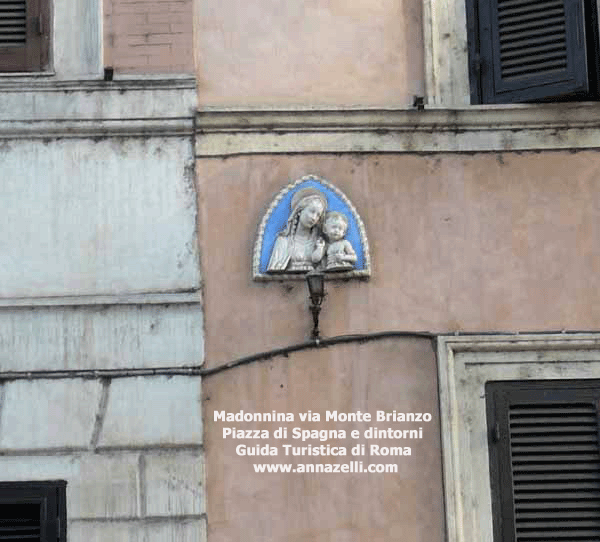


.gif)
.gif)
.gif)
.gif)












.gif)