|
Via Mazzini Viterbo |
via mazzini viterbo centro storico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VIA MAZZINI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beata Santa Rosa Venerini Banca Intesa Sanpaolo Palazzo Nini Palazzo Pagliacci Sacchii Famiglia Pagliacci Sacchi Ex Convento Santa Caterina Istituto Maestre Pie Venerini Edicola Beata Rosa Venerini Ex Collegio San Giovanni Giuseppe Mazzini Vittoria Colonna Suor Maria Crescini Chiesa di Santa Rosa Casa di Santa Rosa e Museo Edicole sacre lapidi Mazzini Stemmi Viterbo centro Archi a via Mazzini Vie piazze da via Mazzini
Dintorni via Mazzini via della Verità Via Orologio Vecchio Porta della Verità Casa di Santa Rosa Museo Santa Rosa Chiesa di Santa Rosa
Guida Turistica Viterbo
|
Via Mazzini, Viterbo centro storico, la lunga via parte da via della Verità ed arriva alla via della casa di Santa Rosa, la via incrocia come piazze: Piazza Dante, Piazza della Crocetta, Largo Santa Rosa Venerini; come vie : Via della Volta Buia, via di Mezzo, via Fontanella del Suffragio, via del Giglio, via Bussi, Via Sant'Egidio, via casa di Santa Rosa, Via Santa Caterina, via Niccolò della Tuccia, via delle Maestre, via Cacciamele, via Tignosi, via di San Rocco. Da vedere la chiesa di San Giovanni in Zoccoli, qui c'era il Collegio San Giovanni chiuso nel 2022 al Largo Santa Rosa Venerini. Da ammirare il palazzo della Ex Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo un tempo appartenuto alla famiglia Pagliacci Sacchi.Su via Mazzini si possono ammirare la Chiesa di San Giovanni in Zoccoli, la chiesa di Santa Maria del Poggio a piazza della Crocetta, il palazzo Nini, di fronte a piazza della Crocetta su via Mazzini, su questa via c'è il collegio di San Giovanni fondato da Santa Rosa Venerini.che aveva anche un'altra sede a piazza San Carluccio. vedi. piazza San Carluccio. Lungo la via ci sono vari stemmi e una Edicola Sacra angolo via dei Tignosi. Giuseppe Mazzini Giuseppe Mazzini. A lui è dedicata una via a Viterbo, nacque a Genova, il 22 giugno 1805 morì a Pisa, il 10 marzo 1872 è stato un patriota, politico, filosofo e giornalista italiano. Esponente di punta del patriottismo risorgimentale, le sue idee e la sua azione politica contribuirono in maniera decisiva alla formazione dello Stato unitario italiano; le condanne subite in diversi tribunali d'Italia lo costrinsero però alla latitanza fino alla morte poiché egli fu convinto sostenitore dell'istituzione repubblicana contro la monarchia sabauda. Le teorie mazziniane furono di grande importanza nella definizione dei moderni movimenti europei per l'affermazione della democrazia attraverso la forma repubblicana dello Stato. Giuseppe Mazzini, patriota e politico genovese. Il suo obiettivo era di trasformare l’Italia in uno Stato unitario, repubblicano e democratico. Mazzini assieme a Garibaldi e Cavour è considerato uno dei “padri della patria” e dei simboli del Risorgimento italiano. Giuseppe Mazzini nacque a Genova, allora parte del Regno di Sardegna, da una famiglia della borghesia medio-alta. Si era accostato fin dagli anni giovanili alle idee democratiche e patriottiche e aveva aderito alla Carboneria. Partecipò quindi alle cospirazioni contro il governo sabaudo, finendo arrestato nel 1830. Rilasciato per mancanze di prove, fu però costretto a emigrare a Marsiglia. Cominciò così a 26 anni la sua vita da esule. Nel 1831 Mazzini fondò in esilio a Marsiglia la Giovine Italia. La Giovine Italia era un’associazione clandestina di rivoluzionari di professione che volevano un’Italia unita e repubblicana con un governo eletto dal popolo. Convinti della necessità di un legame strettissimo tra «pensiero e azione» (la famosa formula mazziniana), Mazzini e i suoi seguaci non aspettarono il maturare di condizioni internazionali favorevoli per mettere in atto i loro progetti e organizzarono una serie di tentativi insurrezionali in Italia. I moti mazziniani, che esplosero tra il 1831 e il 1834, tuttavia fallirono, per la scarsa organizzazione e per la mancata diffusione degli ideali liberali e repubblicani tra operai e contadini. Da qui una profonda crisi di sfiducia verso le idee mazziniane. Mazzini però non rinunciò al suo sogno e superò in breve la «tempesta del dubbio», così come la chiamò Mazzini stesso, caratterizzata dal rimorso di aver sacrificato tante vite (tra cui quelle di veri amici come Jacopo Ruffini) senza aver centrato alcun obiettivo. Superò la crisi convincendosi che la causa nazionale italiana era più importante di ogni accidentale insuccesso. Rifugiatosi in Svizzera, nel 1834 fondò la Giovine Europa, che in due anni riuscì ad articolarsi in diverse organizzazioni nazionali: Giovine Germania, Giovine Polonia, Giovine Svizzera. La Giovine Europa rappresentò il primo tentativo di dare vita a un’organizzazione democratica europea. Si trattò però di un’iniziativa che ebbe un valore soprattutto simbolico e scarsi effetti sul piano operativo. Nel 1837 espulso dalla Svizzera si rifugiò a Londra, dove visse quasi in miseria. Tuttavia non interruppe mai la sua propaganda in Italia. Nel 1848, allo scoppio della Prima guerra d’indipendenza italiana, Giuseppe Mazzini rientrò in Italia dall’esilio, offrendo il suo aiuto al re Carlo Alberto di Savoia. Era convinto che il re avesse dato inizio alla guerra per la riunificazione dell’intera Italia e per la sua trasformazione in uno Stato costituzionale moderno. Ma l’illusione durò poco. Carlo Alberto mostrò scarsa risolutezza nel condurre le operazioni militari e si preoccupò soprattutto di preparare l’annessione del Lombardo-Veneto al Piemonte. Il 29 marzo 1849 Mazzini è nominato triumviro della neonata Repubbblica romana insieme a Carlo Armellini e Aurelio Saffi. La Repubblica romana ebbe però vita breve. Infatti, dal suo esilio di Gaeta, papa Pio IX si era rivolto alle potenze cattoliche per essere ristabilito nei suoi territori. All’appello del papa risposero l’Austria, la Spagna, il regno di Napoli e la Repubblica francese. Luigi Napoleone Bonaparte attaccò Roma, dove nel frattempo erano arrivati pure il generale Giuseppe Garibaldi e volontari da tutta la penisola. Dopo una prima vittoria di Garibaldi, i francesi costrinsero alla resa il generale e i suoi uomini. Mentre Pio IX ritornava sul trono papale, Mazzini si recò esule prima in Svizzera e poi in Inghilterra. Nel corso degli anni Cinquanta Mazzini Giuseppe tentò di riprendere l’iniziativa rivoluzionaria in Italia. A questo scopo fondò nel 1853 il Partito d’Azione, ma tutte le azioni da lui promosse andarono incontro alla repressione. L’insuccesso più grave fu la spedizione di Carlo Pisacane a Sapri nel 1857. Negli anni successivi dedicò molte delle sue energie alla questione sociale e alla battaglia per l’elevazione delle condizioni delle classi lavoratrici. Nel 1864 partecipò a Londra alla fondazione della Prima internazionale dei lavoratori, opponendosi alle posizione dei marxisti e degli anarchici, perché, in quanto riformista democratico, non condivideva le loro teorie rivoluzionarie. Nel 1870, mentre si recava a Palermo per preparare un’insurrezione popolare, lo arrestarono e lo rinchiusero nel carcere di Gaeta per alcuni mesi. Morì il 10 marzo 1872 a Pisa, clandestino, sotto il falso nome di dottor Brown. Tratto da https://www.studiarapido.it/giuseppe-mazzini-chi-era-e-cosa-fece/. Archi a via Mazzini Archi via Mazzini, Viterbo, vi sono degli archi sul lato di via Mazzini che da a via della Verità, altri di fronte alla chiesa di San Giovanni in Zoccoli. Chiesa San Giovanni in Zoccoli La chiesa di San Giovanni in Zoccoli è tra via Mazzini e piazza Dante, Viterbo centro storico, è una delle chiese più antiche della città, l’origine del nome rimane incerta, ma l’ipotesi più attendibile è quella che vende nel termine “zoccoli” una corruzione del volgare “ciocole”, derivante da “ciotole”, in riferimento ai manufatti smaltati che decoravano anticamente la lunetta del portale principale dell’edificio, oggi perduti. La data della sua costruzione è incerta, probabilmente risale ai primi decenni dell'XI secolo. Prendendo per buona una notizia riferita dal Bussi su una campana colpita dal fulmine e rifusa nel 1607, era incisa la data 1037. La chiesa era dedicata a San Giovanni Evangelista. Esterno : la chiesa, datata tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo, è situata in uno dei quartieri più antichi della città, quello di Santa Maria in Poggio, oggi attraversato da via Mazzini: qui vi abitò anche Santa Rosa e qui avvennero i suoi primi miracoli. La facciata è suggestivamente preceduta da due archi paralleli a sesto ribassato che scavalcano la via e vanno ad appoggiarsi alla casa prospiciente l’edificio: un espediente statico per bilanciare le spinte degli archi delle navate. Essi inquadrano anche lo splendido rosone romanico, formato da tre cerchi concentrici ornati da colonnine marmoree ed archetti in peperino. Agli angoli del rosone troviamo il tetramorfo con i simboli dei quattro evangelisti e tutt’intorno una cornice a decorazione musiva. Ai lati due aquile connotano l’intitolazione della chiesa a San Giovanni Evangelista. Il resto della facciata, così come tutta la struttura, ha subito numerosi restauri nel corso dei secoli, in particolare nell’Ottocento ad opera di Giovan Battista Cavalcaselle, che ha ricostruito il fregio del portale sulla base di un frammento originale. Il rifacimento più consistente è stato quello postbellico, mentre l’ultimo intervento di restauro, conclusosi nel 2013, è stato affiancato da indagini archeologiche che hanno fornito dati interessanti riguardo la storia dell’edificio nelle sue prime fasi. La chiesa di forma basilicale presenta una facciata a capanna spezzata impreziosita da due elementi architettonici molto particolari. L'interno della chiesa è in stile romanico, basilicale a tre navate, scandite da una teoria di archi a tutto sesto e con copertura a capriate in legno, termina con tre absidi emergenti e il presbiterio leggermente rialzato. L’opera più importante è un polittico datato 1441 realizzato da uno dei più importanti protagonisti della pittura viterbese: Francesco d’Antonio Zacchi, detto il Balletta. Le colonne che dividono le navate non sono monolitiche ma costituite da grossi blocchi di pietra sovrapposti alla cui sommità sono posti dei capitelli a doppio toro scolpiti in maniera piuttosto rozza, su di esse poggiano degli archi a tutto sesto. Il presbiterio risulta innalzato rispetto alla chiesa e gli archi in quel punto sono più alti e più larghi. La chiesa è stata oggetto di numerosi interventi di restauro nel corso dei secoli, tra i più importanti ricordiamo quello del 1880 e quello seguito alla ricostruzione dopo i bombardamenti subiti durante l'ultimo conflitto. Nel corso del restauro ottocentesco è stato completamente ricostruito il portale di ingresso con decorazione a stelle basandosi per il suo rifacimento su un frammento originale, nella sua lunetta è affrescato San Giovanni in posa estatica come in preda a una sua visione dell'apocalisse. Nel corso di questo stesso restauro, sopra l'altare maggiore fu costruito un baldacchino tabernacolo in pietra che probabilmente non era presente nella chiesa originaria, esso andò distrutto nei bombardamenti dell'ultima guerra e non è stato più ricostruito. Nell'abside centrale, sotto una monofora istoriata con San Giovanni Evangelista, è collocata la sedia episcopale, in forma molto arcaica e probabilmente appartenuta alla chiesa primitiva. Essa è priva di schienale e presenta due braccioli leggermente ricurvi. Al centro del presbiterio è posto l'altare maggiore. Si tratta di un parallelepipedo di pietra che indubbiamente ha subito notevoli mutazioni nel corso dei secoli. Oggi possiamo ammiralo così come è stato restaurato nel corso dell'intervento dell'800. Risulta originale la parte anteriore a colonnine, la mensa o lastra di coperchio e parte della base. Nel corso del restauro furono ricostruiti un fianco e tutta la parte posteriore. All'interno della chiesa, degno di ammirazione, è conservato uno splendido polittico dipinto nel 1441 per l'altare maggiore da Francesco d'Antonio da Viterbo detto il Balletta. Decorato con cuspidi di forma gotica presenta nella parte centrale un'immagine della Vergine con Bambino. Alla sua sinistra San Pietro e San Giovanni Battista, alla sua destra San Giovanni Evangelista e San Paolo. Altre figure minori sono raffigurate nelle due cuspidi laterali, la predella invece presenta scene di miracoli operati dall'Evangelista. (tratto da Alessandra Ambrosini). Palazzo Pagliacci Sacchi Palazzo Pagliacci Sacchi, Via Mazzini Palazzo Pagliacci Sacchi poi sede ex Cassa di Risparmio di Viterbo, si trova a via Mazzini, Viterbo.Il Palazzo Pagliacci, sede storica della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo in origine era di proprietà della Famiglia Maidalchini, poi nel 1702 divenne di proprietà dei Pagliacci, fu riedificato per la famiglia Pagliacci intorno alla metà del XVIII secolo, sul progetto dell'architetto Filippo Prada .successivamente il palazzo fu venduto a Giuseppe Moscatelli, e dal 1874 passò alla Cassa di Risparmio di Viterbo, che ne fece la propria sede.Il Palazzo Pagliacci ospita alcune opere d'arte oggi di proprietà dell'Istituto, tra le quali alcuni reperti di Affreschi della Chiesa di S. Stefano in Bagnaia e opere di autori tra cui Matteo Giovannetti, Domenico Corvi, Giovan Francesco Romanelli e Marco Benefial. Famiglia Pagliacci
Famiglia Pagliacci Viterbo, secoli XVIII-XIX
era originaria di Arlena di Castro e di
Canino, si stabilì a Viterbo all’inizio del
Settecento, venne inserita nella nobiltà di
Viterbo nel 1702. Dei primi discendenti della
famiglia Pagliacci di cui si ha conoscenza
intorno al Seicento, si sa erano originari di
Arlena di Castro e furono militari, e verso la
fine del ‘600 avevano qui una dimora importante
e il Capitano Silverio Pagliacci venne nel 1698
ascritto al ceto nobile. Nel 1702, per cessione
del marchese Andrea
Maidalchini, indebitato con i Pagliacci,
Silverio acquisì beni in Viterbo , come :poderi,
vigne e case, e tra questi un
palazzo a piazza Santa
Caterina, che in tempi recenti fu
la la sede della Cassa di
Risparmio. Suo figlio Giacomo ottenne
l’appalto di una miniera di vetriolo, solfato di
rame, sulla strada per Bagnoregio, per la cui
commercializzazione aveva piena esclusiva in
tutto lo Stato della Chiesa; alla sua morte, ne
1716, questo diritto passò al fratello Antonio,
suo erede. Antonio che fu il maggiore artefice
delle fortune della famiglia, liquidato nel 1719
l’appalto della miniera, ebbe un importante
incarico, almeno fino al 1750, nelle dogane
della provincia del Patrimonio, ne fu anche
tesoriere generale e in seguito fu anche
direttore delle Poste.
Ottenuto un notevole benessere finanziario, fece
decorare gli interni del palazzo di Canino e del
Palazzo della ex Cassa di
Risparmio dal pittore Domenico Corvi. Nel
1730 contribuì con 300 scudi all’edificazione
del monastero domenicano del Rosario a Valentano,
fondato da suor Cecilia Agnese Starnini; nel
1759 fu deputato per la
festa viterbese di santa Rosa; nel 1762
ottenne da papa Clemente XIII il titolo di conte
sulla tenuta di Villanova, che si trovava sulla
via Cassia in direzione di Montefiascone, una
tenuta un tempo appartenuta ai
Maidalchini. Nel
1782 i fratelli Silverio (1747-1810) e Giacomo
(1759-1831), figli di Antonio, strinsero società
con Giuseppe Franceschini e Francesco Polidori
per l’appalto dei forni di pane di Viterbo. Come
il padre, Silverio fu direttore delle
Poste ,
mentre Giacomo fu direttore
dell’Ospedale
Grande ed ebbe cariche civiche. Alla fine
del Settecento il conte Antonio junior,
1794-1864,figlio di Giacomo e di Maria Felice
Sacchi, assunse il cognome
Pagliacci Sacchi. Fu guardia nobile di
Napoleone. Suo figlio Giovanni ebbe un ruolo
importante nell’età del Risorgimento, ai cui
ideali contribuì con il suo operato e con i beni
di famiglia . I Paglliacci si sono estinti nella
prima metà del Novecento. Il loro palazzo
cittadino fu venduto a
Giuseppe Moscatelli, e dal 1874 passò
alla Cassa di Risparmio di
Viterbo, che ne fece la propria sede. Le
sepolture di famiglia sono in
Santa Maria della Verità.
Arme: d’azzurro al destrocherio di carnagione,
vestito di rosso, movente dal lato sinistro e
impugnante tre spighe d’oro. Nell’Ottocento
l’arme era partita con quella dei Sacchi (v.).BIBL. – Spreti, V, p. 35; Signorelli 1968, pp.
146, 158; Carosi 1997a, p. 170; Angeli 2003, pp.
143, 232, 373-375, 458, 474, 509, 572, 841,
901.[Scheda di Saverio Franchi – Ibimus.
Pagliacci
Sacchi Giovanni,
esponente della famiglia Pagliacci, Patriota
nacque a Viterbo nel 1823 e morì a San Martino
al Cimino il 24 aprile1884, fu esponente del
Circolo popolare di Viterbo,del quale fu
consigliere e tribuno,nel 1848 combatté con i
volontari romani in Veneto con il grado di
tenente e partecipò nel 1849 alla difesa della
Repubblica Romana. Esule a Parigi, rientrò in
Italia nel 1859 entrando nell’esercito sardo con
il grado di capitano nel 39° reggimento
fanteria. Nel 1860 fu aiutante maggiore del
colonnello Masi, partecipando con i Cacciatori
del Tevere alla liberazione di Orvieto,
all’avanzata verso Viterbo e al successivo
ripiegamento su Orvieto. Lì per sette anni fu
l’anima del comitato degli esuli viterbesi
impegnati nella preparazione dell’insurrezione
nello Stato Romano e, particolarmente, nella
Tuscia. Fu Caposquadra della colonna di
volontari che il 30 settembre 1867 occupò
Acquapendente e resistette a San Lorenzo allo
scontro con le truppe pontificie, assunse il
comando nel tentativo di occupazione di
Bagnoregio, tentando inutilmente la resistenza
all’interno del convento di San Francesco.
Costretto alla resa, il 5 ottobre fu fatto
prigioniero e condotto a Roma nelle carceri del
San Michele; in base agli atti della
capitolazione dei garibaldini arrestati con lui
a Bagnoregio, avrebbe dovuto essere rimesso in
libertà, ma per la sua attività di cospiratore,
la sua posizione fu inserita nella “Causa
Viterbese di Lesa Maestà” affidata al giudice
Giuseppe Maggi. Il capo d’imputazione nei suoi
confronti,come pure dei fratelli Mazzariggi,era
: Cospirazione e corrispondenza epistolare
antipolitica all’effetto di turbare l’ordine
pubblico. In suo favore, forse presso il
cardinal Antonelli, l’11 gen. 1868 intercesse la
principessa Letizia Bonaparte che si rivolgeva
all’eccellenza reverendissima chiedendo che il
conte, ammalato e rinchiuso al San Michele,
fosse liberato al più presto. Alla fine di
maggio, il processo della causa denominata
“Viterbese di Lesa Maestà” si concluse con la
condanna alla pena dell’ergastolo, dopo soli
quattro giorni commutata su sollecitazione
dell’ambasciatore francese in detenzione per
venti anni. All’indomani della presa di Roma, il
conte era ancora l’unico dei coimputati ad
essere ancora detenuto nel carcere di San
Michele. Riacquistata la libertà rientrò a
Viterbo, dove diede alle stampe” Canti del
prigioniero”. Strenna per l’anno 1871
(Viterbo,Tosoni, 1871).Quando a Bagnoregio, il 6
ottobre
1878 venne posta la prima pietra del
monumento ai caduti
garibaldini, scrisse le parole di un inno
che intitolò “Carabina” e che fu inviato a
Garibaldi. Anche se ammalato, non cessò di
partecipare alla vita pubblica della sua città,
impegnandosi in particolar modo nella tutela e
valorizzazione del patrimonio storico e
culturale viterbese. Su sua proposta, nel 1874
il Consiglio comunale deliberò l’istituzione di
una commissione per l’ordinamento dell’Archivio
storico viterbese composta di tre membri
originari della città, alla quale sarebbe
spettato l’onere di svolgere un ricognizione dei
documenti di maggiore rilevanza storica e
d’interesse cittadino esistenti presso
l’Archivio comunale e presso le corporazioni
soppresse. La questione, discussa e contestata
in seno allo stesso Consiglio comunale, diede
luogo nel 1875 alla costituzione della
Commissione, della quale Giovanni Pagliacci
Sacchi faceva parte con il professor Raffaele
Belli e il canonico Luca Ceccotti. Quest’ultimo
lavorò alacremente per tre anni all’ordinamento
dell’Archivio, ma non riuscì a terminare quel
Compendio di storia patria del quale era stato
incaricato. Dopo il tardivo matrimonio con
Annalia Giacci celebrato nel dicembre 1875,
dalla quale ebbe un figlio, Antonio, Giovanni
Pagliacci Sacchi si dedicò negli ultimi anni
della sua vita ad una prima sistemazione del
materiale librario proveniente dalle
corporazioni religiose soppresse, per un totale
di circa 30.000 volumi, pervenuto alla
Biblioteca comunale.
Rivestì inoltre la carica d’ispettore scolastico
di Viterbo e Civitavecchia. Morì a San Martino
al Cimino in casa di una sua defunta sorella ed
ebbe funerali pubblici a Viterbo prima della
sepoltura nel cimitero di San Lazzaro. Cassa di Risparmio Provincia Viterbo Cassa di Risparmio Provincia Viterbo Storia della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, via Mazzini, nel 1927, La Cassa di Risparmio di Viterbo assorbì le Casse di Acquapendente, Bagnoregio e Carbognano, mentre con regio decreto 25 febbraio 1937 n. 318 incorporò le Casse di Risparmio Riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola, modificando la propria ragione sociale in "Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo”. Alla fine della seconda guerra mondiale, l'Istituto concesse numerosi crediti ai cittadini viterbesi , per la ricostruzione delle proprie case, e partecipò con un fondo di 100.000 lire alla ricostituzione della Società per la Conservazione dei Monumenti, che trovò ospitalità presso la sede dell'Istituto, e si occupò anche dei lavori di restauro di importanti edifici storici danneggiati dai bombardamenti. Dal 1999 l'istituto, entrò a far parte delle "Casse del Centro", società di Banca Intesa. Il 23 novembre 2015 è stata fusa per incorporazione nella capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. Nell'ultimo periodo di attività, era controllata dal gruppo Intesa Sanpaolo attraverso la Banca CR Firenze.(tratto da Wikipedia) Banca Intesa San Paolo Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. di Viterbo, Via Mazzini, 135. Ecco i principali servizi e prodotti disponibili in filiale: Consulenza personalizzata, Conti correnti, Libretti di risparmio, Conto corrente per minorenni, Mutui, Surroga mutuo, Mutuo casa, Mutuo liquidità, Assicurazioni, Assicurazione auto, Assicurazione casa, Bancomat, Carte di debito, Carte di credito, Carte prepagate, Prestiti, Finanziamenti tasso zero, prestiti personali, Piani di Previdenza, Fondi pensione, Investimenti, Fondi comuni di investimento, Gestione patrimoniale, Investimenti assicurativi, Certificates, Piani di risparmio, Piani di accumulo Palazzo Nini Palazzo Nini, via Mazzini, Viterbo Palazzo Nini, via Mazzini, Viterbo centro storico, davanti alla fontana di piazza della Crocetta, c'è un palazzo che avrebbe bisogno di un immediato restauro, molto bello, un tempo della famiglia Nini, i quali avevano palazzi anche a via Annio. Questo palazzo fu costruito nel XVI secolo da Giovan Battista, un discendente del quale Paolo, sposò la giovanissima Olimpia Maidalchini, destinata ad essere insignita del titolo di Principessa di San Martino, dal secondo marito Giovan Battista Pamphili, quando il fratello venne eletto Papa con il nome di Innocenzo X. Un tempo all'ultimo piano di questo palazzo c'era una loggia, oggi sopravvivono le colonnine al secondo piano.vedi anche via Annio Collegio San Giovanni
Ex Collegio San Giovanni Collegio San Giovanni, Largo Santa Rosa Venerini, via Mazzini, Viterbo centro storico,qui ci fu la prima scuola femminile gratuita voluta dalla viterbese Santa Rosa Venerini, nata nel 1656 e morta nel 1728. La Santa era sposata si occupava sia dei figli che di aiutare il marito nel lavoro dei campi. Abitava in un palazzo nobile sito in via Mazzini, quello dove c’era fino al 2022 il Collegio San Giovanni, purtroppo oggichiuso, la Santa lavorava anche come educanda nel monastero di Santa Caterina a piazza Dante. Era una donna intelligente, colta e di buona famiglia.Fin da adolescente decise di seguire gli insegnamenti cristiani, ma senza rinchiudersi in convento. Ancora adolescente vedendo che molte bambine a causa della povertà crescevano senza avere una istruzione adeguata, decise di aiutarle, invitò quindi, un piccolo numero di bambine e ragazze a casa sua, occupando una stanza della casa, per delle “lezioni di ascolto”, dei passi del Vangelo e della Bibbia .Le ragazze che dovevano lavorare come sarte o ricamatrici, apprezzarono l’ascolto e la conoscenza delle Sacre Scritture, e fu allora che Rosa decise di dare loro lezioni di alfabetizzazione. Aiutata da alcune sue amiche aprì la prima scuola popolare gratuita femminile, era il 30 agosto 1685. Il suo motto era “ Educare e Liberare”.In quel tempo infatti non c’era l’abitudine di vedere un gruppo di donne vivere insieme senza Monastero, senza voti e senza grate, con il compito di insegnare a leggere e a scrivere; ma la popolazione capì e presto tutte quelle che potevano corsero in quella scuola, la cui sede fu ampliata grazie all’aiuto economico di una nobile viterbese Artemisia Bugiotti. Il suo insegnamento era apprezzato e famoso, tanto che Rosa venne invitata dal Cardinale Marcantonio Barbarigo, Vescovo di Montefiascone, che lodò il progetto e fece aprire ben 10 scuole nella sua diocesi. A Montefiascone Rosa conobbe Lucia Filippini che amava anche lei l’Apostolato e divenne sua stretta collaboratrice nelle scuole di Montefiascone. Rosa fondò altre scuole, che ancora esistono, in tutta la Tuscia, in Umbria, in tutta Italia e soprattutto a Roma. Le scuole si diffusero anche in tutti i continenti tranne l’Oceania. Con questo progetto Santa Rosa Venerini aiutò a diffondere nelle persone i valori culturali, civili e religiosi. Ora il Collegio San Giovanni è stato chiuso a settembre del 2022, davvero una grave perdita. Vedi piazza Dante. Ex Chiesa Monastero S. Caterina Ex Convento e Chiesa Santa Caterina
Ex Chiesa e
Convento
di
Santa Caterina, piazza
Dante, Viterbo, qui vi soggiornò
Vittoria Colonna,
per 3 anni dal 1541 al 1544. Vittoria Colonna
venne a Viterbo, la prima volta, nel 1525 dove
le giunse la notizia della morte del marito,
infermo a Milano. Si chiamava don Ferrante
Francesco d’Avalos, marchese di Pescara ed era
il più valoroso dei capitani di Carlo V. La
gentildonna rimase talmente sconvolta dal dolore
che si ritirò nel Monastero di santa Caterina.
Vi fece più tardi ritorno e dal 1° Ottobre del
1541 vi dimorò, seppur con brevi spostamenti,
fino al Giugno del 1544. In questo periodo
frequentò il cardinale Reginald Pole, che
ricoprì, dal 12 Agosto 1541, la carica di legato
del Patrimonio di san Pietro a Viterbo, essendo
stato nominato da papa Paolo III. Il Pole si
recava volentieri di persona, nel Monastero di
santa Caterina, per far visita a Vittoria, la
quale ritornò a Viterbo, per un breve periodo,
nel 1545. Vittoria Colonna ebbe anche in questo
periodo viterbese, una intensa corrispondenza
epistolare con Michelangelo Buonarroti. Il
complesso del convento di Santa Caterina, fu
fondato nel 1520 dai domenicani per accogliere
più in là nel tempo, una comunità di monache
benedettine, fu realizzato grazie al sostegno
economico di due nobili viterbesi Nicola Bonelli
e Giambattista Cordelli. Con l’Unità d’Italia
nel 1870 la chiesa e il monastero vennero
soppressi, il complesso fu adibito prima a
Biblioteca, poi a palestra, e poi in Liceo nel
1912.Dell'antica struttura è rimasta all'interno
la ex Chiesa. Suor Maria Teresa Crescini
Lettera di Suor
Maria Teresa Crescini Maestra Pia Venerini
pubblicata on line su Etrurianews 12-11-2022 Beata Rosa Venerini Beata e Santa Rosa Venerini, nacque a Viterbo il 9 Febbraio del 1656 e morì a Roma il 7 Maggio del 1728, a lei si deve la fondazione della Congregazione delle Maestre Pie Venerini, fu beatificata nel 1952 da Papa Pio XII, e fu proclamata Santa da Papa Benedetto XVI il 15 Ottobre del 2006. Era la figlia di Da Goffredo medico di origine marchigiana che si adoperò in aiuto ai viterbesi durante la peste del 1657. La madre era Marzia Zampichetti, che apparteneva ad una delle più importanti famiglie dell’alto Lazio, che sposò essendo rimasta vedova, il Da Goffredo in seconde nozze. Rosa aveva altri 3 fratelli, Domenico che morì giovane e Maria Maddalena ed Orazio. La madre Marzia educò i figli secondo i dettami religiosi avendo la zia materna Anna Cecilia, superiora del convento di Santa Caterina a Viterbo. Rosa insieme a Porzia Baci e a Girolama Coluzzelli, istituirono una Scuola Pia, per l’educazione religiosa delle giovani più povere, e con l’appoggio del Cardinale Marcantonio Barbarigo, fondò la sua Congregazione. Questa sua opera educatrice, ben presto si estese a Roma ed in altre città del Lazio. A quell’epoca era considerato inconcepibile che delle donne sole insegnassero il catechismo che a quell’epoca era compito esclusivo dei sacerdoti ad ogni modo, grazie alla benevolenza degli ecclesiastici e di Papa Clemente XI, la sua missione si estese a Corneto, a Bagnoregio, a Montefiascone ed in altre località, dove le Maestre vennero bene accettate ed amate. Rosa Venerini, rimase a Roma a dirigere le scuole insieme alla Madre Generale Lucia Filippini. Rosa morì per un tumore al seno il 7 maggio del 1728 a Roma, e venne tumulata nella Chiesa del Gesù. Sulla lapide in latino, la scritta : qui giace Rosa Venerini maestra delle fanciulle. Nel 1752 ci fu a Roma una alluvione, la tomba venne invasa dall’acqua, ed il corpo intatto venne ritrovato e posto all’interno di un’urna di vetro e argento nella Casa Generalizia in via Belli a Roma. A Santa Rosa, gli successe nel ruolo di madre Generale, Chiara Candelari, una maestra di origine anconetana che era stata da sempre al fianco della Santa.. Le Maestre Pie Venerini hanno le loro sedi non solo in Italia, ma anche in America, Africa, Romania, Argentina e Brasile. A lei sono attribuiti dei miracoli, tra questi la guarigione nel 2005 da un gonfiore toracico inspiegabile di un bambino africano, che viveva in Uganda, il quale miracolosamente guarì, dopo le numerose preghiere e suppliche alla Santa. Un’altro precedente miracolo avvenne nel 1952, dove una maestra guarì da un grave glaucoma infiammatorio, mentre un altro portò alla guarigione di una maestra affetta da tubercolosi,la quale nel delirio invocò la Santa e al mattino si alzò completamente sanata. Istituto Maestre Pie Venerini Istituto delle maestre Pie Venerini, piazza San Carluccio, Viterbo, si trova sulla piazza San Carluccio. La scuola venne fondata nel 1705 con addossata una fontana del XIII secolo. Qui le ragazze ricevevano una buona istruzione ed in più imparavano a ricamare e a cucire. vedi per maggiori informazioni e fotografie piazza San Carluccio: Edicola Beata Rosa Venerini
Edicola Beata Rosa
Venerini Edicola Santa Rosa Venerini, Largo Santa Rosa Venerini, lugo la via Mazzini, raffigura la Santa mentre insegna ai bambini. Luigi Fantappiè Luigi Fantappié, a lui è dedicata una lapide in memoria a via Mazzini, ed una scuola a via Vetulonia, Viterbo, questo insigne scienziato, un matematico,nacque a Viterbo il 15 settembre 1901 e morì a Viterbo il 28 luglio 1956. Si laureò in matematica alla Normale Superiore di Pisa nel 1922, fu insegnante universitario fino al 1934, anno in cui si trasferì in Brasile .a San Paolo, qui fondò l'Istituto di Matematica nella locale università. Andò in Brasile non solo come membro della Missione Italiana del Dipartimento di Matematica ma anche come colui che doveva tramite accordi precedentemente presi tra Italia e Brasile, prima della sua partenza, di diffondere la cultura e l’educazione italiana fascista. Nel 1940 tornò in Italia e fu docente all'Istituto Nazionale di Alta Matematica, a Roma. Dal 1954 fu socio nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Nel 1955 fu insignito della medaglia d'oro dei Benemeriti della cultura. La sua tomba si trova a Bagnaia, frazione di Viterbo. A lui sono intitolate una via di Bagnaia e una scuola secondaria di I grado a Viterbo. Fra i suoi allievi, Giuseppe Arcidiacono, che ne ha continuato l'opera. In ambito prettamente matematico, Fantappié è ricordato soprattutto come il fondatore della teoria dei funzionali analitici,a cui si dedicò fin dagli studi universitari a Pisa. Successivamente si rivolse alle applicazioni in fisica e biologia. Nel 1942 elaborò una “teoria unitaria del mondo fisico e biologico”, dove tra l'altro introdusse il concetto di sintropia, formalmente equivalente a quello di informazione elaborato per la prima volta da Ralph Hartley nel 1928 e a quello di negentropia (o entropia negativa) proposto da Erwin Schrödinger nel 1943.La teoria unitaria proposta da Fantappié è basata sull'idea che le soluzioni progressive e regressive dell'equazione delle onde rappresentino processi entropici e "sintropici": precisamente, le soluzioni che procedono in avanti nel tempo darebbero origine ai comuni fenomeni fisici in cui l'entropia aumenta, mentre le soluzioni che procedono indietro nel tempo darebbero origine all'organizzazione in opposizione all'aumento del disordine. Il concetto di negentropia, analogalmente a quello di sintropia, è stato affrontato da alcuni scienziati russi sulle basi degli esperimenti condotti da Nikolaj Kozyrev nonché sulla sua teoria dei flussi di densità di tempo. In seguito, i suoi studi e le sue ricerche riguardarono propriamente la teoria della relatività di Albert Einstein e su alcune sue possibili ulteriori formulazioni e perfezionamenti matematici. Nel 1952 elaborò una teoria degli universi fisici basata sulla teoria dei gruppi. In questo ambito, nel 1954, con il suo scritto Su una nuova teoria di "relatività finale", Fantappié propose una possibile estensione, su scala cosmica, della relatività ristretta. Tratto da wikipedia. Scuola Luigi Fantappiè
Scuola Luigi Fantappiè Porta della Verità Porta della Verità o dell'Abate Porta della Verità o dell’Abate o San Matteo, Viterbo, chiamata anche porta dell’Abbate, La porta prende il nome dalla vicina chiesa di Santa Maria della Verità. Anticamente era chiamata porta dell'Abate per la vicinanza dell'abbazia della suddetta chiesa ed anche di porta San Matteo per la piccola chiesa dedicata a questo santo che sorgeva non molto lontano. Sulla porta campeggia un grande stemma di papa Benedetto XIII affiancato da altri due stemmi più piccoli del governatore Oddi e del vescovo Sermattei oltre allo stemma del Comune di Viterbo. In basso due stemmi del comune. Una grande epigrafe, sulla facciata, ricorda la storia della porta. L’aspetto attuale lo si deve ad una ricostruzione del 1728, sopra vi sono i merli ghibellini, che si affiancano a quelli guelfi delle mura. All’interno una lapide di marmo ricorda la sanguinosa battaglia dei garibaldini del 1867, da questa porta fino a porta Romana si vedono l’alternarsi delle torri e i vari periodi costruttivi delle mura. Altre informazioni su via Mazzini Viterbo centro storico Edicole Sacre a via Mazzini Viterbo Edicole Sacre Madonnelle - Via Mazzini Edicole sacre a via Mazzini, Viterbo, una si trova all'angolo tra via Mazzini e via dei Tignosi, una edicola è dedicata alla Beata Rosa Venerini posta alla scuola di San Giovanni chiusa nel 2022 a largo S. Rosa Venerini, di fronte a via Mazzini, una edicola è alla facciata della chiesa di San Giovanni in Zoccoli, un'altra edicola è su via Mazzini. Stemmi lapidi iscrizioni scritte a via Mazzini Viterbo Stemmi Viterbo centro - Via Mazzini Stemmi a via Mazzini, Viterbo, lungo la via alcuni stemmi e scritte sulle finestre. Come arrivare a via Mazzini Viterbo centro storico
Mappa zona Piazza della Crocetta - Mappa Salita di Santa Rosa - Mappe di Viterbo Fotografie Via Mazzini Viterbo centro storico informazioni e fotografie Via Mazzini Viterbo centro storico, info e foto Anna Zelli - Vie di Viterbo centro Via Mazzini Viterbo centro storico, info e foto Anna Zelli - Vie di Viterbo centro Via Mazzini Viterbo centro storico, info e foto Anna Zelli - Vie di Viterbo centro Via Mazzini Viterbo centro storico, info e foto Anna Zelli - Vie di Viterbo centro Chiesa San Giovanni in Zoccoli via Mazzini Viterbo Chiesa San Giovanni in Zoccoli, via Mazzini, Viterbo -Chiese di Viterbo centro Gradini di accesso alla Chiesa di San Giovanni in Zoccoli via Mazzini info e foto Gradini di accesso Chiesa S. Giovanni in Zoccoli, via Mazzini - Scalinate Viterbo centro Edicola Chiesa San Giovanni in Zoccoli via Mazzini Viterbo centro storico Edicola Chiesa San Giovanni in Zoccoli via Mazzini Viterbo - Edicole sacre a Viterbo Rosone Chiesa San Giovanni in Zoccoli via Mazzini Viterbo centro storico Rosone alla Chiesa S. Giovanni in Zoccoli, via Mazzini, info e foto Anna Zelli Chiese di Viterbo centroAbside Chiesa San Giovanni in Zoccoli via Mazzini Viterbo centro storico info e foto Abside Chiesa S. Giovanni in Zoccoli, via Mazzini, info e foto Anna Zelli Chiese di Viterbo centroAbside Chiesa S. Giov. in Zoccoli veduta da piazza Dante Viterbo Chiese di Viterbo centro Campanile a vela chiesa san Giovanni in Zoccoli da piazza Dante - Campanile a vela chiesa san Giovanni in Zoccoli da piazza Dante - Campanili di Viterbo centro Collegio San Giovanni via Mazzini Viterbo centro storico Collegio San Giovanni Via Mazzini Viterbo centro, info e foto Anna Zelli - Palazzi di Viterbo centro Edicola
raffigurante Beata Rosa Venerini Beata Rosa Venerini, Via Mazzini Largo Santa Rosa Venerini - Edicole sacre a ViterboLapide Maestre Pie Venerini largo Santa Rosa Venerini Viterbo Lapide Maestre Pie Venerini Largo Santa Rosa Venerini - Lapidi Viterbo centro Lapide alla Santa Rosa Venerini a Corso Italia Viterbo Lapide Beata Rosa Venerini a Corso Italia lapide Santa Rosa Venerini, Lapidi Viterbo centro Beata Rosa Venerini Beata Rosa Venerini - Santi vita opere storia Palazzo Pagliacci Sacchi via Mazzini Viterbo centro storico informazioni e foto Palazzo Pagliacci Sacchi, ex Cassa di Risparmio Via Mazzini Viterbo - Palazzi di Viterbo centro Banca Intesa San Paolo via Mazzini Viterbo Banca Intesa Sanpaolo via Mazzini Viterbo - Palazzi di Viterbo centro Palazzo Nini di fronte a piazza della Crocetta via Mazzini Viterbo Palazzo Nini, via Mazzini, Viterbo - Palazzi di Viterbo - Palazzi di Viterbo centro Edicola sacra tra via Mazzini e via dei Tignosi Viterbo centro storico Edicola via Mazzini - Viterbo centro, foto Anna Zelli Edicole sacre a Viterbo Edicola via Mazzini - Viterbo centro, foto Anna Zelli Edicole sacre a Viterbo Edicola sacra via Mazzini Viterbo centro storico Edicola via Mazzini - Edicole Sacre Madonnelle a Viterbo centro Stemmi Lapidi scritte iscrizioni a via Mazzini Viterbo Stemma al palazzo Pagliacci Sacchi via Mazzini Viterbo Stemma al palazzo Pagliacci Sacchi via Mazzini Viterbo - Stemmi a Viterbo Stemma palazzo via Mazzini 6 Viterbo -Stemmi a Viterbo Stemma palazzo via Mazzini 61 Viterbo - Stemmi a Viterbo Simbolo San Bernardino via Mazzini Viterbo Simbolo San Bernardino via Mazzini 105 Viterbo - Scritte a via Mazzini Viterbo Scritta palazzo via Mazzini 89 Viterbo - Scritta palazzo via Mazzini 29 Viterbo Scritta palazzo Nini via Mazzini 29 Viterbo scritta data 1874 palazzo Cassa di Risparmio di Viterbo via Mazzini Bassorilievo Mucca e Vitello via Mazzini Viterbo Bassorilievo mucca e vitello via Mazzini Viterbo Finestra decorata via Mazzini 1 Viterbo Finestra decorata via Mazzini 1 Viterbo Archi e case ponte a via Mazzini Viterbo centro storico fotografie e informazioni Archi a via Mazzini Viterbo centro storico, informazioni turistiche e foto, Anna Zelli Arco a via Mazzini Viterbo centro storico, informazioni turistiche e foto, Anna Zelli Casa ponte via Mazzini Viterbo Casa Ponte a via Mazzini Viterbo Profferlo a via Mazzini Viterbo Balcone Palazzo Cassa di Risparmio di Viterbo Lapide a Luigi Fantappiè Matematico Viterbese Lapide a Luigi Fantappiè via Mazzini Viterbo Luigi Fantappiè Matematico Viterbese Luigi Fantappiè vita opere storia a lui è dedicata la scuola a via Vetulonia Viterbo Giuseppe Mazzini a lui è dedicata la via Nasone a via Mazzini Viterbo centro storico Nasone a via Mazzini Viterbo centro storico - Fontane lavatoi nasoni Viterbo da vedere a Via Mazzini Viterbo centro storico informazioni e fotografie
Dintorni via Mazzini Viterbo
Via Mazzini Viterbo centro storico Via Mazziini Giuseppe Viterbo info e foto Anna Zelli Mappa Colle Crocetta - Mappa Salita S. Rosa - Mappa Corso Italia
Mappe di Viterbo centro storico Mappe colli vie piazze zone Viterbo Vie di Viterbo centro - Piazze Viterbo centro - Quartieri Viterbo centro storico
Viterbo centro storico - Viterbo dintorni
Viterbo guida centro storico - Viterbo dintorni
Informazioni Turistiche
città di
Viterbo monumenti di Viterbo centro storico
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Città di Viterbo |
informazioni storico turistiche e fotografie della città di Viterbo a cura di Anna Zelli |




















































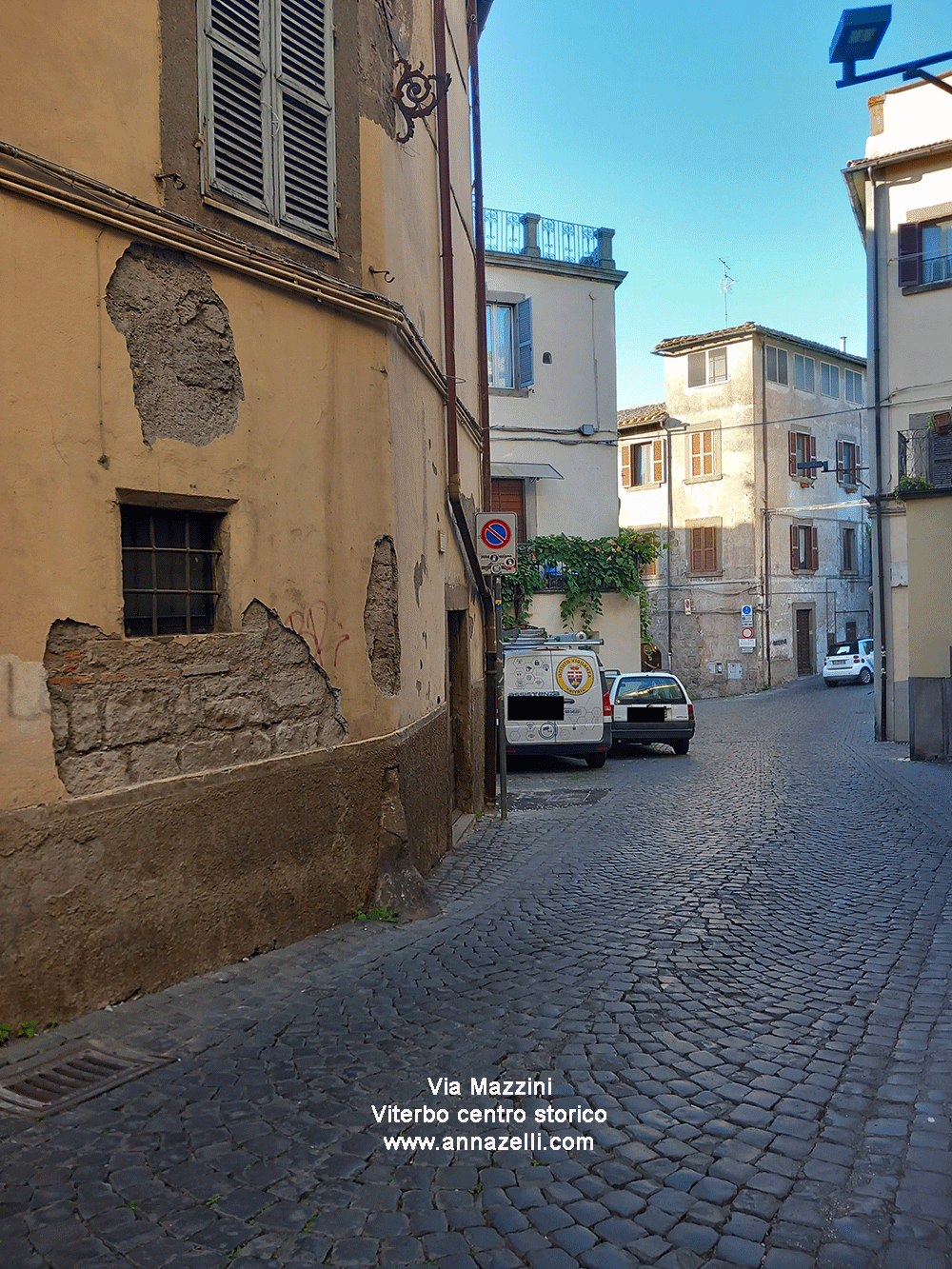







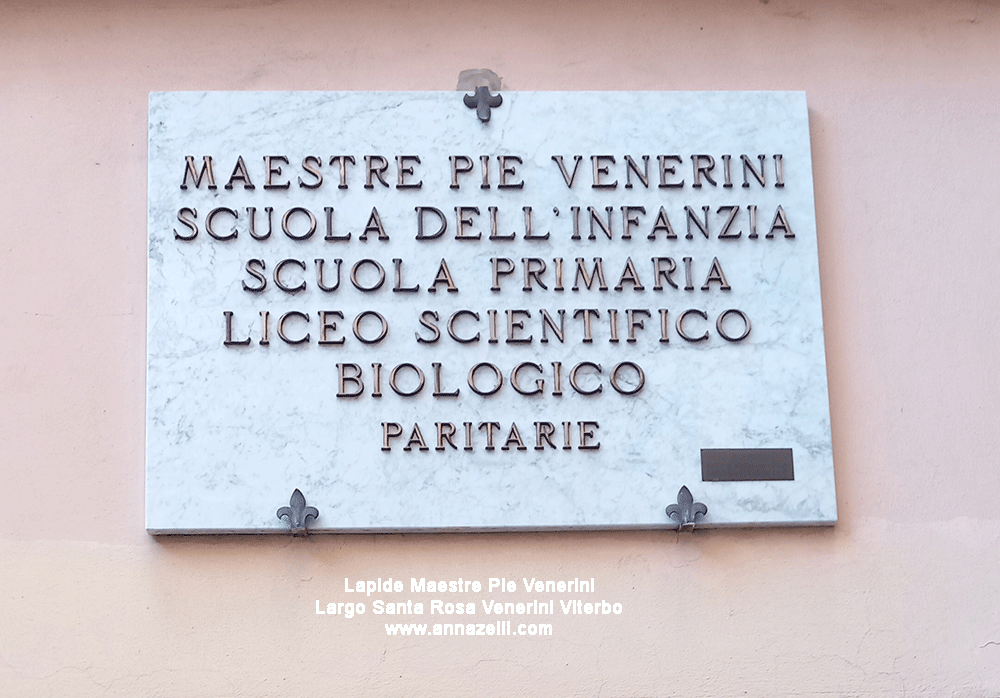

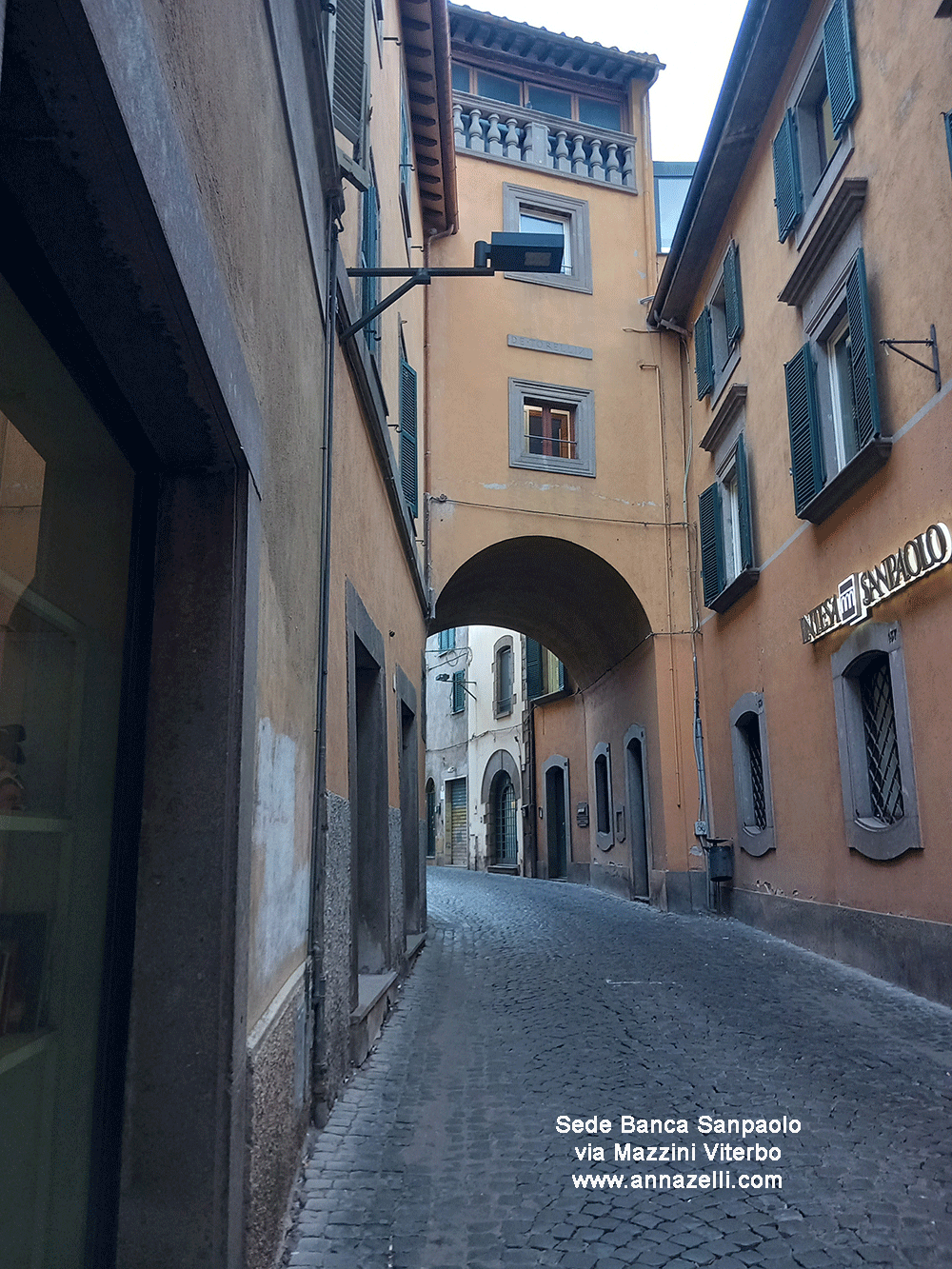




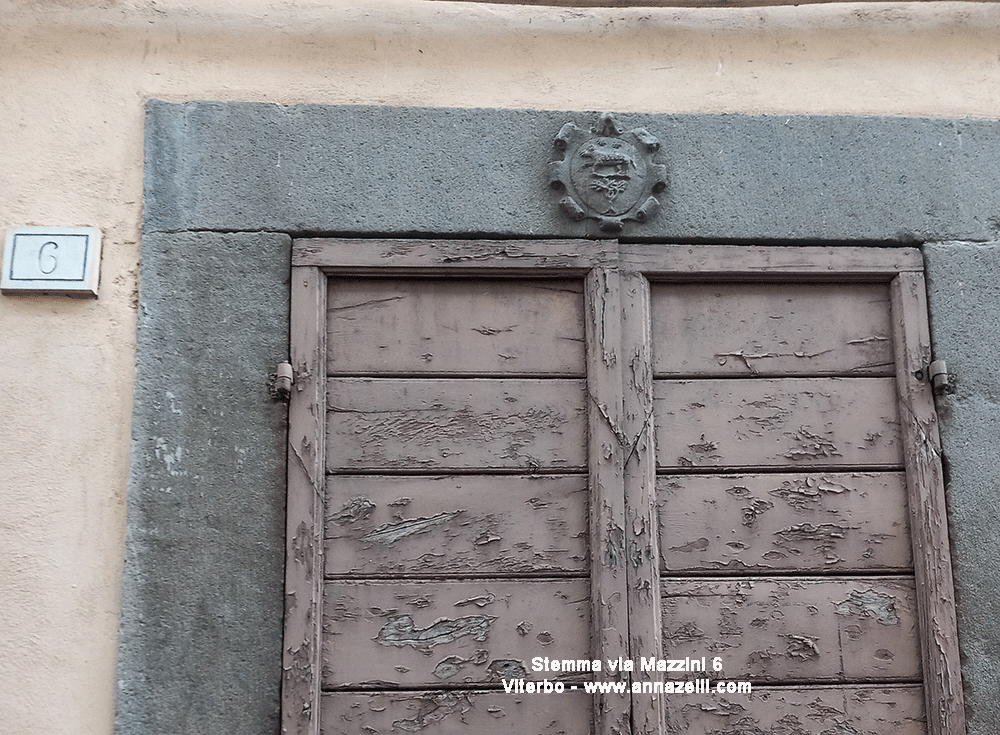




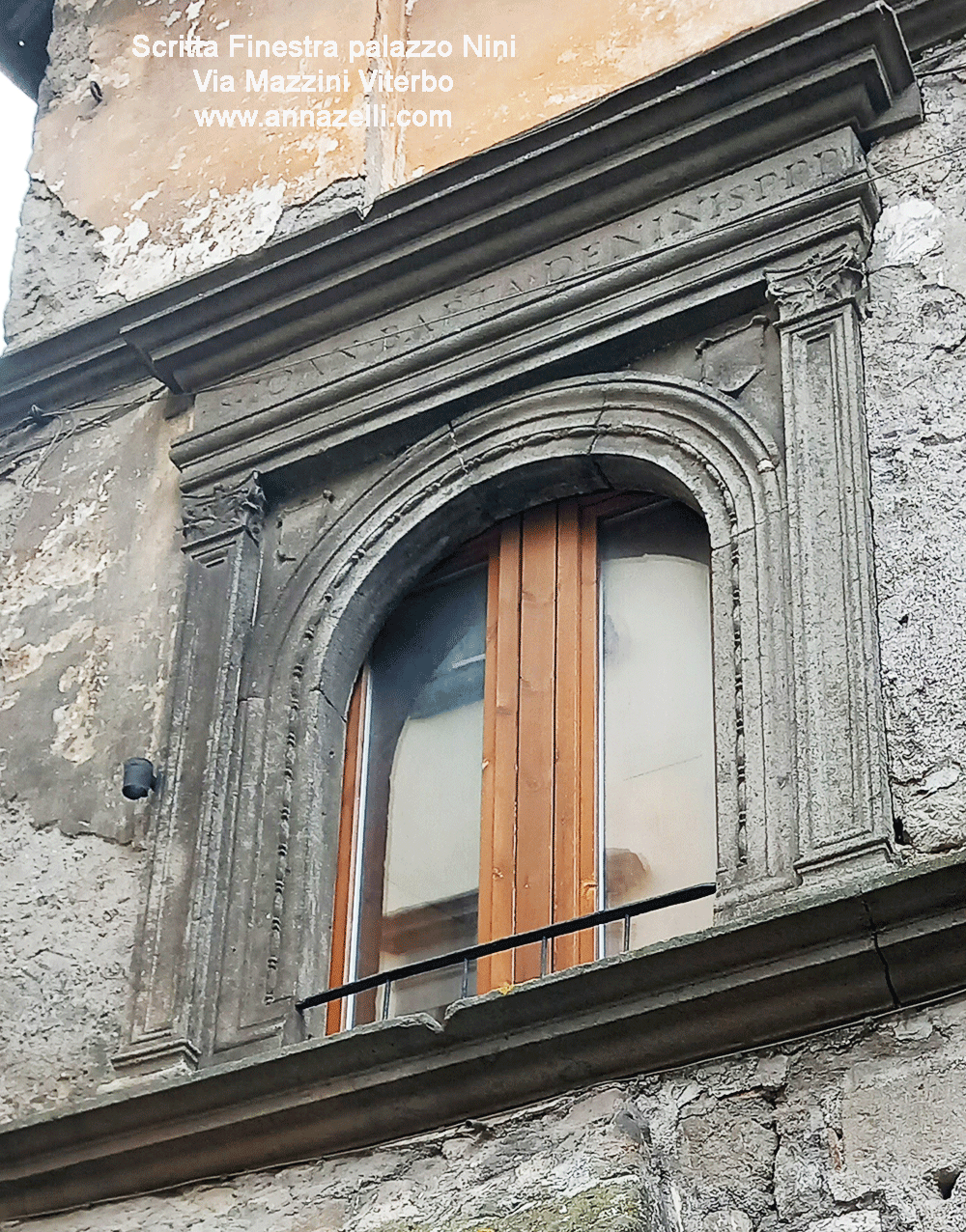


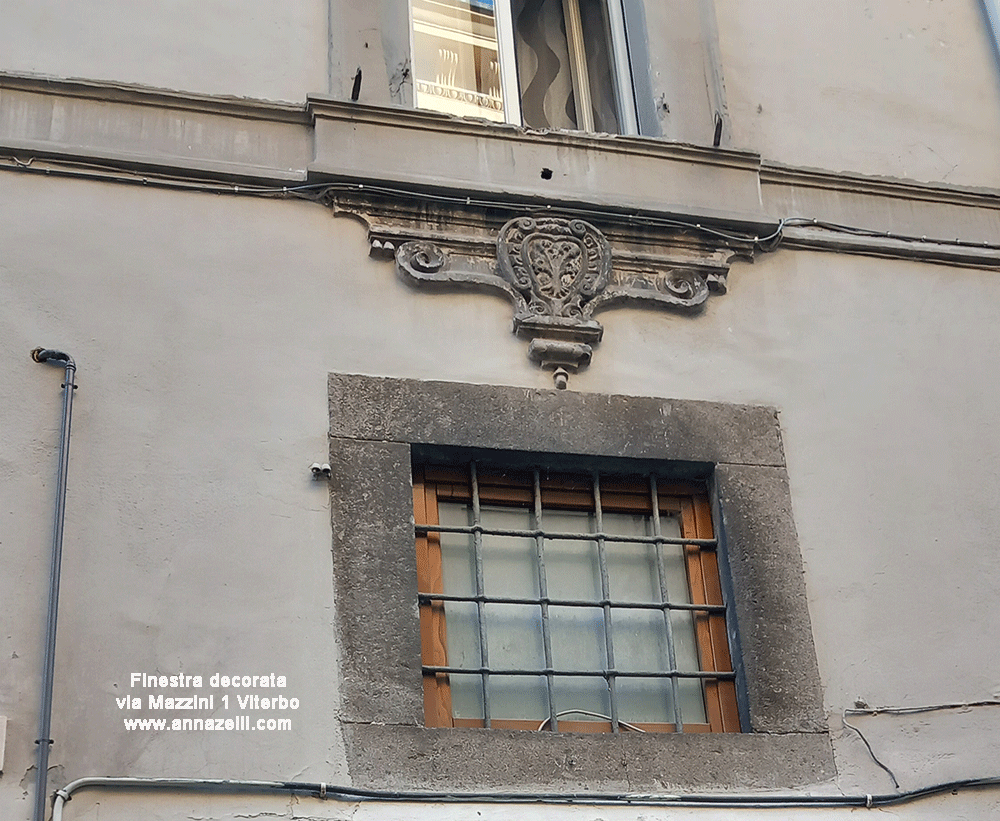
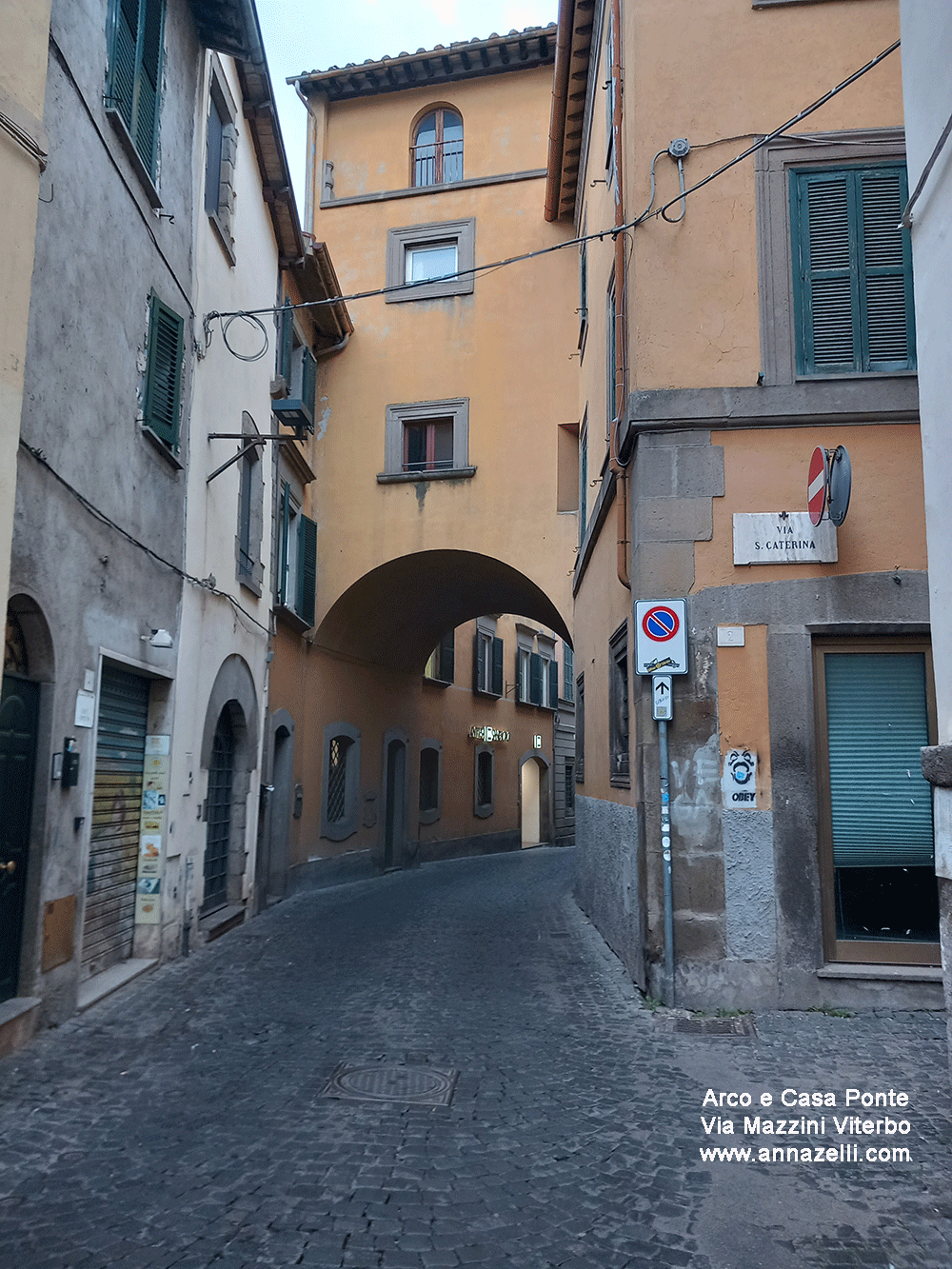

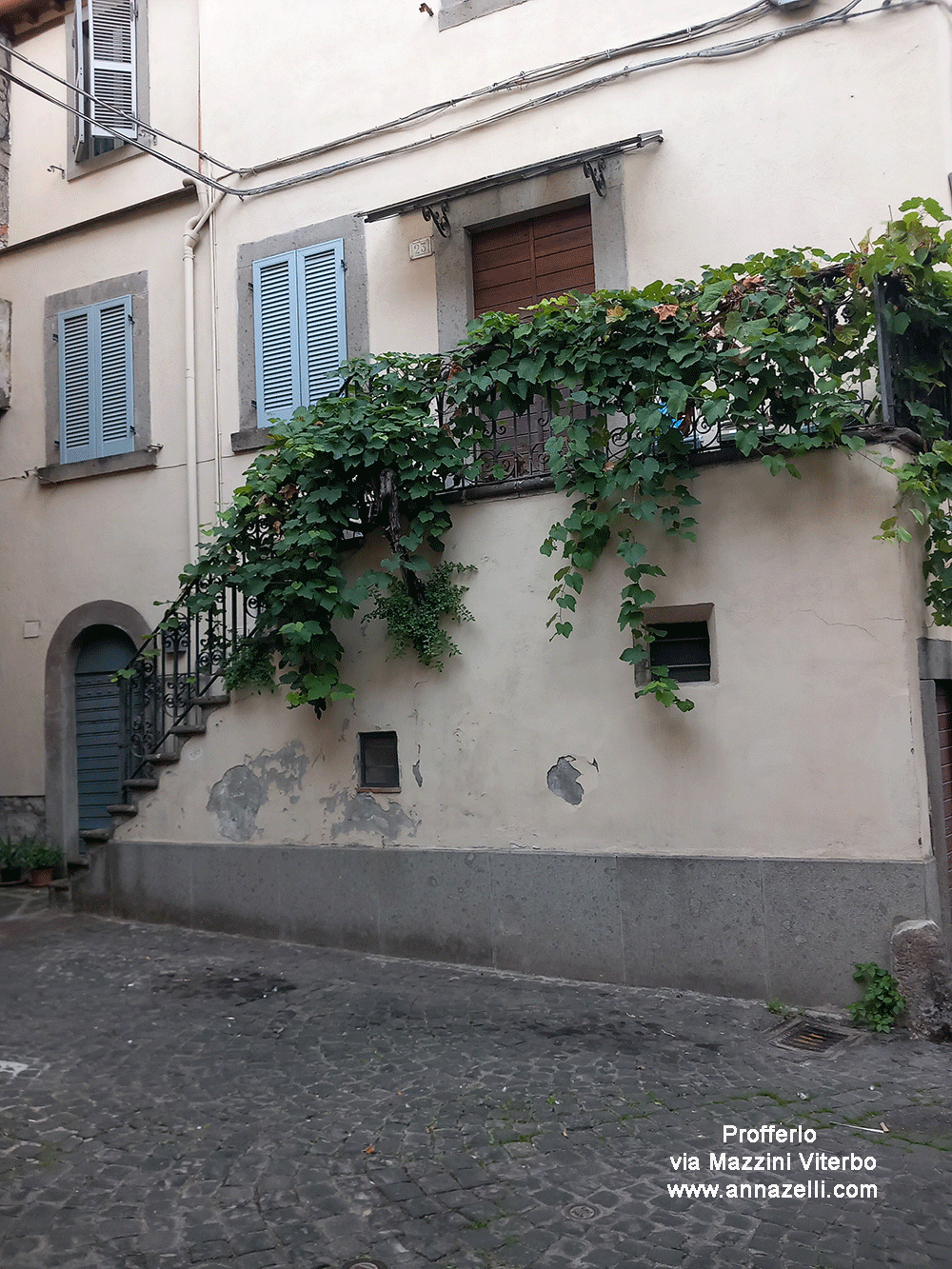
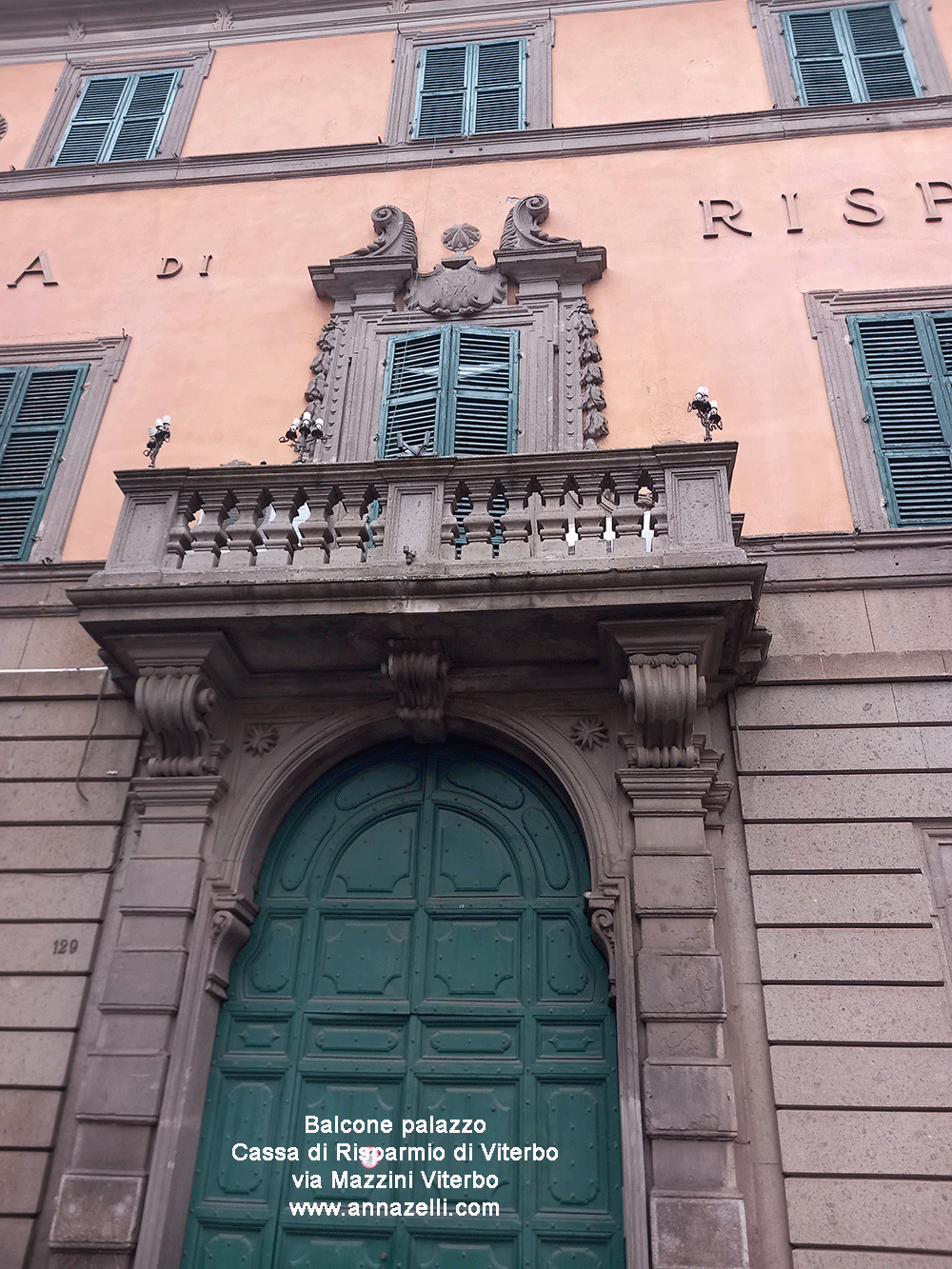













.gif)