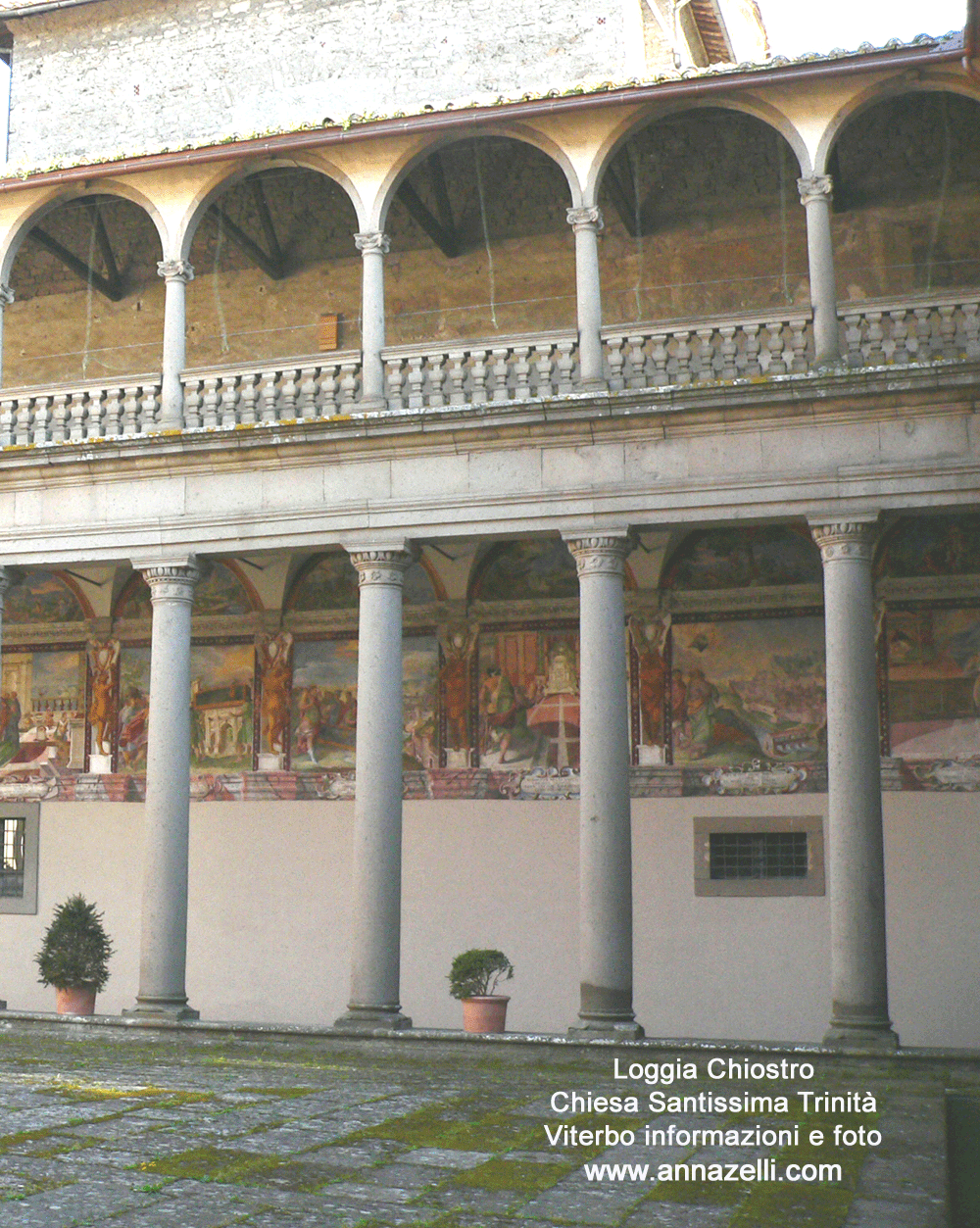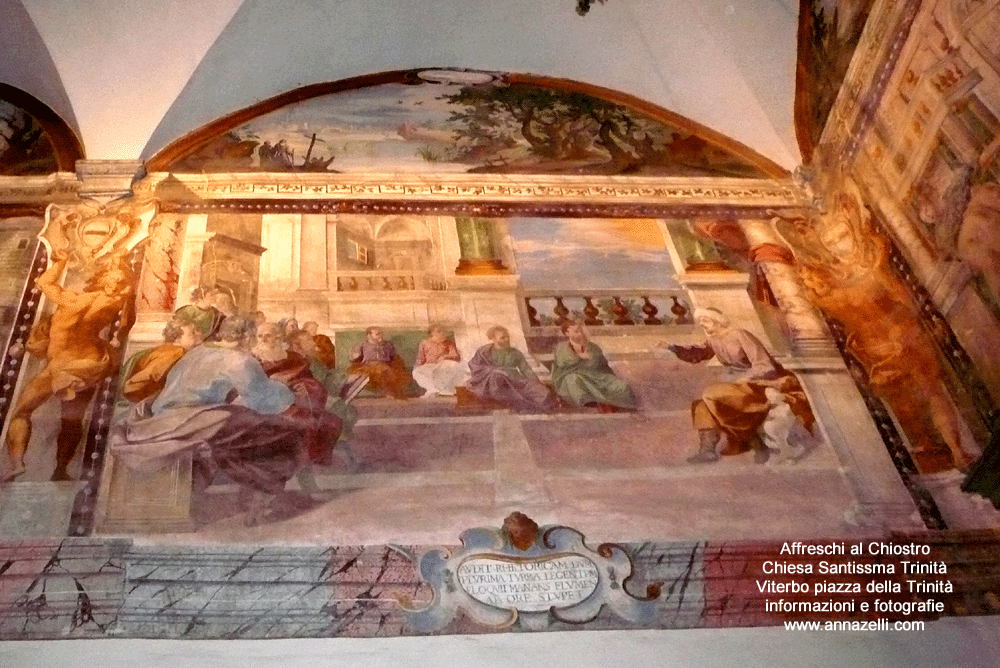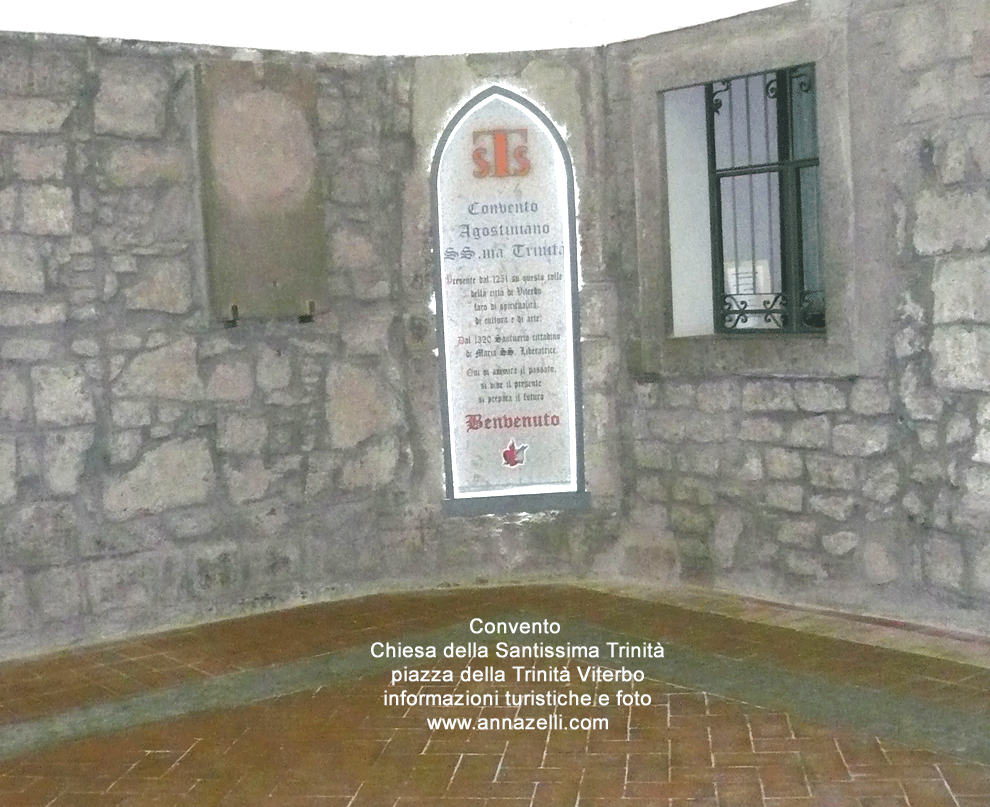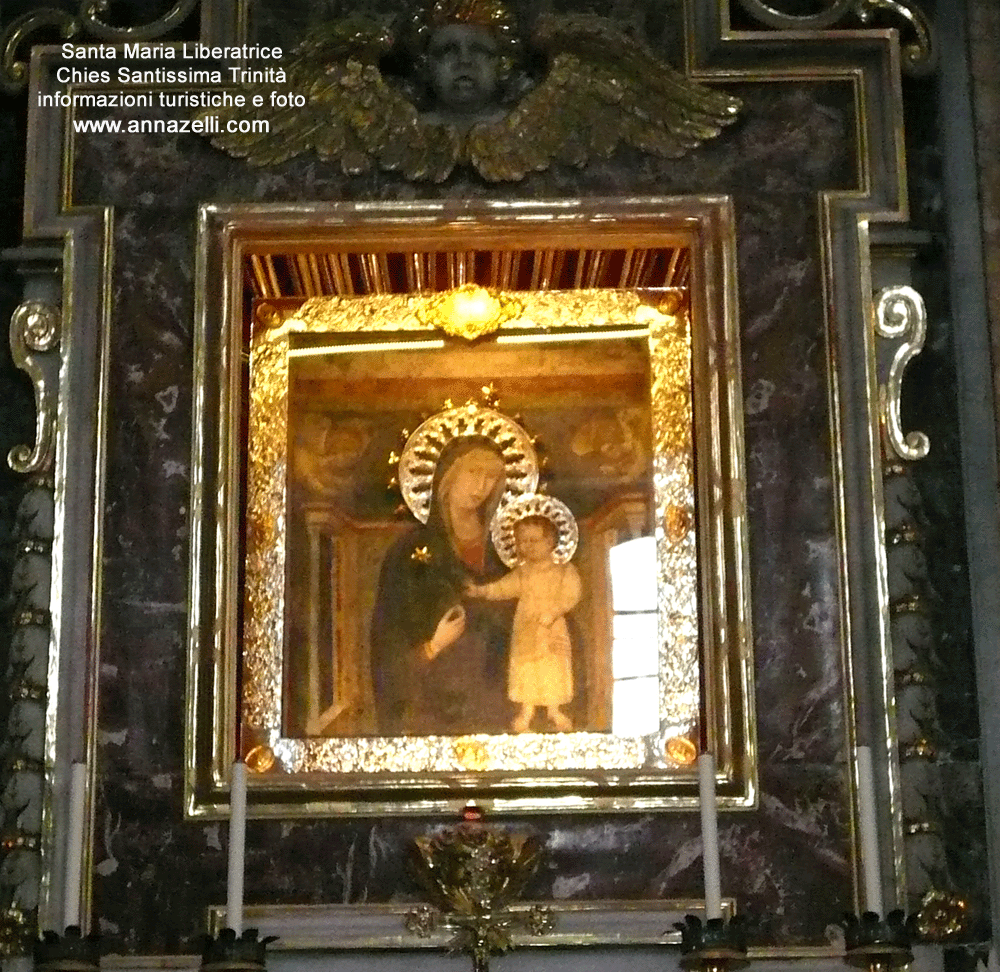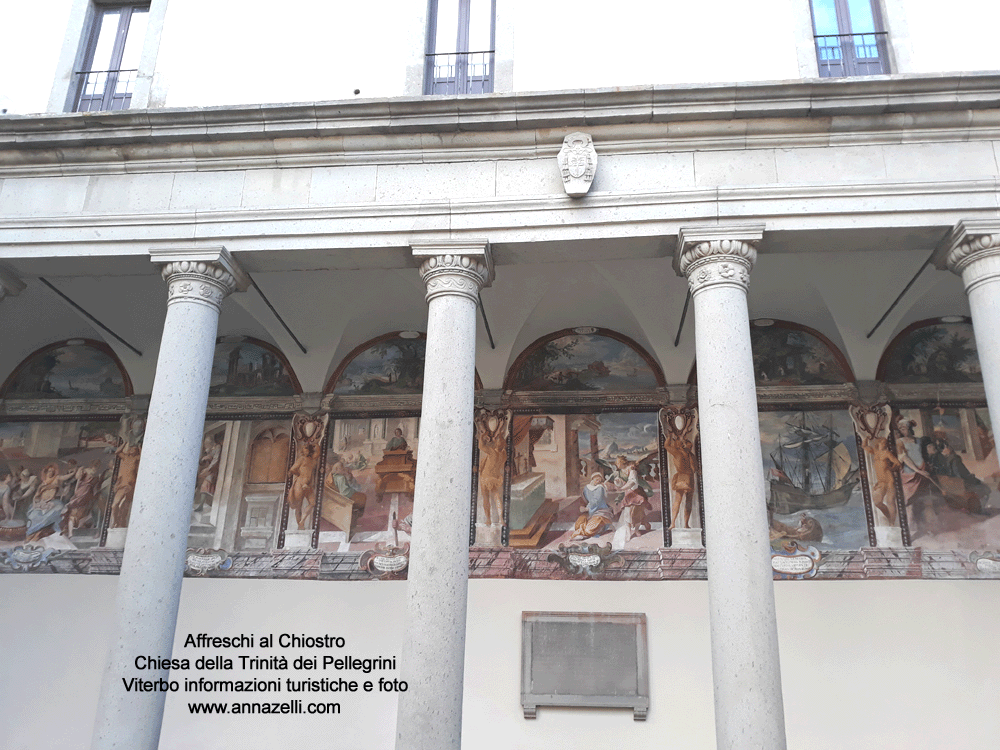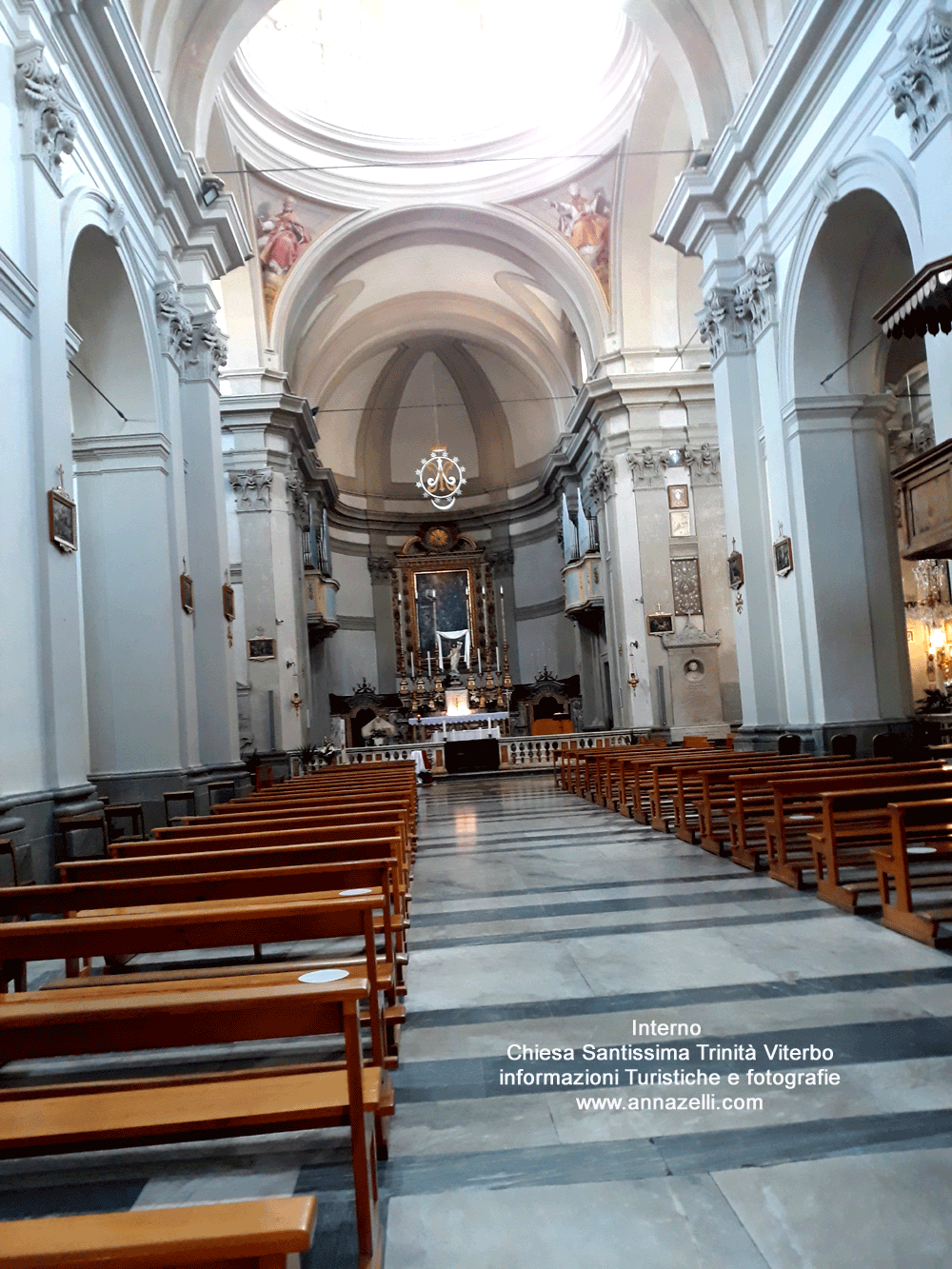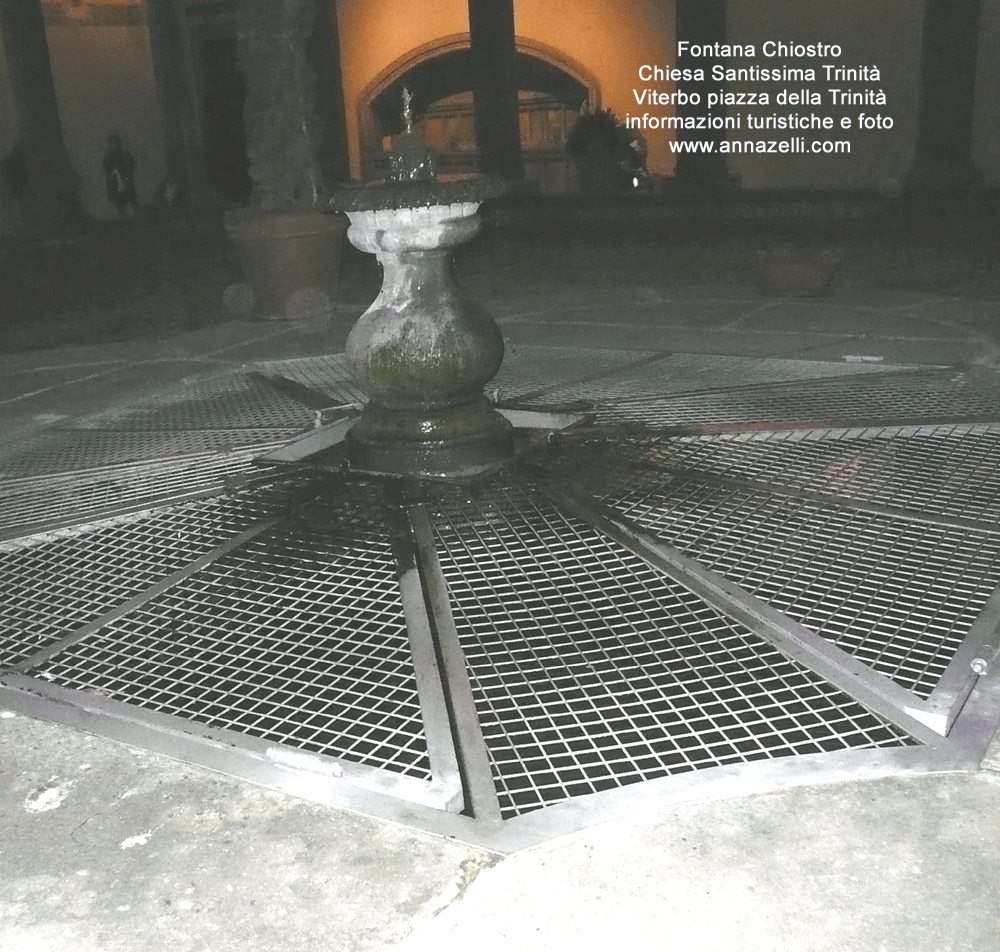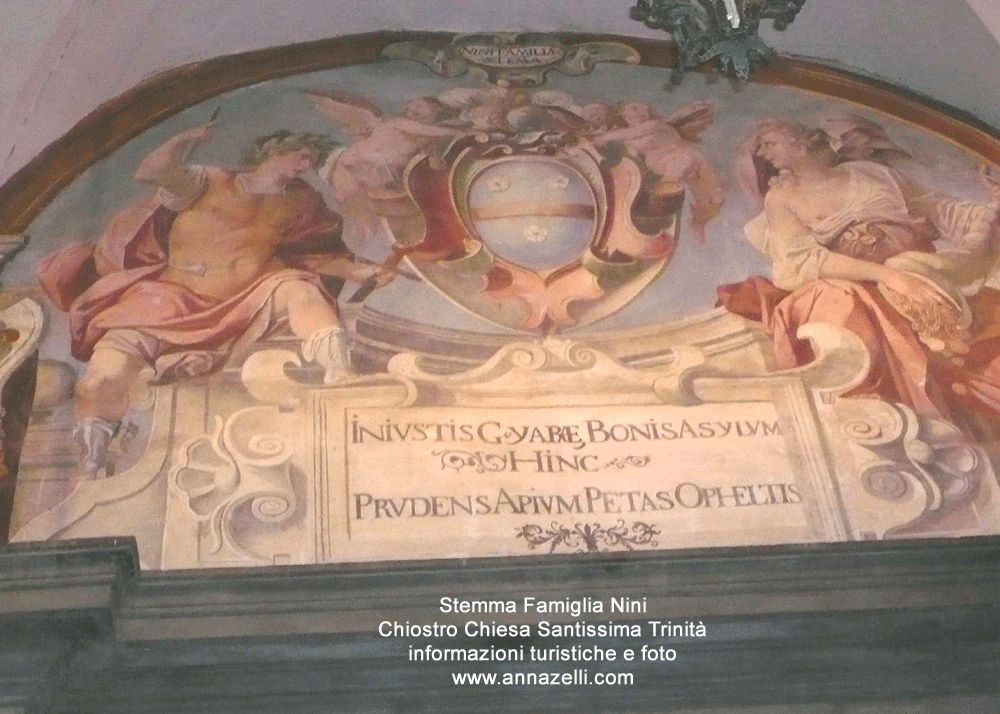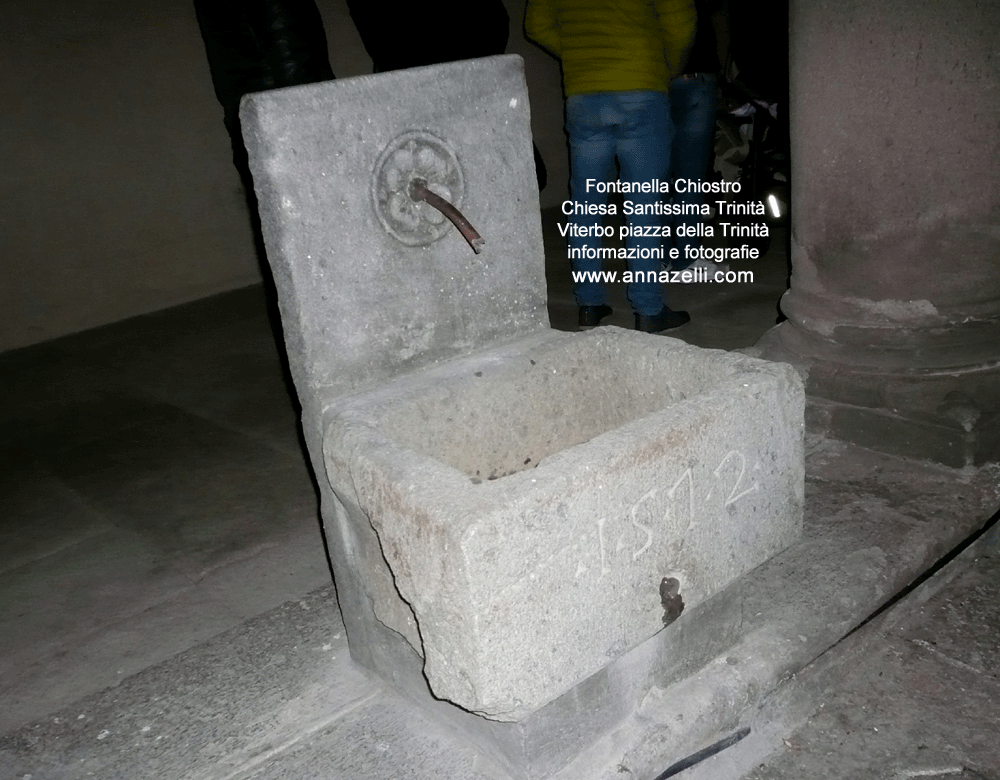|
Viterbo piazza della Trinità |
chiesa della santissima trinità dei pellegrini chiese di viterbo centro storico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CHIESA SANTISSIMA TRINITA' VITERBO CENTRO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiostro Santissima Trinità
Guida Turistica Viterbo
|
Chiesa della Santissima Trinità o Santuario di Santa Maria Liberatrice, è tra piazza della Trinità,e via San Giovanni Decollato, Viterbo, oltre la zona di piazza Martiri d’Ungheria, nei pressi di piazza Sant’Agostino, zona tra porta Fiorentina e porta Bove, fu consacrata da papa Alessandro IV nel 1258 , il nome di Santa Maria Liberatrice le deriva da una immagine sacra che è conservata all’interno, attribuita a Gregorio e Donato D’Arezzo, oggi custodita nella cappella di Sant’Anna, l’affresco è stato posto qui nel 1748. La chiesa è in stile Settecentesco e fin dalle origini è stata la sede dell’Ordine degli Agostiniani. Sia la chiesa che il convento furono edificati dai Padri Eremitani Agostiniani dell’eremo di Monterazzano e consacrati due anni più tardi. Poiché la chiesa era piccola, nel 1727 si decise di ampliarla ed il nuovo edificio venne ultimato nel 1745. Sulla facciata si mescolano elementi barocchi e neoclassici, è divisa in due livelli. Sul primo si aprono tre portali e due nicchie, nella nicchia di destra è collocata la statua di S. Tommaso di Villanova, in quella di sinistra la statua di S. Agostino. Sul secondo ordine,si vede un ampio finestrone sorretto da una balaustra in peperino, qui, altre due nicchie in corrispondenza del piano inferiore, contenenti rispettivamente la statua di Santa Rita da Cascia a destra e quella di Santa Monica a sinistra. Al centro un balcone sormontato dal simbolo della Trinità scolpito in travertino. Sul lato sinistro troviamo il campanile a pianta quadrata, coperto da una cupola, anch’essa a pianta quadrata. Sulla destra della chiesa si apre il portale che da accesso al chiostro rinascimentale. La chiesa della Trinità è meglio conosciuta dai viterbesi come santuario della Madonna Liberatrice. La chiesa primitiva risaliva al 1237. Nel 1288 durante i lavori per edificare una cappella, venne alla luce un affresco raffigurante la Vergine con Bambino, all'immagine fu dato il nome di Madonna Liberatrice in seguito ad un avvenimento miracoloso accaduto nel 1320. Riferiscono i cronisti dell'epoca che il 28 maggio di quell'anno il cielo della città si riempì di demoni e forze del male che assalirono Viterbo. Apparve la Vergine, venerata in una cappella della chiesa della Trinità, che invitò i cittadini a pregare davanti alla sua immagine. Ci fu un gran raduno di gente implorante protezione ai piedi della Madonna e avvenne il miracolo. La città fu libera e da allora, all'immagine della Vergine, fu dato il nome di Madonna Liberatrice di Viterbo. L'antica chiesa fu restaurata nel 1421 con il concorso di papa Martino V dopo che un incendio l'aveva gravemente danneggiata. Nel 1727, poiché la chiesa si era rivelata inadeguata per l'affluenza di devoti fu deciso di ricostruirla completamente. L'affresco con l'immagine della Madonna, risalente al XV secolo e facente parte di una rappresentazione probabilmente più complessa, fu collocato nella sua posizione attuale nel 1748. L'interno a croce latina è suddiviso in tre navate, l'intersezione con il transetto à sormontato da una cupola illuminata da otto oculi. Lungo ciascuna delle navate laterali si snodano 4 altari, la cappella che custodisce l'mmagine della Madonna Liberatrice è situata nel braccio destro del transetto. Nel corridoi che porta alla sacrestia è conservato quanto resta del munumento funebre del cardinal Raimondo Perrault morto a Viterbo nel 1505. L'accesso alla sacrestia è chiuso da una pregevole cancellata in ferro battuto del '400; in un locale adiacente la sacrestia è collocato un imponente lavabo del '600. Di grande bellezza ed importanza è il Chiostro, che si trova sul lato destro della chiesa. Quello attuale fu costruito nel 1513 e sostituì quello originario risalente al XIII secolo. Per la sua costruzione sono state usate 36 colonne monolitiche inizialmente destinate ad un rifacimento della chiesa, rifacimento che non fu mai fatto. Il chiostro, a pianta quadrata, presenta sul lato destro un elegante loggiato, al centro vi à una fontana incassata nella pavimentazione in peperino. In uno dei bracci, incassata in una nicchia a sesto ribassato, si può ammirare una fontana del XIII secolo. Le pareti interne del chiostro presentano affreschi eseguiti tra la fine del '500 ed il primo decennio del '600. Il ciclo pittorico consta di 44 scene illustranti la vita di S. Agostino. Nell'affresco compare spesso lo stemma della casata Nini essendo stato eseguito con un lascito di Giacomo Nisini che ne indicò anche il soggetto. Sul lato sud, sopra le storie di S. Agostino, le lunette sono affrescate con scene agresti, mentre su quello nord sono raffigurati episodi biblici. Chiesa della Santissima Trinità Interno della Chiesa della Santissima Trinità, Viterbo, è diviso in 3 navate, con 4 grandi pilastri per lato, con archi a tutto sesto, ci sono 3 grandi finestre per lato. Vi è una bella cupola illuminata da 8 oculi e decorata con i Santi, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, San Girolamo e San Gregorio, opera di Giuseppe Toeschi. Le cappelle delle navate minori sono riccamente decorate, partendo da destra: Cupola Chiesa della Trinità
Cupola Chiesa della Santissima Trinità, piazza della Trinità Viterbo, si ammira nella sua bellezza sia da valle Faul, che da via Sant'Antonio e dal cortile dei Priori. Campanile chieda della Trinità Campanile Chiesa della Santissima Trinità, piazza della Trinità, Viterbo, un bel campanile quadrangolare, visibile da via San Giovanni Decollato. Statue e stemma Chiesa Trinità Statue e stemma Chiesa della SS Trinità Statue facciata chiesta Santissima Trinità, piazza della Trinità, Viterbo, si ammirano le statue in basso a sinistra di Sant'Agostino, a destra di San Tommaso da Villanova, sopra la statua di Santa Chiara da Montefalco e la statua di Santa Rita da Cascia, sopra il timpano la testa di un leone, simbolo della città di Viterbo. Stemma facciata chiesa della Santissima Trinità, Viterbo, al centro della facciata in alto troneggia il simbolo della Trinità, un grande cerchio con al centro l'occhio di Dio circondato da angeli Stemmi porta Chiostro Trinità
Stemmi portone chiostro Stemmi alla porta del chiostro della chiesa della Santissima Trinità, Viterbo, vi sono alcuni stemmi abrasi. Loggia Chiesa della Trinità Loggia al Chiostro Chiesa della Santissima Trinità, piazza della Trinità, Viterbo, risale al 1637 con colonnine ioniche a tutto sesto. Affreschi Chiostro Trinità Chiostro Chiesa della Santissima Trinità, piazza della Trinità, Viterbo, vi si accede dalla porta che si trova alla destra della facciata, oppure dagli ambienti della sacrestia che si trova in fondo alla navata destra della chiesa. Il Chiostro era già esistente nella seconda metà del XIII secolo, epoca dell'intero complesso conventuale. In origine era caratterizzato da archetti sestiacuti poggianti su colonnine di marmo. Nel XV secolo su progetto di Pier Domenico Ricciarelli e per la richiesta del frate Egidio Antonini padre generale degli Agostiniani e futuro vescovo di Viterbo, la struttura venne ricostruita. Fu il cardinale Fazio Santoro a mettere i fondi per il completamento dell'opera. Rispetto al progetto iniziale ci furono delle varianti. Il chiostro è più alto e presenta un colonnato continuo. Il chiostro ha una struttura a pianta quadrata, si apre su un cortile interno, le colonne in peperino sono regolarmente distanziate e presentano capitelli tuscanici scolpiti a ovoli. L'insieme è decisamente armonioso. Su un lato del chiostro si apre il loggiato.risalente al 1637.Il chiostro presenta dei meravigliosi affreschi di Marzio Ganassini, romano, dipinti tra la fine del '500 ed il primo decennio del '600, dove è illustrata la vita di Sant'Agostino. La Famigli Nini finanziò il progetto, ed il suo stemma è più volte ripetuto. Vi sono 44 scene delimitate da telamoni reggistemmi, in monocromo giallo ocra con giovani dai capelli scomposti. Sopra le storie di Sant'Agostino ci sono delle lunette su un lato con scene agresti e su un altro lato con scene bibliche. E' probabile che l'intero affresco sia ispirato alle tecniche pittoriche fiamminghe da pittori che alla fine del '500 si erano recati a Roma, ad Orvieto e a Perugia. Fontanile Chiesa della Trinità
Fontanile Chiesa Fontanile al Chiostro della Santissima Trinità, Viterbo, fontanile lapideo, con quattro bocche dalle quali una volta fuoriusciva l'acqua, è istoriato con dipinti nell'all'arco e nel fondale. Convento Chiesa della Trinità Convento Chiesa della Trinità dei Pellegrini, Viterbo, piazza della Trinità, nel refettorio le pareti sono affrescate. Santa Maria Liberatrice Santa Maria Liberatrice, Chiesa della Santissima Trinità, Viterbo, piazza della Trinità, la Chiesa della Santissima Trinità venne consacrata da Papa Alessandro IV nel 1258, è anche il Santuario di Santa Maria Liberatrice ed una delle prime sedi dell’Ordine degli Agostiniani. Il legame di questa chiesa con Santa Maria Liberatrice si deve ad un evento avvenuto a maggio del 1320, riferite dai cronisti dell’epoca. Fu un avvenimento straordinario che terrorizzò gli abitanti di Viterbo e li spinse a rifugiarsi in preghiera nella chiesa della Trinità e a far voti per la loro liberazione dinanzi all’immagine della Madonna. Un testimone oculare, Giovan Giacomo Sacchi, così racconta:“Ricordo come a dì 28 maggio 1320 apparsero in Viterbo nell’aere grandissimi segni che derno terrore a tutto il populo con tenebre horribili et figure de demoni, che parea che subissasse il mondo; et apparse miraculo di una figura di Nostra Donna ne la Cappella del Campano in Santo Agustino sopra Faule et per sua gratia fommo liberati”. Anche il cronista Niccolò della Tuccia ricorda che : “Alli 23 di maggio fu il memorabile miracolo della Madonna Santissima della Trinità, che liberò Viterbo dallo mani de’ diavoli, di cui l’aria tutta era piena, e gridavano voler (s)profondare la città. Ma la Vergine misericordiosissima, che sta dipinta nella cappella di Sant’ Anna, apparve a molti eremiti e incarcerati, omini da bene, dicendoli che andasse a quella cappella tutto il popolo con luminarie, e sariano liberati. Correndo tutti della città con molta devozione, compunzione e penitenze conforme aveva comandata la Vergine pietosa, furno visibilmente veduti tutti demòni buttarsi con urli orrendissimi nel bullicame: e da tutto il popolo fu riconosciuta la similitudine della santa figura, con la quale era apparsa la Madonna. Questa fu la prima luminaria istituita in Viterbo, proseguita sempre con solennità, e imitata poi nelle altre feste notabili, come appare nella Margarita del Commune. Il fondatore di quella cappella fu messer Campana castellano di Viterbo“. In realtà piuttosto che di demoni, si trattava del Bullicame, dal quale erano fuoriuscite ceneri e gas che riempirono ed oscurarono il cielo, insieme a eventi tellurici che scossero Viterbo. I cittadini ritennero di essere stati liberati per intercessione della Madonna, e fu un avvenimento così importante che coinvolse sia le autorità ecclesiastiche che civili e quindi venne istituita una festa per commemorarlo solennemente ogni anno. A partire da questo avvenimento, Santa Maria Liberatrice è venerata e pregata come Protettrice della Città nei periodi difficili della sua storia. Sabt'Agostino Sant’Agostino, vita opere storia, Viterbo, Agostino Aurelio nacque a Tagaste piccola città della Numidia in Africa il 13 novembre 354 da una famiglia di classe media, primogenito,di piccoli proprietari terrieri, il padre Patrizio era pagano, violento e dai costumi poco morigerati, mentre la madre Monica, proveniva da una buona famiglia cristiana, ed era una donna mite e pia, oltre ad Agostino, ebbe altri due figli. Agostino non venne battezzato da piccolo, perché secondo l’usanza dell’epoca si veniva battezzati in età adulta, andò a scuola ed imparò a leggere a scrivere e a fare di conto. Il padre voleva che il figlio diventasse un retore, un maestro di lettere e di eloquenza e quindi lo mandò a studiare a Madaura, la città più importante di Tagaste. Agostino si applicò con ardore agli studi dei classici latini, e meno alla lingua greca che mai imparò a padroneggiare. Venne aiutato a proseguire gli studi da un ricco e generoso concittadino, il nobile Romaniano, e così nel 371 potè andare a studiare a Cartagine, che era la grande capitale romana d’Africa. Ben presto imparò la retorica, la dialettica, la geometria, la musica, la matematica, ma oltre all’impegno negli studi conduceva anche una vita dissoluta. Dopo nemmeno un anno si accompagnò con una ragazza che gli diede un figlio Adeodato, però non si sposò mai, nonostante la relazione si protrasse per oltre un decennio. In Agostino vi erano due anime una dedita ai piaceri della vita e l’altra che lo tormentava per lo smarrimento della fede. La madre, Monica, lo aveva educato secondo i principi del più ortodosso cristianesimo, ma la mente inquieta di Agostino vedeva la religione intollerabile nei dogmi e cercò la verità altrove. Fu in quegli anni che maturò la sua vocazione di filosofo, dopo aver letto l’Ortensio di Cicerone, il libro lo aveva particolarmente colpito, perché Cicerone affermava, che soltanto la filosofia poteva aiutare la volontà ad allontanarsi dal male e ad esercitare la virtù. Provò anche a leggere la Bibbia, ma le Sacre letture non dicevano niente alla sua mente razionale e la religione professata dalla madre gli appariva come una superstizione puerile, quindi cercò la verità nel manicheismo. Il Manicheismo era una religione orientale fondata nel III secolo d.C. da Mani, che fondeva elementi del cristianesimo e della religione di Zoroastro, suo principio fondamentale era il dualismo, cioè l’opposizione continua di due elementi egualmente divini, uno buono e uno cattivo, che dominano il mondo e anche l’animo umano. Nel 374 iniziò a seguire i Manichei, ma solo nella posizione di uditore, non andando mai oltre. Nel frattempo morì il padre Patrizio, che la madre Monica era riuscita a convertire al cristianesimo, ed allora Agostino tornò a Tagaste e cominciò a dare lezioni per guadagnarsi da vivere. Strinse amicizia con uno dei suoi allievi Alipio, amicizia che non si sciolse mai. In un primo momento venne accolto dalla madre, ma le sue idee eretiche e la sua condotta poco morale, spinsero Monica a cacciarlo di casa, che continuò a pregare affinchè il figlio si ravvedesse. Dopo di che aiutato dal suo benefattore Romaniano tornò a Cartagine, vi rimase per otto anni, avendo aperto una scuola di eloquenza, in questo periodo, pubblicò il suo primo libro, De Bello e del Convenevole, e più maturo, iniziò ad allontanarsi dal manicheismo, anche se per motivi pratici non ruppe subito definitivamente. A causa della sua inquietudine interiore, Agostino maturò l’idea di andare in Italia, che si concretizzò definitivamente perche mal sopportava i suoi studenti indisciplinati che erano soliti mettere a soqquadro la scuola e le aule. Pertanto nel 383, di notte, e di nascosto dalla madre che non voleva che partisse, si imbarcò alla volta di Roma. A Roma venne accolto da un uditore manicheo al quale era stato raccomandato dai suoi confratelli di Cartagine. Si ammalò e fu sul punto di morire. Ripresosi, cercò degli studenti, i quali sebbene più educati di quelli cartaginesi, avevano però la brutta abitudine di piantarlo senza pagarlo. Agostino iniziò anche a sentirsi a disagio perché pur essendo grato ai manichei per gli aiuti, non ne condivideva più le idee. Soprattutto perché alcuni di loro conducevano una vita disonesta. Quindi si trasferì a Milano, quando Simmaco prefetto di Roma, ricevette la richiesta di un bravo maestro di retorica per la pubblica accademia. Agostino partecipò al concorso per l’assegnazione di quel posto e lo vinse e nel 384 si trasferì a Milano, dove poco dopo lo raggiunse anche la sua donna e il figlioletto Adeodato. Anche la madre Monica e il suo fedele amico Alipio, si trasferirono a Milano, da Agostino. Giunto a Milano Agostino fece visita al vescovo Ambrogio, che lo accolse benevolmente, Agostino iniziò a partecipare alle sue omelie, che ebbero una influenza positiva e che lo spinsero ad allontanarsi definitivamente dai Manichei. Tornò ad occuparsi della ricerca della verità, lesse alcuni testi di Platone e le lettere di San Paolo e gli si aprì la convinzione dell’esistenza di un Intelletto supremo, della incarnazione del Verbo e dell’Amore di Dio, pur rimanendo ancora in conflitto con se stesso tra la carne e lo spirito. Rimandò in Africa la sua compagna e su suggerimento della madre Monica si preparò a contrarre le nozze con una fanciulla di suo pari rango. Ma in lui iniziò a maturare l’idea della castità e del distacco dal mondo, e dopo due anni nel 386 Agostino si sentì convertito. Lasciò la cattedra e con alcuni suoi fedeli compagni si ritirò a Cassiciaco, forse l’odierna Cassago in Briaza. In una villa offerta dall’amico Verecondo. Qui nella quiete campestre si dedicò allo studio delle Scritture, dei Salmi e scrisse: Contro gli Accademici, La vita Beata, Dell’Ordine e dei Soliloquii. Si preparò al battesimo che ricevette nella notte di Pasqua del 387 per mano di Sant’Ambrogio, insieme con il figlio Adeodato e l’amico Alipio. Agostino decise di lasciare l’Italia e di tornare in Africa, insieme anche alla madre. Ad Ostia mentre erano in attesa di imbarcarsi, Monica, benché felice per la conversione del figlio, si ammalò e morì. Agostino decise di rimanere a Roma, e vi rimase per un anno, durante il quale si diede da fare per convertire i manichei, a tal proposito, scrisse due libri : Sui Costumi della Chiesa Cattolica, e Sui Costumi dei Manichei. Dopo di che salpò alla volta di Cartagine, si ritirò con i suoi compagni nel podere paterno fuori Tagaste, conducendo una vita di preghiera e di studio insieme ai suoi compagni che lo consideravano come loro superiore. Qui si posero le basi della regola monastica che il Santo dettò e che prese il suo nome, e che anche oggi è seguita da numerose congregazioni. In quel tempo Adeodato, morì, figlio amato e sempre seguito amorevolmente dal padre. Negli anni successivi si dedicò all’approfondimento del dogma cristiano e ad approfondire le Sacre Scritture, durante questo periodo scrisse Sul Genesi, e altri libri come: Della Musica, Del Maestro. Nel 391 si recò a Ippona per confortare nella fede persone che desideravano convertirsi. Non tornò più a Tagaste. Venne proclamato prete per la sua fama di oratore e per la sua dottrina, Agostino si sentiva indegno di tanto onore, ma accettò perché vi vedeva un segno della volontà di Dio. Chiese al vescovo Valerio di potersi preparare al nuovo ministero, il quale gli concesse un orto poco distante dalla chiesa dove Agostino radunò i monaci e qui visse fino alla fine dei suoi giorni, Tra il 395 o il 396 venne nominato coepiscovo di Valerio e alla sua morte gli successe nella Cattedra di Ippona, che tenne per tuto il resto della sua vita. Il primo suo biografo fu Possidio vescovo di Calama e suo discepolo, che ne narrò diffusamente le virtù del Santo e le fatiche apostoliche dei 35 anni di episcopato. Le sue attività dottrinali, l'influenza delle quali era destinata a durare molto a lungo, furono molteplici: predicava frequentemente, a volte per cinque giorni consecutivi; scrisse lettere che trasmisero a tutto il mondo conosciuto la sua soluzione per i problemi dell'epoca; lasciò la sua impronta su tutti i concili africani ai quali partecipò, e lottò infaticabilmente contro tutte le eresie. Agostino operò una prima distinzione fra il male fisico del corpo e il male morale dell'anima, legato al peccato. In questo modo superò una convinzione diffusa nel periodo precedente, che concepiva la malattia e il dolore come una conseguenza e una sorta di punizione divina delle azioni umane. Agostino escluse questa possibilità poiché "Dio è Amore", e un'eventuale espiazione dei peccati si colloca in una vita ultraterrena. Dolore, fame, malattia e peccato hanno però la stessa origine metafisica, ontologica, sono mancanza di essere, nell'anima e nel corpo, così come teorizzava la filosofia classica. Il male non è concepibile da parte di Dio, mentre lo è da parte dell'uomo, che può attuarlo poiché è creato libero, "a immagine e somiglianza di Dio", come afferma la Genesi. In questo senso l'uomo può fare il male, mentre Dio no. Ciò non significa che l'uomo è più libero, o che la divinità cristiana non è onnipotente, ma che l'uomo, errando, può commettere atti che lo rendono imperfetto e infelice. Non commettere il male non è un limite, ma un segno di perfezione. Agostino, come Socrate, sostenne l'intellettualismo etico, ossia che il male si manifesta per ignoranza, ed esclude nuovamente il male dalla natura divina perché questa è onnisciente. In altre parole, Dio non può fare il male per un motivo ontologico, perché il male è mancanza di essere, mentre lui è "Essenza", che non ha nulla fuori di sé, e per uno gnoseologico-etico, per il quale chi ha la conoscenza ed è veramente libero non commette atti legati all'ignoranza del proprio bene, e che negano la propria libertà. L'uomo è libero al punto di negare la propria libertà innata, compiendo il male; la fonte dell'essere e della conoscenza sono la medesima, e da entrambe deriva l'esclusione di una deviazione etica in un essere perfetto. Lo scisma donatista fu l'ultimo episodio delle controversie montaniste e novazianiste che agitavano la Chiesa dal II secolo. Mentre l'oriente stava investigando sotto vari aspetti il problema divino e cristologico della "Parola", l'occidente, indubbiamente a causa della sua vocazione più pratica, si poneva il problema morale del peccato in tutte le sue forme. Il problema principale era la santità della Chiesa; il peccatore avrebbe potuto essere perdonato e rimanere al suo interno? In Africa la questione riguardava in particolar modo la santità della gerarchia. I vescovi di Numidia che, nel 312, avevano rifiutato di accettare come valida la consacrazione di Ceciliano alla sede di Cartagine da parte di un traditore, avevano dato il via ad uno scisma che aveva posto queste gravi questioni: i poteri gerarchici dipendono dalla dignità morale del presbitero? Come può l'indegnità dei suoi ministri essere compatibile con la santità della Chiesa? Essendo stato identificato con un movimento politico, forse con un movimento nazionale contro la dominazione romana, al tempo dell'arrivo di Agostino ad Ippona, lo scisma aveva raggiunto proporzioni immense. Comunque, al suo interno è facile scoprire una tendenza di vendetta antisociale che gli imperatori dovevano combattere con leggi severe. La setta nota come "Soldati di Cristo", e chiamata dai cattolici "Circoncellioni" ("briganti", "vagabondi"), associata agli scismatici, fu caratterizzata da fanatica distruttività, causando una severa legislazione da parte degli imperatori. La storia delle lotte di Agostino con i Donatisti è anche quella del suo cambio di opinione sull'utilizzo di misure rigide contro gli eretici. Anche la Chiesa d'Africa, dei cui concili era stato l'anima, lo seguì in questo cambio. Agostino, inizialmente, tentò di ritrovare l'unità attraverso conferenze e controversie amichevoli. Nei concili africani ispirò varie misure conciliatrici, spedì ambasciatori presso i Donatisti per invitarli a rientrare nella Chiesa o, almeno, esortarli ad inviare deputati ad una conferenza (403). I Donatisti accolsero questi inviti dapprima col silenzio, poi con insulti e infine con tale violenza che Possidio, vescovo di Calama e amico di Agostino, sfuggì alla morte per puro caso, il vescovo di Bagaïa fu lasciato ricoperto di orribili ferite e la vita del vescovo di Ippona subì vari attentati. Questa violenza dei Circoncellioni richiese una dura repressione, e Agostino, apprendendo delle molte conversioni che ne seguirono, da allora approvò l'impiego di leggi rigide, pur non volendo mai che l'eresia fosse punibile con la morte. Nonostante ciò, i vescovi erano ancora favorevoli ad una conferenza con gli scismatici e, nel 410, un editto promulgato dall'imperatore Onorio pose fine al rifiuto dei Donatisti. Nel giugno 411, alla presenza di 286 vescovi cattolici e 279 vescovi donatisti, fu organizzato a Cartagine un solenne Concilio. I portavoce dei Donatisti erano Petiliano di Costantina, Primiano di Cartagine e Emerito di Cesarea, gli oratori cattolici Aurelio di Cartagine e Agostino. Alla questione storica in discussione, il vescovo di Ippona provò l'innocenza di Ceciliano e del suo consacratore Felice, sostenendo, nel dibattito dogmatico, la tesi cattolica che la Chiesa, finché esiste sulla terra, può, senza perdere la sua santità, tollerare i peccatori al suo interno nell'interesse della loro conversione. A nome dell'imperatore il proconsole Marcellino sanzionò la vittoria dei cattolici su tutti i punti in discussione. La fine della controversia donatista coincise pressappoco con l'inizio di una nuova disputa teologica che impegnò Agostino fino alla sua morte. L'Africa, dove Pelagio e il suo discepolo Celestio si erano rifugiati dopo il sacco di Roma da parte di Alarico, era diventato il principale centro di diffusione del movimento pelagiano. Già nel 412 un concilio tenuto a Cartagine aveva condannato i Pelagiani per le loro opinioni sulla dottrina del peccato originale, ma, grazie all'attivismo di Agostino, la condanna dei Pelagiani, che avevano avuto il sopravvento in un sinodo tenuto a Diospolis in Palestina, fu reiterata dai successivi concili tenuti a Cartagine e a Milevi, e confermata da papa Innocenzo I nel 417. Un secondo periodo di attivismo pelagiano si sviluppò a Roma; papa Zosimo fu inizialmente convinto da Celestio ma, dopo essere stato convinto da Agostino, nel 418 pronunciò una solenne condanna contro i Pelagiani. In seguito la disputa fu proseguita per iscritto contro Giuliano di Eclano, che aveva assunto la guida del gruppo ed attaccava violentemente Agostino.Verso il 426 nacque il movimento dei Semipelagiani, i cui primi membri furono i monaci di Hadrumetum, in Africa, seguiti da quelli di Marsiglia guidati da Giovanni Cassiano, abate di San Vittore. Essi cercarono di mediare tra Agostino e Pelagio sostenendo che la grazia dovesse essere concessa solo a coloro che la meritano e negata agli altri. Informato delle loro opinioni da Prospero d'Aquitania, il santo scrisse il De praedestinatione sanctorum, nel quale spiegava che qualsiasi desiderio di salvezza era dovuto alla "Grazia di Dio" che, perciò, controllava completamente la nostra predestinazione. Nel 426, all'età di 72 anni, desiderando risparmiare alla sua città il tumulto di un'elezione episcopale dopo la sua morte, Agostino spinse sia il clero sia il popolo ad acclamare come suo ausiliare e successore il diacono Eraclio. In quegli anni l'Africa fu sconvolta dalla rivolta del comes Bonifacio (427); i Visigoti inviati dall'imperatrice Galla Placidia per contrastare Bonifacio e i Vandali che questi aveva chiamato in suo aiuto erano tutti Ariani e, al seguito delle truppe imperiali, entrò ad Ippona Massimino, un vescovo ariano. Agostino difese la propria fede in una conferenza pubblica (428) e con vari scritti. Essendo profondamente addolorato per la devastazione dell'Africa, lavorò per una riconciliazione tra il comes Bonifacio e l'imperatrice; la pace fu ristabilita, ma non con Genserico, il re vandalo. Bonifacio, cacciato da Cartagine, cercò rifugio a Ippona, dove molti vescovi si erano già rifugiati per cercare protezione in questa città ben fortificata, ma i Vandali l'assediarono per ben diciotto mesi. Cercando di controllare la sua angoscia, Agostino continuò a confutare Giuliano di Eclano, ma, all'inizio dell'assedio, fu colpito da una malattia fatale e, dopo tre mesi, il 28 agosto 430, morì all'età di 75 anni. Nel 718 il suo feretro, venerato per secoli a Cagliari dove era stato portato da esuli fuggiti all'invasione vandala del Nordafrica, fu fatto trasportare dalla Sardegna a Pavia, a opera del re longobardo Liutprando. Da allora le sue spoglie sono custodite nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. (una parte tratta da wikipedia) a Viterbo vi è la Chiesa della Santissima Trinità che segue l'Ordine degli Agostiniani. Ordine Agostiniani L’Ordine Agostiniano a Viterbo, storia, questo ordine si insediò a Viterbo molti secoli fa, probabilmente prima del 1236, rispondendo alla richiesta della Chiesa di fare apostolato secondo i dettami di Sant’Agostino, e pertanto i frati, si trasferirono dall’eremo di Monterazzano, dove risiedevano al colle della Trinità a Viterbo. In quei tempi il colle non era ancora protetto dalla cinta muraria, e probabilmente vi era già un piccolo oratorio. Il colle era detto delle Carbonaie ed era separato dal resto della città dalla valle Faul e dal fiume Urciorno. Il luogo era difeso da palizzate e successivamente venne munito di mura, torri e fossati. Un documento attesta che già nel 1256 i frati eremitani di Sant’Agostino erano nel luogo ove oggi c’è il convento della Chiesa della Santissima Trinità. Frà Giacomo era l’economo della comunità e a nome del convento acquistò un pezzo di terra situata fuori della porta Bove, pertanto è probabile che tra il 1251 e il 1255 i frati avessero gà aderito all’Ordo Sant’Augustini in Tuscia e che qui edificarono la primitiva chiesa che aveva il suo ingresso rivolto al colle San Lorenzo e il convento. La chiesa mantenne il suo impianto gotico originario fino al ‘700, epoca in cui venne demolita ed interamente riedificata. Da una lapide posta all’interno dell’attuale chiostro risalente al XIII secolo si attesta che la consacrazione di questa chiesa avvenne nel 1258 con la benedizione di Papa Alessandro IV,che allora risiedeva a Viterbo, cui presenziarono anche vescovi e cardinali. I fedeli ebbero un periodo di indulgenze elargite dal Papa se si fossero recati a visitare la chiesa e avessero dato elemosine. Il periodo in cui i frati edificarono il convento e la chiesa al colle della Trinità, fu lo stesso durante il quale venne anche edificato il palazzo Papale sul colle San Lorenzo, opposto, dal momento che , anche i Papi si erano trasferiti da Roma a Viterbo. Vi fu un periodo di grande fermento, si edificò una nuova cinta muraria che inglobò anche il colle della Trinità. I frati godettero dei favori della curia papale e nel 1277 si svolse per la prima volta a Viterbo uno dei Capitoli Generali dell’Ordine Agostiniano. Nel 1277 alla morte di Papa Giovanni XXI, arrivarono a Viterbo Cardinali e prelati per partecipare al conclave per la elezione del nuovo Papa, alla fine del 1277 venne eletto Papa Nicolò III. Il covento e la chiesa della Trinità divenenro uno dei più importanti della Provincia Romana. Il Capitolo di Centocelle nel 1290 stabilì che nel convento si conservassero tutte le lettere papali pertinenti alla Provincia Romana, diventando quindi la sede dell’Archivio provinciale che poi, si arricchì di una importante biblioteca. Regola di Sant’Agostino, L’Ordine di Sant’Agostino, nei suoi rami maschile e femminile, Agostiniani e Agostiniane, è sorto in Italia agli inizi del secolo XIII, a partire dall’unione, promossa dalla Sede Apostolica, di varie espressioni di vita eremitica che seguivano la Regola di S. Agostino. L’unione delle congregazioni eremitiche avvenne a Roma, nella Basilica di Santa Maria del Popolo, da qui il termine “la Grande Unione” che designa quell’evento, e fu confermata dal papa Alessandro IV con la bolla Licet Ecclesiae Catholicae del 9 aprile 1256. Il nuovo Ordine, in pochi decenni, si diffuse in Italia, con un migliaio di presenze dal 1256 ad oggi, sia in Italia che in tutti i paese europei, diventando, insieme ai Francescani e ai Domenicani, una delle maggiori forze motrici di una grande riforma della Chiesa, della cultura e della società europee.
Prologo Bibliografia: S. Agostino, La regola, Nuova Biblioteca Agostiniana – Città Nuova., Luc Verheijen, La regola di S. Agostino, 2 voll. Ed. Augustinus. Torre Bove Giardino della Trinità
Torre Bove giardino Trinità Porta Bove Porta e Torre Bove, o anche porta Bonaventura, chiusa, oltre ad essere una porta è anche una torre, Viterbo, si trova alle spalle del complesso della Chiesa della Santissima Trinità, è inserita all'intero delle mura di Viterbo e dentro il giardino della Chiesa e pertanto non è visitabile, si trova su un piano più alto rispetto al piano stradale. Un tempo questa porta era aperta e consentiva di andare verso la zona del Riello, poi per la perdita di importanza venne chiusa, essendo la strada ridotta ad un viottolo di campagna. Alcuni storici collocano la costruzione di questa porta al 1215, facendone derivare il nome dal senatore di Roma Bavone, che in quell'anno era il podestà di Viterbo, mentre per il Bussi la torre viene datata al 1255 e fa riferimento alla famiglia Bonaventura che ebbero incarichi di podestà , anche lo storico Orioli sposa la tesi del Bussi, e spiega che il nome BO.VE deriva da Bonaventura. Mentre per lo Scriattoli, storico del '900, indica il 1215 come la data di costruzione della Torre e giustifica gli stemmi che qui sono presenti dei Papareschi, come coloro che fecero eseguire i lavori di sistemazione e rifinitura della torre stessa. Nel 1215, riferisce lo storico Della Tuccia, che furono anche erette le mura che da porta Bove arrivavano al piano di San Faustino e alla Porticella. All'interno di questa porta, parzialmente interrato, sopra l'arco, vi è una cuspide con scolpiti i nomi dei Papareschi di Roma, e in questo caso del Cardinale Bonaventura che era un discendente di Papa Innocenzo II, e che fu podestà di Viterbo tra il 1255 e il 1256. Vi è anche una lapide in latino che tradotta : "quando fu il 50 e poi il 5 dopo il 1200, il proconsole Bonaventura, nobile dell'Urbe, bella mi fece ed anche più grande, il nome augurale accompagna l'opera, per questo vuole che mi chiami Bonaventura. Colui che mi costruì ed il podestà che mi adornò, possa egli vivere in eterno con la gente che abita Viterbo". Fu come già detto sopra chiamata anche Bove, Bovo, o Bovone, sembra in riferimento ad Oddone di Bovo, un romano, che fu anche lui podestà di Viterbo nel 1215 anno della costruzione della porta, mentre il Bonaventura fu colui che la restaurò, decorandola ed inserendo il suo stemma, quello dei Papareschi, che circondano la lapide. Sopra la torre, in alto, ci sono altri stemmi due per ogni fianco. Vi è anche un'altra lapide inserita nella cinta muraria che tradotta dice . "Nell'anno 1290 il podestà Rinaldo al pari di Ettore, valente soldato che la palatina stirpe dei Brumfort vanta, fece fondare queste mura di Viterbo, costruite nel nome del verbo, altre mura edificare ed altre per uguale ragione riparare. Le sue onorate armi, insegne da Re, sono qui sottoposte agli stemmi del Sommo Pontefice. Dunque, lettore, circondata da salde mura, sono io città di Viterbo. mi accompagna la protezione del Verbo, decisa a seguire le sorti del Papa Niccolò IV. " Prospero fece scrivere questa lapide, e scrisse anche i versi della lapide di Porta Sonsa. Forse era uno che nel 1301. fu uno dei personaggi degli Otto del Popolo della Comunità di Viterbo. Nel 1354, la torre venne occupata dalle milizie vaticane ad opera del viterbese Giovanni Moscio. Nel 1404 i residenti di San Faustino si riunirono per la concessione dei terreni prossimi a Porta Bove ai frati Agostiniani e al Convento della Santissima Trinità. Nel 1457 Giacomo Almadiani e Nofrio edificarono una torricella restaurarono la torre Bove ed edificarono i merli. La porta è chiusa.(anno 2021) Via San Giovanni Decollato Via San Giovanni Decollato, Viterbo, centro storico, la via venendo da piazza della Trinità da una parte conduce fino a via Faul che costeggia la grande vallata oggi adibita a parcheggio e a porta Faul, prima di arrivare alla valle Faul, a sinistra si incrocia la via di Ser Monaldo via questa che incrocia la via del Lazzaretto e porta alla ex Chiesa di San Giovanni Decollato.Prendendo la via San Giovanni Decollato, da piazza della Trinità, a destra si fiancheggia la chiesa della Santissima Trinità, da qui si ammira il campanile quadrangolare sul quale vi è un coro di campane. A destra, al civico 1, si può osservare dall'esterno l'abside della Chiesa della Trinità, e l'entrata al Convento degli Agostiniani, in fondo c'è un arco che immette ad un cortile che arriva fino alle mura della città, e che degradano fino a Porta Bove, la cui apertura è interna e chiusa dal perimetro delle mura del convento. Su una piccola altura adiacente al cortile del convento, nel 1720 venne rinvenuto il perimetro della villa romana di Tullio Varrone, Console e Pretore dell'Etruria, qui si ammirano, 6 stanze disposte in un unico piano, intatta la pavimentazione con mosaici di figure animali e vegetali, ed una testa sulla cui fronte volteggiano dei serpenti. Dal portale n° 3 a destra si accedeva alla Chiesa e Monastero di Val Verde, andati distrutti, e che furono edificati nel 1267 e concessi da Papa Niccolò IV nel 1291 al Monastero di Sassovivo, abitato da monaci dotti e combattivi, ai quali il Comune concesse un'area per costruire il nuovo Cenobio, affidando loro la custodia del futuro fortilizio che prese il nome di Torre Sassovivo, sulla quale si vede lo stemma crociato dell'Ordine. Nel 1774 vi si adunava la Congregazione per il suffragio delle Anime. Proseguendo la strada, si cammina tra due rupi di tufo incassate, che era un Camminamento degli Etruschi. che conduceva la Bosco Sacro di Voltumna. A sinistra su un piano elevato si trova la Ex Chiesa di Santa Maria della Ginestra, sconsacrata, nominata dallo storico Niccolò della Tuccia, nel 1243, appartenente al Monastero di Farfa in Sabina. Poi nel 1531, qui si insediò la sede dell'Ospedale della Misericordia gestito dal 1553 dalla Confraternita della Pietà, con il titolo di San Giovanni Decollato, i monaci erano vestiti con un saio nero per preparare ad una buona morte i condannati alla pena capitale, la cui esecuzione si svolgeva davanti alla Rocca del Papa o per impiccagione o per decapitazione. Proseguendo lungo la via di San Giovanni Decollato, si ammira il lato settentrionale del Palazzo Papale che mostra la sua invulnerabilità con il mastodontico fortilizio. Piazza della Trinità Piazza della Trinità, Viterbo, centro storico, prende in nome dalla chiesa della Santissima Trinità, la piazza va da via San Giovanni Decollato che porta a valle Faul, a via Santa Maria Liberatrice,a piazza Sant'Agostino, e qui incrocia la via Santa Maria in Volturno. Da vedere la Chiesa della Santissima Trinità, l'interno della chiesa e il Chiostro tutto affrescato con la vita di Sant'Agostino. Sulla piazza da notare una madonnella, edicola sacra in ceramica, raffigurante la Madonna con Bambino. Chiesa della Santissima Trinità Santuario Santa Maria Liberatrice piazza della Trinità Viterbo Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Chiesa Santissima Trinità Santuario Santa Maria Liberatrice piazza della Trinità Viterbo Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Santa Maria Liberatrice Chiesa della Santissima Trinità Viterbo Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Sant'Agostino vita opere storia Sant'Agostino, vita opere storia, informazioni e fotografie Anna Zelli Ordine degli Agostiniani a Viterbo
Statue alla Facciata della Chiesa della Santissima Trinità Viterbo Statue Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Statue alla Facciata della Chiesa della Santissima Trinità Viterbo Statue Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Stemma simbolo della Trinità Occhio di Dio Chiesa della Santissima Trinità Viterbo Simbolo della Trinità, Chiesa della Trinità, Viterbo, informazioni e foto Anna Zelli Cupola della Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini piazza della Trinità Viterbo Cupola Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Campanile Chiesa della Trinità piazza della Trinità Viterbo Campanile Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, info foto Anna Zelli Campanile Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, info foto Anna Zelli Stemmi al portone chiostro chiesa Santissima Trinità Viterbo Stemmi portone chiostro Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo Leone simbolo di Viterbo alla Facciata della Chiesa della Santissima Trinità Viterbo Leone simbolo di Viterbo Chiesa Santissima Trinità Viterbo info e foto Anna Zelli Stemma ingresso giardino chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrino Stemma ingresso giardino chiesa della Trinità dei Pellegrini Viterbo Chiostro Chiesa Santissima Trinità dei Pellegrini piazza della Trinità Viterbo Chiostro Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Chiostro Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Loggia al Chiostro Chiesa della Trinità dei Pellegrini piazza della Trinità Viterbo Loggia Chiostro Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo Affreschi al chiostro della Chiesa della Santissima Trinità Viterbo Chiostro Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, info foto Anna Zelli Stemmi e Lapidi al Chiostro della Chiesa della Trinità dei Pellegrini Viterbo Stemmi e Lapidi al Chiostro SS Trinità - Piazza della Trinità info e foto Anna ZelliConvento Chiesa della Trinità dei Pellegrini Convento Chiesa Santissima Trinità, Viterbo, informazioni turistiche e foto Anna ZelliInterno Chiesa della Santissima Trinità Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Chiesa della Santissima Trinità piazza della Trinità Viterbo, informazioni foto Anna Zelli Edicola Sacra Madonna con bambino ingresso giardino Chiesa della Trinità dei Pellegrini Edicola Sacra Chiesa Trinità dei Pellegrini Viterbo Edicole sacre a Viterbo Edicola sacra al convento della Chiesa della SS Trinità Viterbo Edicola Sacra Convento Trinità Porta Bove o anche Porta di San Bonaventura Porta Bove, o anche di San Bonaventura, Viterbo centro storico al giardino della Trinità Via San Giovanni Decollato Piazza della Trinità Viterbo Da vedere alla Chiesa Santissima Trinità piazza della Trinità e dintorni Viterbo
Mappa Trinità - Mappa San Faustino - Mappa San Francesco - Mappa Sacrario
Colle Trinità - Faustino - S. Francesco - Rocca - Sacrario - Valle Faul
Piazza della Trinità Viterbo Piazza della Trinità ViterboChiese di Viterbo centro informazioni e foto a cura di Anna Zelli Vie di Viterbo centro - Piazze Viterbo centro - Quartieri Viterbo centro storico
Viterbo centro storico - Viterbo dintorni
Viterbo guida centro storico - Viterbo dintorni Copyright dal 2011
Tutte le foto
ed i contenuti del presente sito web
sono di Anna Zelli,sono di
Informazioni Turistiche
città di
Viterbo monumenti di Viterbo centro storico Viterbo centro storico - Viterbo dintorni 
Viterbo guida centro storico - Viterbo dintorni
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Città di Viterbo |
Informazioni storiche turistiche e fotografie della città di viterbo a cura di anna zelli |